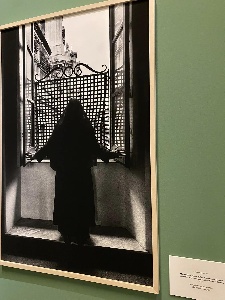Ho scritto un centinaio tra articoli, novelle e romanzi, eppure il mio nome non lo conosce nessuno. Di tutte le mie emozioni, i miei sforzi, il mio impegno, le mie aspirazioni non è rimasto nulla. E’ come se fossi stata inghiottita dalla storia. Ma io non mi rassegno all’idea di aver sprecato le mie energie. Lotterò, come ho sempre fatto, per riscattarmi, per conquistare lo spazio che mi spetta nella letteratura italiana. A questo punto, non resta che presentarmi: sono Beatrice Speraz, in arte Bruno Sperani, nata a Spalato il 24 luglio del 1839 (1) e morta a Milano il 2 dicembre del 1923.
Spalato è in Dalmazia, nell’attuale Croazia. Mia madre era istriana (2), mio padre slavo (3). Caro, dolce papà. Era alto e magro, troppo esile per la sua statura, con i capelli castani e gli occhi chiari, il tipo della razza slava, la razza odiata in Istria. “Mia figlia non avrebbe mai dovuto sposare quel barbaro”, ripeteva mia nonna materna, nobildonna di provincia decaduta. (4). Odiavo sentire parlare male di mio padre, era la bontà fatta persona e io lo difendevo ogni volta che potevo. Col risultato che per la famiglia di mia madre, sono sempre stata la figlia del barbaro, oppure la montenegrina, perché dalla Dalmazia al Montenegro il passaggio è breve. In casa, si parlava solo italiano, la lingua di mia madre. Invece, nella casa vicina più grande, la casa dei nonni, si parlava più spesso un’altra lingua, che doveva essere l’illirico. E quasi tutto il villaggio parlava così, anche
il babbo quando era con i suoi. Io, invece, di quella lingua non capivo niente. Papà non me l’aveva insegnata per non dare un dispiacere alla mamma. Papà adorava la mamma. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. Non dimenticherò mai il giorno in cui andammo al matrimonio di una parente di papa vicino Spalato. La mamma era così bella che sembrava lei la regina della festa. Fasciata in un abito celeste con una striscia dello stesso colore nei capelli corvini, ballava senza sosta sotto gli sguardi ammirati degli invitati. Non so se papà fosse geloso, di sicuro non si mosse mai dalla sedia tenendo gli occhi fissi su di lei (5).
Adoro Milano. Ci ho vissuto per quasi cinquant’anni. Sono arrivata qui nel 1876 con il cuore colmo di speranza. Ricordo come se fosse ieri l’emozione che provai appena scesa dalla carrozza mentre, con passi lenti e incerti, mi avviavo verso l’uscita della stazione. Che cosa avrei fatto?
Ero sola in una città che non conoscevo e che mi appariva piena di insidie. E se mi fossi smarrita? E se fossi stata derubata? E se qualcuno avesse tentato di farmi del male? E se….? Ero così frastornata che quasi urlai quando un signore che correva verso i binari mi urtò involontariamente.
Lo scossone ricevuto fu come una folgorazione: di colpo, la paura svanì lasciando il posto allo stupore e all’eccitazione nel guardare le luci, il viavai della gente, le carrozze, i cavalli, i facchini. Mi incamminai decisa verso Corso di Porta Vittoria 53, nelle due stanze arredate alla buona che avevo preso in affitto per poche lire. Quanti anni sono passati da quel giorno e quante case ho cambiato! Adesso vivo con Vespa (6) a Piazza Castello 22, al quarto piano di un bellissimo palazzo d’epoca. Vespa dice che è una specie di solaio bucato a metà da un lucernario che s’innalza verso le stelle, dove s’infiltra la pioggia che fa ammuffire i muri e i quadri (i suoi, ovviamente) appesi alle pareti. Si, l’appartamento è modesto. Ed è piccolo, così piccolo che non riusciamo a ospitare nessuno. Nemmeno mia figlia Gina (7) e suo marito Mario (8), costretti ad alloggiare in una pensioncina al numero 20 di Piazza Castello, a due passi da casa, quando vengono a Milano a trovarmi (9). Però, che magnifici tramonti godiamo da quell’altezza! E che viste spettacolari delle Alpi e del Monte Rosa quando il cielo è terso!
A Milano, mi ero lasciata alle spalle un passato drammatico e doloroso, due relazioni importanti e ben sette figli. La mia reputazione era pessima. Per la famiglia di mia madre ero una poco di buono, una svergognata, tanto per usare un eufemismo. Credo che fossero in molti a pensarla così senza avere il coraggio di dirlo apertamente. Non faccio queste confidenze per giustificarmi.
Chi è in difetto, alla fine, paga sempre il conto. Voglio semplicemente raccontare la mia vita così come è stata realmente partendo dalla mia infanzia e adolescenza in Dalmazia. Quando i miei genitori morirono, prima la mamma nel 1843, e poi il papà nel 1848, ero una ragazzina di 11 anni bisognosa di attenzioni e affetto. Ah, se avessi avuto almeno una sorellina con cui condividere la mai solitudine! Ma Ottavia, la seconda bambina avuta dai miei genitori un anno dopo di me, era sopravvissuta solo pochi giorni (10). Venni affidata alla famiglia di mia madre e mi trasferii a Pirano, in Istria, lasciando il cuore in Dalmazia. A 16 anni presi il diploma magistrale e cominciai a scrivere romanzi e novelle che poi strappavo. L’atmosfera in casa era pesante, malinconica, percepivo il risentimento di mia nonna per il matrimonio fatto da mia madre, di cui ero il frutto.
Trovai rifugio nella lettura. Mi innamorai di Leopardi, studiai con passione gli autori tedeschi fino a quando un fulmine si abbatté sulla mia testa. Mia nonna materna decise che avevo bisogno di qualcuno che si prendesse cura di me e che provvedesse alle mie necessità. Non avevo possibilità di appello, in casa comandava lei. E così, nel 1857, all’età di 18 anni, contro la mia volontà andai sposa al conte Giuseppe Vatta di Pirano, uomo colto e maturo, distante da me anni luce.
Insegnava e aveva mille virtù, ma io ero infelice. Scalpitavo, mi sentivo chiusa in gabbia e, nonostante dalla nostra unione fossero nati tre figli (Domenico, Maria ed Elena), fuggii a Trieste. Oggi, probabilmente, sarei condannata per abbandono del tetto coniugale e abbandono di minori ma, per paura dello scandalo, la nonna e la famiglia di mio marito misero tutto a tacere.
Mi piaceva Trieste, l’attività frenetica del porto la rendevano una città cosmopolita. Nonostante l’unificazione italiana nel 1861, Trieste era rimasta sotto il dominio degli austriaci e pullulava di etnie di vario genere: c’erano italiani, serbi, ungheresi, sloveni, croati, greci. Una piccola torre di Babele, la città perfetta per vivere nell’anonimato. Riuscii subito a trovare un posto di maestra in una scuola di lingua italiana, ma la prospettiva di insegnare per il resto dei mie giorni non faceva per me. Il mio chiodo fisso era scrivere, ma Trieste non era certo la piazza ideale per le mie aspirazioni. Non conoscevo nessuno e non avevo santi in Paradiso. Inaspettatamente, ebbi un colpo di fortuna. Ero seduta al caffè Tommaseo, il più antico di Trieste, rapita dalla bellezza del locale in perfetto stile viennese con i suoi magnifici cristalli, i tavolini, gli specchi, i grandi lampadari, la pasticceria. Il caffè brulicava di gente, aristocratici austriaci, nobildonne e personalità del luogo si riunivano lì per parlare di affari e politica. Stavo sorseggiando un the quando un uomo sulla trentina si avvicinò a me porgendomi un guanto. “Tenga, è suo”, disse. “L’ho visto cadere due minuti fa”. Ero cosi' assorta che ebbi un sobbalzo. Lui rise, io balbettai qualcosa. “Mi
dispiace, non volevo spezzare il filo dei suoi pensieri”, aggiunse. “E invece ha fatto bene. Erano pensieri spiacevoli “, risposi con una battuta. Avevamo rotto il ghiaccio e lo invitai ad accomodarsi. La mia solitudine era così grande che avevo voglia di scambiare due chiacchiere con qualcuno. Non so se, per una donna, fosse un comportamento normale per quei tempi. Probabilmente no, ma io ero fatta così: timida, schiva e riservata, ma anche l’esatto opposto, audace e coraggiosa quando occorreva. Scoprii che si chiamava Emilio Treves, che era figlio di un rabbino della comunità' israelitica di Trieste e che era proprietario di una piccola casa editrice di Milano che, negli anni successivi, avrebbe fatto la fortuna di Verga, D’Annunzio, De Amicis, Deledda e Pirandello. Gli parlai della mia passione per la scrittura, lui mi guardò incuriosito come se mi vedesse per la prima volta e concluse: “Ah bene! Ha già qualcosa nel cassetto?”. Maledicendomi per le novelle e i romanzi che avevo scritto e strappato, dissi di no, quasi vergognandomi, ma lui non si perse d’animo, era un uomo intraprendente. “Allora, vorrà dire che ne inizierà uno per me da domani.” Tornando a casa, mi sembrava di volare. La fortuna aveva bussato alla mia porta sotto le sembianze di Emilio Treves, e io giurai a me stessa che non l’avrei fatta scappare. Ma tutti i miei buoni proponimenti andarono a farsi benedire quando due settimane dopo conobbi Giuseppe Levi, un discendente di una nobile famiglia di Trieste. Mi aggrappai a lui perché ne avevo bisogno e non ebbi paura a confessargli la verità. Lui non mi giudicò, disse solo: “Non mi importa del tuo passato. Sono più preoccupato per te che dovrai vivere con questo rimorso per tutta la vita”. Lo abbracciai forte e scoppiai a piangere. Avevo cercato più volte di avere notizie dei miei tre bambini ma inutilmente. Le lettere che spedivo alla famiglia di mia madre tornavano indietro. Anche se Pirano non era lontana da Trieste, fra me e i miei figli c’era una distanza incolmabile che non sono riuscita a superare neanche quando sono diventi adulti. Dei tre, solo Domenico ha capito. “Immagino come tu abbia sofferto. Il matrimonio fra te e papà”, mi disse un giorno, “era male assortito, anzi impossibile, e tu sei stata forzata dai parenti in un’età in cui non eri in grado di farti un giudizio” (11). Capite? Era riuscito a perdonarmi nonostante le maldicenze dei parenti e della gente e io provai per lui un amore sconfinato. A poco a poco ci riavvicinammo e, io che non sapevo quasi nulla della sua vita, gli scrivevo lunghe lettere asfissiandolo di domande per placare la mia curiosità. Lui mi parlava di sua moglie, dei suoi figli, del suo lavoro di segretario comunale e della sua passione per la poesia. Aveva scritto diversi canti popolari e patriottici e proprio il suo forte sentimento antiaustriaco gli aveva procurato guai fin da quando era all’Università. Una volta, mentre frequentava il primo anno del Politecnico a Graz, scrisse una poesia in morte di Vittorio Emanuele II. La polizia austriaca lo arrestò e le tenne in carcere per 48 ore. Ma il peggio venne dopo, nel 1915, all’inizio della seconda guerra mondiale, quando i gendarmi lo prelevarono da Pirano con l’accusa di scritte ingiuriose contro il governo austriaco e lo internarono prima a Gollersdorf e poi a Overhollerbrun per tre lunghi anni (12). Che brutti ricordi, vorrei cancellarli dalla mente. Ecco, mi sono commossa, mi succede ogni volta…. E non è vero che col tempo si dimentica tutto. Se potessi tornare indietro, darei a quelle creature tutto l’amore che meritavano.
Io e Giuseppe rimanemmo a Trieste diversi anni e, anche se la nostra unione non poteva essere formalizzata perché ero sposata con Giuseppe Vatta, diedi alla luce Giuseppina. La mia adorata Giuseppina che io chiamo Gina. Ha seguito le mie orme, e anche lei è diventata una scrittrice. A proposito … ho un aneddoto molto divertente da raccontare. Quando nel 1902 uscì La meta, il primo romanzo di Gina (che si firmava come Ginevra Speraz), il giornale La Perseveranza di Milano con il quale avevo collaborato all’inizio della mia carriera, fece una recensione favorevole sul libro credendo che ne fossi io l’autrice. Mia figlia infuriata mandò subito una rettifica. Un momento, ve la leggo… l’ho conservata. Ma dove l’ho messa? Ah eccola. “Nel ringraziare il vostro periodico del cenno cortese e benevolo che ha voluto fare del mio romanzo La meta nel numero del 31 ottobre 1902, credo opportuno avvertirlo dell’equivoco in cui è caduto: io Ginevra Speraz non sono affatto Bruno Sperani la quale è, invece, mia madre e si chiama Beatrice. Non toccano quindi a me i lusinghieri epiteti di “vigorosa ed inesauribile scrittrice” essendo anzi La meta il mio primo romanzo. Devotissima Ginevra Speraz Pilo”. Quante risate ci facemmo io e Vespa che, sarcastico e pungente com’è, concluse laconicamente. Giornalisti imbecilli, dimenticando che ne aveva sposata una. Ma andiamo avanti. La nascita di Gina nel 1865 provocò in me una reazione inaspettata. D’improvviso sentii il bisogno di ricostituire la famiglia che avevo abbandonato a Pirano. Persi tutta la voglia di scrivere, mi sembrava fatica sprecata, anzi se avessi potuto in quel periodo avrei studiato medicina, tanto per fare qualcosa di utile. Paradossalmente, io che avevo lottato contro le convenzioni sociali, i pregiudizi e i conformismi, mi ritrovai a incarnare mio malgrado il ruolo di moglie e madre come voleva la cultura ufficiale del tempo, mentre le mie colleghe più spregiudicate già cominciavano a riporre il grembiule di casa per brandire la penna. Erano gli anni del pericolo “roseo”, come l’hanno definito poi i critici, gli anni in cui un’ondata di giornaliste e scrittrici si riversò sul mercato editoriale dell’Italia unificata minacciando il monopolio letterario maschile. Ma quanta fatica per farsi largo, quante critiche, quanto discredito! Per l’opinione dominante, la scrittura femminile era debole, superficiale e priva di originalità soprattutto nel romanzo che rimaneva a esclusivo appannaggio del genio maschile. Forse, inconsciamente, fu per questa grave e amara considerazione, smentita poi dal tempo che, in seguito, decisi di firmare tutti i miei romanzi con lo pseudonimo maschile di Bruno Sperani.
Dopo Gina, a distanza di pochi anni l’una dall’altra, vennero al mondo Noemi, Gilda e Clotilde, ahimè meno fortunate di Gina. Gilda, benedetta ragazza. Insegna in una scuola maschile. L’ha voluto lei quel posto e ora si lagna continuamente dei bambini che sono troppo vispi. Clotilde è in miseria e mezza malata ed è costretta a lavorare tutto il giorno. Non so come faccia, senza donna di servizio, a mandare avanti la casa e ad accudire un bambino. Noemi, anche lei poverina, non naviga nell’oro. Se potessi le aiuterei, ma scrivere non mi ha arricchita. Mi arrangio. Una settimana fa, per esempio, con la seta di una vecchia mantellina mi sono fatta un paltoncino, un cappello e un ombrellino deliziosi. E quando ho dovuto cambiare l’ottomana della sala, ridotta in uno stato pietoso, ho recuperato la stoffa per foderare un divano e una poltrona nuovi. Io e Vespa siamo sempre stati due squattrinati. Ricordo una Pasqua del 1894 o 1895, non so bene. Speravamo di ricavare un po’ di soldi dall’esposizione di quadri e altri oggetti di Vespa organizzata nei locali della Famiglia artistica e poi dalla Ravizza (13). Fu una delusione: mio marito non vendette nulla e in casa non c’era un soldo. Non avendo scelta, contattai l’Aliprandi, un piccolo editore milanese con il quale avevo già pubblicato alcune novelle, e gli cedetti i diritti di 13 racconti alle condizioni che stabilì lui: 300 lire (all’incirca 1300 euro di oggi), per sempre. Una miseria. Ricevetti subito 200 lire di acconto e con quei soldi pagammo una parte dei creditori e facemmo la spesa per le festività pasquali. D'altronde, non ero l’unica ad avere sempre l'acqua alla gola. Giovanni Verga che avevo conosciuto nel salotto letterario di Teresa Kramer (14) mi confidò che, all'inizio della carriera, Treves gli aveva dato 300 lire per pubblicare il suo primo romanzo Eva. Le sue quotazioni erano salite dopo i successi de I Malavoglia e Mastro don Gesualdo e, adesso, pur guadagnando - a suo dire - dagli 8mila alle 12mila lire al mese, era sempre carico di debiti fino agli occhi. Solo che lui, figlio di proprietario terriero, poteva contare su altre entrate in caso di necessita, io invece sulle mie sole forze (15).
Ecco, ho divagato per l’ennesima volta, ma adesso mi rimetto in riga. Mentre le bambine crescevano e ricevevano la loro educazione in collegio, io e Giuseppe ci trasferimmo a Firenze. Mi ritornò la voglia di scrivere e mi procurai subito delle collaborazioni giornalistiche con la Nazione. Scrivevo di spettacoli, di manifestazioni artistiche, di arte, di musica e i miei articoli, così vivaci e briosi, piacevano. Riuscii anche a pubblicare il mio primo romanzo, Due madri: piccolo dramma, ormai introvabile, con l’Aliprandi. Per una provinciale come me, vivere nella città che era la culla della lingua italiana e dell’arte era una continua fonte di ispirazione. Presi subito l’accento toscano e cominciai a darmi da fare per introdurmi nei salotti della città. Ma per quanto mi sforzassi nel trovare collaborazioni, le nostre finanze non brillavano. Di comune accordo decidemmo di trasferirci a Milano che offriva maggiori possibilità di guadagno. Scrissi subito a Gina che studiava in un collegio non lontano da Firenze, e le comunicai che presto saremmo partiti per Milano con il papà. Di Clotilde, Noemi e Gilda non mi preoccupai, vivevano a Trieste seguite dalla famiglia di Giuseppe, ed erano ancora troppo piccole per essere coinvolte. Di loro, mi sarei occupata dopo. Fissammo la data della partenza per Milano il 17 febbraio 1876, ma la morte improvvisa di Giuseppe mandò tutto all’aria. Precipitai in uno stato di profonda prostrazione. Avevo quattro bambine da mantenere e i pochi soldi che avevo bastavano a malapena per tirare avanti qualche mese. Mi feci coraggio e decisi di andare a Milano anche senza Giuseppe. Il giorno prima della partenza, andai a trovare Gina e le dissi in lacrime che ero costretta a lasciarla. Ma solo per poco tempo. Appena sistemata, sarei ritornata da lei a riprendermela.
Ed eccomi a Milano, la città più città d’Italia, come la definiva Verga. In quegli anni, Verga aveva pubblicato diverse novelle a Napoli, Firenze e Torino senza che il suo nome uscisse dalla cerchia delle sue amicizie. Nel 1873 venne a Milano, consegnò due manoscritti a Treves e in poco tempo le case editrici più importanti della città, da Galli, Tommasi e Sonzogno, cominciarono a disputarsi i suoi romanzi. Era la Milano da bere dell’Ottocento, come direste voi oggi. C’erano decine e decine di giornali: Il Secolo, Il Sole, Il Pungolo, La Perseveranza, il Corriere della sera… Si aveva la sensazione che tutte le porte fossero aperte e che in poco tempo si potesse sfondare. Mi rimboccai subito le maniche e iniziai a collaborare con diverse testate, celandomi prima dietro pseudonimi femminili come Livia (16) o Donna Isabella e poi con quello definitivo di Bruno Sperani. Non so se fu una scelta felice firmarmi con un nome maschile perché quando, dieci anni dopo, pubblicai i miei primi romanzi, mi vidi appiccicata addosso l’etichetta di scrittrice virile anche dalla critica femminile. Sentite cosa scrisse Virginia Olper Monis (una scrittrice ebrea veneziana, come me caduta nell’oblio) recensendo il mio libro L’avvocato Malpieri su Cronaca rossa, il giornale di sinistra dove è riportato l’articolo e sul quale scrivevo anch’io. Ve lo leggo. “…. Bruno Sperani, più che gentile è gagliarda, più che impressionista, riflessiva. In lei predominano la profondità e la robustezza specialmente proprie al sesso virile; né si trovano sempre fuse alla delicatezza e alla grazia muliebre, ma la donna qua e là si rivela”. E più avanti: “Sente come una
donna e scrive come un uomo, sente con l’affettuoso cuore muliebre e scrive da forte scrittore”. Anche se il giudizio sul libro era positivo, il ritratto che Virginia fece di me mi colpì perché mortificava la mia femminilità e dava credibilità a uno stereotipo dal quale rifuggivo. Era il 1888 e io avevo 47 anni. Non ero più, come mi aveva descritto De Amicis, agile e snella. Della mia antica bellezza rimanevano solo gli occhi azzurri e una folta capigliatura nera. Ero ingrassata e vestivo in maniera austera, quasi sempre di nero. Sembravo una matrona. Le difficoltà della vita non mi avevano tolto l’appetito, anzi sul cibo sfogavo tutte le mie frustrazioni. Una volta, passeggiando per Piazza Duomo, intravidi tra la folla Ugo Valcarenghi, uno scrittore che avevo conosciuto a Milano una decina di anni prima a una Mostra internazionale dedicata alla musica. Lui era il segretario del
comitato organizzatore e quando mi presentai, capii subito di aver fatto colpo. Non è presunzione o vanità, lo scrisse lui stesso nel suo libro più famoso, Rievocazioni. “Una mattina venne anche una signora, una bella signora. Mi si annunciò come giornalista. Era Bice Speraz… Era intenta a fare un po’ di reportage per La Nazione di Firenze e si occupava anche di musica. La ricordo molto bene. Sembrava ancora molto giovane quantunque avesse già toccato i quarant’anni. Alta, slanciata e anche un po’ magrolina. Elegante e profumata nella serica veste nera che le dava un aspetto signorile un po’ esotico. Parlava con quell’accento toscano e colorito che affascina….”. Bei tempi, ma ormai ero un’altra persona. Mi avvicinai per salutarlo: “Ugo, come stai. Che piacere rivederti”, esclamai. Lui non si mosse, era a disagio. Non mi aveva riconosciuto. “Ugo, sono Beatrice. Beatrice Speraz…”. Fu solo a quel punto che i suoi occhi si illuminarono. Mi baciò la mano imbarazzato. Si scusò per la sua distrazione, ma stava rimuginando sulla trama di un libro che gli dava filo da torcere… Sorrisi e feci finta di credergli. Si era salvato in corner con una bugia grande come una casa.
Quando conobbi Vespa, il mio terzo e ultimo compagno, non avevo né la voglia né il tempo per pensare agli uomini, stritolata com’ero dagli impegni familiari con mia figlia Gina che viveva con me e la mia attività di giornalista/scrittrice. Qualche ammiratore lo avevo, ma io non sono il tipo che si butta in una relazione per ripiego o convenienza, tanto per vivere tranquilla o riabilitarsi agli occhi del mondo. Ero e volevo rimanere una donna indipendente, senza avere tra i piedi cavalieri che mi scortassero. Avevo sperimentato sulla mia pelle che gli uomini pensano al matrimonio come a un luogo di potere, spingendo le donne alla sottomissione o alla frivolezza. E lo scrissi chiaramente in un articolo dal titolo Alle signore riportato su Cronaca Rossa del 6 maggio 1888 che vi invito a leggere a pag…. Per vivere, facevo di tutto: corrispondenze, bozzetti, articoli, racconti brevi . E anche traduzioni dal francese e dal tedesco per Emilio Treves. Ricordate? L’avevo conosciuto a Trieste, avrei dovuto scrivere un libro per lui, ma poi ci eravamo persi di vista. La sua casa editrice aveva sede a Milano, in Via Palermo, così decisi di scrivergli una lettera proponendogli una collaborazione. Andai all’appuntamento senza sapere cosa aspettarmi. Treves era un fiume in piena, mi diede subito delle traduzioni dal tedesco perché sapeva che avevo studiato Schiller, Goethe e Heine. Poi mi parlò della sua intenzione di affidarmi due grandi autori francesi, Zola e Daudet. “Se la sente di tradurli?”, mi chiese a bruciapelo. Tradurre Zola mi faceva paura, era il romanziere più noto in Europa. “Non l’ho mai fatto, non credo di essere in grado….”, tentai di obiettare. “Certo che sì”, rispose lui. “Se ha letto i classici francesi, è ovvio che sa cavarsela”. E cosi, nel giro di pochi giorni, mi ritrovai a tradurre testi dal tedesco e dal francese, ma mi pentii subito di aver accettato. Era un compito lungo ed estenuante, che mi toglieva il tempo materiale per collaborare con riviste che pagavano più velocemente. Vi confesso che, a volte, ero così carica di lavoro che scrivevo gli articoli che dovevo consegnare il giorno dopo con la mano sinistra come diciamo in gergo noi giornalisti per i pezzi fatti male, mentre gli occhi mi si chiudevano per la stanchezza. Non avevo la forza di rileggerli, correggerli o migliorarli. Col risultato che, quando usci il mio secondo romanzo nel 1879 col titolo di Cesare, i critici furono implacabili. Il libro, sentenziarono, era stato scritto con troppa precipitazione. Avevano ragione e io non me la presi. Avevo dato a Cesare tutto il tempo che mi avanzava dalle traduzioni e dalle altre collaborazioni. Evidentemente non era stato sufficiente, ma io non avevo la bacchetta magica. Di più non potevo fare.
Incontrai Vespa nel 1887, in una di quelle occasioni mondane a cui ero costretta dalla mia professione di giornalista. Non ricordo chi ci presentò, ma io lo conoscevo già di fama, perché era un instancabile animatore della vita artistica milanese. Scriveva, dipingeva, faceva sculture, caricature e vignette umoristiche, suonava il violino, insegnava, e chi più ne ha più ne metta. Era un artista a tutto tondo, sfacciato e spregiudicato e io, che ero esattamente l’opposto, ne rimasi affascinata. Ce l’aveva con tutti, con i ricchi, con i leccapiedi, con i i burocrati, con la cultura accademica, con il governo, con la monarchia. Si era reso famoso in città, insieme ad altri amici scapigliati, per un episodio che voglio raccontarvi e che spiega bene chi era Vespa. Il 5 maggio del 1881 Milano ospitò L’Esposizione delle Belle Arti con centinaia di opere tra quadri, sculture e progetti di architettura di artisti provenienti da tutta Italia. Era una manifestazione importante per quei tempi, un evento che – come scrisse non so chi - chiudeva l’età Ottocentesca e sanciva a livello europeo l’esistenza di un Paese chiamato Italia. Vi chiederete cosa c’entra Vespa in tutto questo. C’entra, c’entra eccome! La sua capacità di cogliere il lato comico delle cose e la sua insofferenza per la cultura accademica, lo portarono a organizzare una contromanifestazione, una mostra – sberleffo che chiamò L’Indisposizione delle Belle arti, che si tenne nello studio di uno scultore a Via S. Primo lo stesso giorno dell’Esposizione. Ancora oggi, quando ci ripenso, mi viene da ridere. Sentite qua: su una parete era appeso un quadro dal titolo Effetto di sole buono a mangiarsi con qualche michettina che raffigurava un sole circondato da nubi gialle che sembrava un uovo al tegamino. Un altro, Fuga di Bach, aveva come soggetti i bachi da seta che correvano verso il bosco. Di fronte, sulla parete opposta, una tela bianca incorniciata col sottotitolo di Quadro non incominciato per la morte dell’autore con accanto Il ritratto di un mezzo soprano che era solo la metà di una cantante lirica. Divertente, vero? Vespa mi raccontò che la mostra ebbe un successo inaspettato e straordinario che aveva ripagato in pieno i loro sforzi. Ci avevano messo mesi, lui e i suoi amici scapigliati, a preparare i quadri sberleffo. Vespa era così, faceva le cose per puro divertimento, anche se di batoste ne aveva prese dalla vita. Quando iniziammo la nostra relazione, era vedovo da 14 anni con un figlio adolescente a carico. Sua moglie era morta durante il parto, e da allora non si era più risposato. Vivendo con lui, il mio umore migliorò. Io che ero musona, ansiosa, malinconica e provata dalla vita, imparai a sorridere, a vedere il lato positivo delle cose, a rilassarmi. Lasciai definitivamente il giornalismo e mi dedicai a tempo pieno ai romanzi. Una scelta di cui non mi sono mai pentita e che segnò il periodo più prolifico e intenso della mia attività di scrittrice. Quando iniziai la mia relazione con Vespa avevo già pubblicato diverse novelle e romanzi, tra cui due libri ben recensiti dalla critica. Parlo di Nell’Ingranaggio e di Numeri e segni. Finalmente, dopo quasi 10 anni di gavetta, le cose cominciavano a girare per il verso giusto. Ci fu persino un giornale inglese che pubblicò un trafiletto su di me. Mi pare fosse il Queen o il The Queen. Mi definiva una scrittrice di talento, una prima donna nel panorama delle autrici italiane. Ero lusingata da tanta benevolenza, ma scoppiai a ridere quando lessi il seguito dell’articoletto: “Bruno Sperani vive a Milano e ha una figlia, una figlia che scrive. E questo sfata il vecchio detto secondo il quale se un genitore è intelligente, la figlia è stupida. Non si può mai sapere cosa ci riserva la vita”. Ah, gli inglesi e il loro cinico senso dell’umorismo. Ma la soddisfazione più grande fu la recensione che Filippo Turati fece del mio terzo libro, L’Avvocato Malpieri subito dopo la pubblicazione. Il fatto che un brillante politico e giornalista apprezzasse il mio lavoro di scrittrice mi riempiva di orgoglio.
Ma nonostante le buone recensioni della critica, vendevo poco. I miei romanzi erano anti borghese e io apparivo come un'anima ribelle, una fustigatrice delle convenzioni sociali e dei costumi. Il pubblico gradiva di più i romanzi di Neera (17), una scrittrice con la quale mi contendevo il campo e che riusciva a ritrarre e a blandire la realtà in maniera più scaltra di me. Il suo romanzo più famoso, Teresa, le aveva spianato la strada al successo e ora Neera veniva recensita dalle riviste più quotate, pubblicava con gli editori piu importanti, intratteneva corrispondenze con i letterati più noti, come Benedetto Croce, per esempio. Al lettore piaceva il suo stile, il suo modo di dipingere la realtà smussandone gli angoli e incipriandola. Che dire! Eravamo lontane come il giorno e la notte. Lei descriveva la monotona quiete della campagna lombarda, la bellezza dei laghi tersi e la rassegnazione della donna al proprio destino, e io ritraevo piccoli borghesi, proletari o aristocratici con le loro sofferenze, ipocrisie e meschinità sopraffatti dall'ordine delle cose, stritolati dall'ingranaggio della vita. Le donne, poi....Le rappresentavo così come erano, deboli, sottomesse, incapaci di affermarsi al di fuori della maternità e del matrimonio. Le protagoniste dei romanzi di Neera, invece, pur essendo vittime della brutalità degli uomini, assurgevano al ruolo di eroine e paladine dei valori della famiglia, il luogo ideale dove combattere gli eccessi e l'immoralismo propugnato dal modello francese di Flaubert, Zola e Balzac. Il ruolo della donna, dunque, non era lottare per l'emancipazione, ma perpetuare la specie sopportando docilmente le catene dietro un sorriso. Che mi toccava sentire! Impazzivo di rabbia nel leggere le idiozie che predicava nei suoi articoli. Però in fondo aveva ragione lei. Ero troppo in anticipo sui tempi. Come potevano le donne sottrarsi a un destino ingrato se la loro istruzione era in mano ai conservatori? Nelle classi elementari femminili, per esempio, s’insegnava a stento a leggere, scrivere e fare di conto. Il grosso delle lezioni era incentrato sull’economia domestica, cucito, rammendo, maglia, cura della casa…. Non c'era alcun bisogno di far studiare letteratura o filosofia a persone che poi sarebbero
diventate mogli e madri virtuose. Sarebbe stata fatica sprecata.
Per fortuna, non ero la sola a lottare contro la schiavitù della famiglia e lo stereotipo della donna come angelo del focolare domestico. Al mio arrivo a Milano avevo conosciuto nel salotto della Kramer Maria Antonietta Torriani, in arte Marchesa Colombi. Il suo aspetto fisico insignificante non lasciava trapelare per nulla di quali passioni e trasgressioni fosse capace quella donna. Veniva da Novara, ma viveva a Milano dal 1868, dove si era trasferita dopo essere fuggita dal convento nel quale l'avevano rinchiusa i suoi parenti dopo il rifiuto a un matrimonio di convenienza. All'inizio scriveva di moda, costume, storie strappalacrime, roba commerciale e poco impegnativa, come facevo io. Ma poi cominciò a interessarsi alla causa femminile, organizzando conferenze pubbliche, corsi di lingua e letteratura e battendosi per la creazione di un liceo a Milano. L'ho sempre considerata un'amica. Sapendo delle mie difficoltà familiari e professionali, si faceva in quattro per procurarmi collaborazioni. Confesso che ho sempre invidiato la sua grinta e la sua faccia tosta. Credo che si divertisse molto a sfidare le convenzioni e come aggravante della sua compromessa reputazione, fumava sigari e sigarini in pubblico, tanto per scandalizzare i benpensanti. Era uno spasso. Senza di lei non avrei mai pubblicato a puntate, sul Corriere della sera il romanzo Numeri e Sogni. L'anno prima che mi trasferissi a Milano, Maria Antonietta aveva sposato Eugenio Torelli Voillier, fondatore, proprietario e direttore del giornale. Che strana coppia che erano quei due!. Lei, piemontese, piccola, robusta e dai capelli e occhi neri, sembrava una del Sud. Lui, napoletano, alto,magro, capelli e barba rossicci e occhi chiari, sembrava un inglese (18). Ricordo perfettamente il giorno in cui Maria Antonietta mi disse Dai, vieni al Corriere. Ti faccio conoscere quel gentleman di mio marito. L'appuntamento era a Piazza Duomo in una giornata in cui pioveva a dirotto. Il Corriere era a due passi, in due stanze di un ammezzato in Galleria, più un locale sotterraneo dove lavoravano tre redattori. Regnava il caos lì dentro. Eugenio si scusò e mi strinse la mano. Mia moglie mi ha parlato molto bene di te, disse frettolosamente tenendo in mano due bozze già pronto a congedarmi. Ho bisogno di collaboratori. Perché non mi proponi qualcosa? Ti avverto però: paghiamo pochissimo. E così dicendo si dileguò nel locale sotterraneo. Non avrei mai immaginato che in quella baraonda sarebbe nato il più grande quotidiano italiano. Per qualche tempo mi dimenticai di Eugenio. La prospettiva di guadagnare poco o niente per un giornale esordiente non mi allettava, ma nel giro di poco tempo dovetti ricredermi. Sotto la guida di Eugenio, Il Corriere cresceva di giorno in giorno, scalzando i concorrenti. Eugenio era un uomo di talento, un fior fiore di giornalista formatosi alla scuola di Alessandro Dumas, lo scrittore francese che nel 1860, sull'onda dei successi garibaldini, aveva fondato e diretto a Napoli per quattro anni
L'Indipendente. Ero tentata di contattarlo quando fui preceduta da un suo biglietto in cui mi commissionava un racconto da pubblicare a puntate sul suo giornale. Io avevo appena finito di scrivere Numeri e segni. Gli mandai il manoscritto, ma fui subito assalita da mille dubbi. E se non gli fosse piaciuto? Numeri e segni non era la solita storia sentimentale strappalacrime a cui era abituato il pubblico femminile, ma la vita tormentata di un pittore di provincia che si perde nella Milano affarista dell'epoca. Era stato Vespa a ispirarmi, ma adesso non ero più sicura di niente. La risposta di Eugenio mi liberò da tutte le mie preoccupazioni. Ho letto il racconto, scrisse nel suo stile secco e asciutto. Interessante. Vieni a trovarmi che definiamo i dettagli. Ero felice, ma mi chiedo quale ruolo avesse giocato Maria Antonietta in questa vicenda. Era stata lei a sollecitare Eugenio? Non lo saprò mai. Di certo, la mia amica aveva un grande ascendente sul marito e sugli altri uomini. Era sulla bocca di tutti la sua relazione con Giosuè Carducci e i suoi rapporti amichevoli con Emilio Treves al quale raccomandava in tono canzonatorio le colleghe che reputava degne di stima. Sentite cosa gli scrisse una volta: Mio signore, le ho mandato un lavoro della signorina Ceriani Sebregondi per la quale le ho fatto delle raccomandazioni e preghiere che si fanno soltanto a un uomo che ha fatto colazione con il re. E non mi ha risposto nulla. E forse quel lavoro l'avra' messo sul fuoco. A pensarci mi vengono i capelli bianchi. Cosa posso dire io a quella signorina? Alla peggio la mando da lei e si salvi come può. Mi raccomando il mio manoscritto, che non vada distrutto come quello della signorina Ceriani. Eugenio la saluta (19). Alcuni anni dopo pubblicai Tre donne, forse il mio romanzo più famoso e poi La fabbrica, il libro che spinse i critici a chiedersi quale fosse il mio reale rapporto con il socialismo. In un momento di grandi trasformazioni, caratterizzato dalla nascita del movimento operaio, di lotte, scioperi e repressioni, avvertii il bisogno di denunciare e fotografare questa realtà scrivendo appunto La Fabbrica che fu dato alle stampe dall'editore Galli nel 1893, un anno dopo la nascita del Partito dei lavoratori italiani. Ce la misi tutta per descrivere in maniera realistica l'ambiente proletario milanese e forse ci sono riuscita se ancora oggi qualcuno si chiede come ha fatto una signora che frequentava i salotti milanesi e conduceva una vita regolare e borghese a descrivere con tanta verosimiglianza un mondo lontano da lei mille anni luce. In effetti, anche se non ero una militante, sono sempre stata una simpatizzante dei movimenti socialisti, emancipazionisti, femministi, umanitaristi e quant'altro potesse salvare le donne, gli oppressi e i reietti dal loro stato subalterno.
Chi mi conosce sa che ho sempre combattuto contro le ingiustizie sociali, per l'uguaglianza della donna, il diritto al voto, all'istruzione, alla parità salariale. E con chi potevo condividere queste idee se non con quelli, come per esempio il gruppo democratico/socialista di Turati, Ghisleri, Virginia Olper o Cameroni, che la pensavano come me? Di certo, analizzare il mondo operaio dall'esterno senza conoscerne i meccanismi fu una grande sfida, l'ultima della mia lunga e prolifica carriera. Dopo La fabbrica, mi isolai dal mondo, e anche se passavo le giornate a scrivere, stentavo a trovare un editore. L'unico che pubblicava i miei racconti era Aliprandi, in virtù di quel contratto capestro di 300 lire per 13 racconti (vedi pagina...) che avevo sottoscritto in un momento di difficoltà economica. Non dico bugie: provate a spulciare nella mia bibliografia. Vedrete che dal 1893/94 fino alla fine del 1900, il mio unico editore - a parte qualche rara eccezione – è proprio lui, Aliprandi. Avrei voluto tanto che, tra i grandi editori del tempo, oltre a Galli, anche Treves o Sonzogno avessero in catalogo un mio romanzo. Invece non andò così. Ebbi solo una piccola fiammella di speranza nel 1883, quando Sonzogno comprò i diritti di Veronica Grandi, un racconto che avevo pubblicato a puntate su La Nazione di Firenze. Pensavo che ne facesse un volume, invece non lo fece uscire mai, lasciandomi l'amaro in bocca. Mi rinchiusi nel mio mondo, quasi non avevo più una vita sociale e le mie precarie condizioni di salute peggioravano la situazione. Quando mi sentivo meglio, facevo lunghe passeggiate al Parco con Vespa, l'unico uomo che io abbia veramente amato e che mi è stato accanto fino all'ultimo giorno della mia vita. Dei miei ultimi lavori scritti dopo il 1900, quando ormai la giovinezza era alla spalle, vi parlerò solo di uno perché sono stanca, e cioè: Ricordi della mia infanzia in Dalmazia. Avevo 76 anni quando è stato pubblicato, l'età in cui la paura della dipartita ci fa aggrappare alla memoria delle persone amate che presto si raggiungeranno. Io li ho raggiunti il 2 dicembre 1923, quando la mia vita si è spenta per un attacco di anemia cerebrale. Gina non era con me. Dopo la morte di Mario si è trasferita a Buenos Aires, illudendosi di soffrire meno. Vespa mi ha assistito amorevolmente fino all'ultimo respiro e il mio più grande cruccio è stato lasciarlo solo con la sua tristezza e malinconia. Adesso riposo nel Cimitero Maggiore di Milano, il meritato premio per chi come me ha vissuto, ha lottato, ha sofferto, ha amato.
Nota 1 Ci sono informazioni contrastanti sulla città natale di Beatrice Speraz. Dallo stato di famiglia redatto dal Comune
di Milano, la scrittrice risulterebbe essere di Spalato, ma fonti croate indicano in Salona il suo luogo di nascita.
Nota 2 Elena Mariana Teresa Alessandri, nata a Umago, Istria, il 17 marzo 1817, morta a Umago il 23 agosto
del 1843, a soli 26 anni.
Nota 3 Marin Sperac, nato a Solona, Dalmazia, nel 1810, morto nella stessa città il 18 giugno 1848.
Nota 4 Ottavia De Franceschi, sposata a Bernardo Alessandri.
Nota 5 Descrizione tratta dal suo libro Ricordi della mia infanzia in Dalmazia, Milano, A. Vallardi 1915.
Nota 6 Vespasiano Bignami (Cremona 1841 - Milano 1929), ultimo marito di Beatrice Speraz. Era uno degli artisti più
versatili della scapigliatura milanese. Esordi' come illustratore e caricaturista per poi dedicarsi quasi esclusivamente alla
pittura. A lui si deve la fondazione nel 1872 della Famiglia artistica che ancora oggi sopravvive.
Nota 7 Giuseppina Levi, in arte Ginevra Speraz o Ginevra Pilo (Bologna 1865 - Buenos Aires 1936), scrittrice di libri per
bambini, era la primogenita delle quattro figlie nate dalla relazione di Beatrice con Giuseppe Levi, morto nel 1876. La sua
opera migliore e' considerata La meta.
Nota 8 Mario Pilo (Pallanza 1859 - Mantova 1920), marito di Giuseppina Levi. Fu professore di Scienze naturali e,
successivamente, docente di estetica musicale a Bologna e Pisa.
Nota 9 La circostanza si desume dalla lettera che Beatrice Speraz scrisse a sua figlia Gina il 20 maggio del 1903
conservata alla Biblioteca Comunale Roberto Ardigo' di Mantova, fondo Mario Pilo.
Nota 10 Ottavia Vica, seconda figlia di Marin ed Elena, era nata il 16 settembre 1840 ma era morta otto giorni dopo a
Solona. L'informazione e' ricavata dal testo Spisateljica Vica Sperac o Splitui Solinu di Milan Ivanisevic.
Nota 11 Lo spunto è tratto dalla lettera di Domenico Vatta alla sorella Giuseppina Levi del 22 dicembre 1918
conservata alla Biblioterca comunale Roberto Ardigo’ di Mantova, fondo Mario Pilo.
Nota 12 Tutte le informazioni relative a Domenico Vatta sono tratte dal libro di Paolo Blasi Poesia Piranese
dell’Ottocento, 1995, Trieste.
Nota 13 Alessandrina Ravizza (Gatcina 1846 – Milano 1915). Era nata in Russia dove il padre che era milanese si era
rifugiato durante le guerre napoleoniche. Nel 1863 si trasferi’ a Milano e divenne ben presto una figura di riferimento del
mondo dell’assistenza e dell’emancipazione femminile. A lei è dedicato il Parco milanese Ravizza che porta il suo nome.
Nota 14 Teresa Berra In Kramer (Milano 1804 – Milano 1879) . L’Enciclopedia Treccani la definisce una patriota italiana,
amica di Mazzini e di altri esuli italiani. I salotti della sua casa milanese e della villa di Cremella erano aperti agli aderenti
e simpatizzanti della Giovine Italia. Finì per essere sorvegliata dalla Polizia. Tra i frequentatori abituali vi erano Giovanni
Verga, Bruno Sperani, Maria Antonietta Torriani nota come Marchesa Colombi, Emmanuele Navarro della Miraglia,
Giovanni Visconti Venosta.
Nota 15 Le informazioni sugli introiti di Verga sono tratte dalla tesi di laurea Il notomista nelle anime, sociologia e
geografia del romanzo nell’Italia di fine Ottocento (1870-1899) di Valentina Perozzo, pag.332, Università degli Studi di
Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità.
Nota 16 La prima novella milanese della scrittrice a firma Livia apparve in tre puntate il 29 agosto del 1876 sulle
pagine de La Perseveranza col titolo di La notte del 6 febbraio.
Nota 17 Anna Radius Zuccari (Milano 1846 – Milano 1918). Scrittrice di grande successo che esordì nel 1875. Nel 1890
fu tra i fondatori della rivista Vita Intima che però cessò le pubblicazioni l’anno dopo.
Nota 18 Spunti e informazioni sulla Marchesa Colombi e Eugenio Torelli Voillier sono stati tratti dal libro di Maria Teresa
Cometto La Marchesa Colombi, B.L.U Editoriale, 1996, Torino
Nota 19 Fondo Emilio Treves, Civica Biblioteca d’arte, Castello Sforzesco, Milano. Lettera di Marchesa Colombi a Emilio
Treves, 5 novembre 1898.__
In copertina, un quadro di Giuseppe Colombo.