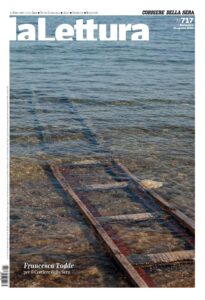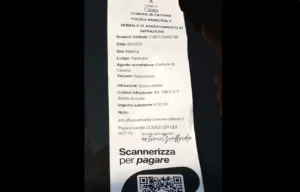E altri racconti del paese di Vigata
di Redazione

Roma – Con 8 racconti che sono il romanzo di Vigàta, paese inventato ma più vero di quelli che esistono realmente, Andrea Camilleri ci offre un ritratto divertente e amarognolo della popolazione siciliana. Gli affacci sul passato, manie d’una piccola borghesia pettegola e bigotta che non perde occasione per peccare in modo sfacciato, salvo camuffare e negare anche l’evidenza subito dopo, sono specchi falsi che restituiscono un’immagine spezzata e distorta della realtà.
E così la signora fascista de «La congiura» al centro di un complotto; la beffa ai notabili del circolo dove si gioca d’azzardo derubati da un comune malvivente in «Regali di Natale»; «Il merlo parlante» che svela insospettabili segreti d’alcova; «Il gran circo Taddei», sgangherata compagnia di guitti del quale fanno parte 3 giovani donne coinvolte in una tragicommedia pirandelliana, non sono altro che figure spesso burlesche che ritornano anche in «La fine della missione», «Un giro di giostra», «La trovatura» e «La rivelazione». Memorie, dice Camilleri, “di una sconfinata vanità e varietà umana rilette alla logica del presente e mondate da ogni incrinatura demoniaca”, che prendono consistenza in “Gran circo Taddei e altre storie di Vigata”.
Camilleri, dietro l’umorismo di ogni racconto, quanta tragedia c’è?
«Parecchia. E credo non tutta dissimulata dal divertimento. Anche questo è un modo di contrabbandare le cose».
I suoi racconti si sarebbero potuti intitolare anche “libro dei tradimenti”, perché l’inganno è sempre presente. Tradire è proprio nella natura dell’uomo?
«L’inganno è una delle componenti, ma diciamo che il tradimento è la faccia oscura del carattere siciliano».
E com’è quella chiara?
«E’ la faccia nella quale ci imbattiamo quotidianamente: aperta, sorridente, cordiale, espansiva e leale. E’ l’altra faccia della luna, quella che non vediamo, ma c’è. E non sempre è cordiale e espansiva».
Storie a volte surreali ma indicative di quella che è l’anima della provincia ricca di tante sfaccettature. Tutte storie inventate, o si tratta di materiale raccolto sul campo?
«Sono tutte storie inventate, però nascono da un terreno di coltura. Preciso: sono inventate ma sono altrettanto possibili perché il terreno di coltura è quello. L’anima siciliana è molto variabile».
Quindi deve solo concimare un po’ e penso che il concime non le manchi?
«Di concime ne ho quanto ne vuole, di tutti i tipi. Lo distribuisco sulle mie coltivazioni di storie che germogliano dalla mia fantasia come pianticelle, e perché crescano bene le curo come si deve».
Che cosa rende i siciliani così predisposti alla cospirazione, all’intrigo?
«La voglia di complicare le cose. Cito una bellissima frase che Moravia un giorno disse a Sciascia: “La differenza tra i milanesi e i siciliani è che i milanesi tendono a semplificare un fatto complicato. I siciliani operano all’inverso: un fatto semplicissimo tendono a complicarlo”. E le complicazioni portano a sotterfugi e tradimenti».
L’ironia è la misura dei suoi racconti, tutti tessuti con un filo che associa alla storia una grande capacità rievocativa. Così anche la tragedia diventa comica.
«Per me è un fatto naturale cercare di trasformare la tragedia in comicità. Non so se ci riesco, ma in certe occasioni bisogna stemperare l’incombenza di certe situazioni. Ritengo sia anche questa una forma di difesa. C’è un bellissimo passaggio ne Il consiglio d’Egitto di Sciascia, in cui il vicerè chiede a un siciliano: “Come si fa a essere siciliani ?” Sciascia nel romanzo non dà una risposta. Io, modestamente, dico che si può essere siciliani solo se si ha ironia».
Le vicende si svolgono in un tempo in cui la burla era sinonimo d’intelligenza e il gallismo una sorta di sfida tra giovinastri dediti alla caccia di fimmine. In questi ritratti di provincia fonda, quanto s’identifica e quanto si diverte?
«Credo che il racconto italiano sia una grande tradizione. Mutatis Mutandis, si può dire che i miei racconti sono pronipoti di certi racconti e novelle del Boccaccio, di Matteo Bandello e di tutta la grande novellistica italiana».
I politicanti fascisti di alcuni racconti nelle loro piccolezze, ripicche e dispetti bambineschi, non mi sembrano molto differenti da molti politici attuali. Una sorta di mediocrità dilagante?
«Il carattere centrale di tutte le cose è proprio la mediocrità dilagante, ed è un carattere eterno, La mediocrità è veramente più eterna dell’intelligenza. E’ un connettivo enorme dovunque e soprattutto in politica».
Hanno un ruolo favolistico gli animali presenti nei suoi racconti?
«Essi non sono né osopiani né trilussiani, e la morale della favola di questi animali, non è molto educativa. Sono elementi di calcolo come tanti altri nella vita, utilizzati a scopi diversi da quelli cui la natura li ha creati».
Che cosa ne pensa Andrea Camilleri dei fermenti rivoluzionari che stanno sorgendo a macchia d’olio nel Maghreb?
«Poiché spero che a queste ribellioni possano succedere dei governi democratici, io non posso che vederli bene, anche con il problema sovraeccitato dal terrore dei cinquantamila o centomila immigrati che possono arrivare. In genere dalle dittature si scappa, dalle democrazie no. E la democrazia, auspicando che si instauri al più presto in tutti i paesi, potrebbe essere l’unico deterrente a fermare gli sbarchi in Italia».
Le fa piacere la festa critica con la partecipazione degli studenti che hanno organizzato a Roma in suo onore nei giorni 8 e 9 marzo?
«Per me saranno giorni molto belli, perché sono siciliano ma prima di tutto un italiano nato in Sicilia. Ci vado molto volentieri e sono pronto a rispondere a tutte le domande dei giovani così come ho sempre fatto nelle scuole in cui sono andato ogni volta che mi hanno invitato. Per me parlare con i giovani è un invito a nozze, perché la loro freschezza intellettuale è piena di curiosità e sanno avanzare domande sempre interessanti».
© Riproduzione riservata