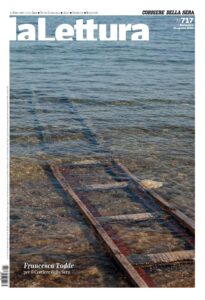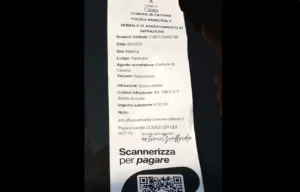Diciotto anni dopo…
di Giuseppe Savà


Scicli – Tre domande sull’architettura da salvaguardare.
Prima Domanda
Quali manufatti architettonici esistenti a Scicli sono meritevoli di essere conservati alla lettera e quali possono essere suscettibili di modifiche progettuali e funzionali?
Vorrei rispondere a questa domande con delle considerazioni disciplinari e metodologiche di carattere generale, per definire dei lineamenti di intervento riferibili ai tanti manufatti architettonici degradati della città in attesa di attenzione.
Il campo della storia dell’architettura finora è stato arato solo per manufatti emergenti o per “protagonisti” (i progettisti di architetture), ultimamente stiamo assistendo ad uno spostamento di interessi sempre più cosciente e intenzionale verso i luoghi del lavoro e l’architettura “minore”.
La riprogettazione funzionale (nella prassi riconosciuta e consolidata da tempo) riguarda soprattutto edifici che in primo luogo sono assenti dalla storia dell’architettura (gli edifici non monumentali) e in secondo luogo sono successivi, come epoca di edificazione, al 1800. Cioè, secondo i principi appena esposti, sono inoperanti le categorie elaborate a partire dagli edifici eccezionali (unici e irripetibili, es. Fornace Penna, Palazzo Beneventano) e i criteri fondati sui “caratteri stilistici” (il Barocco di Scicli) sono inapplicabili.
Se la cura del riattivatore si basa su queste categorie e criteri, si può dedurre che – nel valutare il grado di intervento – prevarranno le considerazioni basate sul contenuto (monumentale o stilistico), in assenza di questo, egli giudicherà gli edifici sprovvisti di interesse, quindi rivitalizzabili.
La riattivazione e anche il consolidamento non attenti ai caratteri filologici delle architetture non monumentali, si scontra con una carenza culturale. Sappiamo come trattare le chiese monumentali e i palazzi signorili, ma siamo disarmati davanti alla città operaia o ai luoghi del lavoro. E poi la nostra cultura eclettica spesso non sa dove si trova la linea di spartizione tra il conservabile e il modificabile. Se a questo aggiungiamo la soppressione – legittima – della distinzione netta tra architettura “minore“ e “grande” architettura, non si facilita certo il compito. Questa contrattazione non significa che bisogna trattare tutti gli edifici antichi non monumentali allo stesso modo, è evidente che il grado di intervento deve variare da caso a caso con sensibilità e cultura nell’interesse dell’identità del manufatto.
La conservazione ci difende dalle spesso maldestre manipolazioni sulle architetture del passato e attua una zona protetta attorno al monumento. Un alone, una terra di attesa e di rispetto nella quale si spegne l’apparente silenzio, ma l’effettivo fragore, emesso dagli “oggetti storici”. Zona protetta come distanza riverenziale verso la “qualità” materializzatasi nelle architetture uniche e monumentali. Per quanto concerne il recupero e la ridestinazione (o meglio rivitalizzazione) penso che per un verso esse siano strategie utili (spesso rappresentano la condizione necessaria per prolungare la presenza di un edificio), per altro bisognerebbe farne a meno nei casi di ruderizzazione già avvenuta (es. Convento dei Cappuccini, S. Antonio, Fornace Penna) o quando si è in presenza di un elevato pregio stilistico del manufatto. Intervenire in questi casi limite – nell’impazienza del consolidamento solo per necessità statiche – comporta la realizzazione di un manufatto diverso dal primo in attenzione e che quindi rende vano e nega lo stesso processo di conservazione. Se rileggiamo le vicende architettoniche trascorse ci rendiamo conto come la cultura della conservazione (v. politica edilizia a Bologna negli anni Settanta) è nata come reazione ai “fallimenti” della grande scala urbana teorizzata dalla modernità (es. scuola Lipparini in p. Italia).
ph. Bellia
Continua…
© Riproduzione riservata