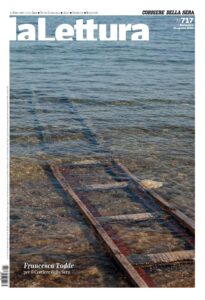Un articolo di Massimo Gatta, su La biblioteca di via Senato
di Massimo Gatta

Roma – Forse non basteranno neppure questi cinquant’anni che ci separano dalla morte, a indurre a una maggiore e più sobria valutazione (e conoscenza) dell’opera complessiva svolta nella Roma degli anni Trenta dal giornalista e intellettuale fascista Telesio Interlandi(Chiaramonte Gulfi, 20 ottobre 1894 – Roma, 15 gennaio 1965), se non altro per non indulgere ancora in uno sterile gioco al massacro, riproponendo stereotipi fin troppo noti, che nulla di nuovo hanno apportato in questi anni, se non un’algida damnatio memoriae, assoluta e inappellabile.
Una desertificazione intellettuale dove l’azzeramento della memoria, figuriamoci poi dell’opera, ha rappresentato il telos abbacinante che ha animato, e anima ancora, tutti coloro che l’hanno sentito anche solo nominare, associandolo unicamente alla esiziale politica razzista e antisemita del fascismo, e fino alle leggi del ’38- ’39.
Non casualmente nel 2014, dalle pagine di una rivista ragusana online, un non meglio identificato “Un Uomo Libero” (come si firmava) scriveva: «[…] Ho letto attentamente gli atti di quella manifestazione. Dopo circa sedici anni, non riesco ancora a capire, dal loro attento esame, il bisogno di fare luce su un’esistenza per la quale il silenzio sarebbe stato, invece, quanto mai prudente e necessario. Men che meno capisco l’interesse della famiglia (in quell’occasione erano presenti il figlio e il nipote) a sollevare il velo dell’oblio da una figura tanto negativa ed eticamente poco esemplare».
Ecco, appunto. L’anonimo articolista non faceva che seguire una lunga tradizione, e ponendosi gli stessi dubbi. Ma cosa nascondeva, e nasconde, la paura di capire di più e meglio? Perché ci saremmo dovuti trincerare, ancora una volta, dietro al silenzio «prudente e necessario»? Perché non avremmo dovuto e potuto, in tutti questi anni, «fare luce» su una figura magmatica, complessa, chiaroscurale, certamente «negativa ed eticamente poco esemplare», ma anche ricca di stimoli culturali, letterari, artistici, editoriali, di quando Roma, in quegli anni drammatici, era pur sempre la capitale culturale d’Europa?
L’anonimo articolista citava gli Atti di un convegno svoltosi a Chiaramonte Gulfi nel 1998 su Telesio Interlandi: il giornalista, l’intellettuale, lo scrittore (e – aggiungiamo noi – l’appassionato collezionista d’arte pittorica, soprattutto di Fausto Pirandello).
Un volume del tutto assente dalla bibliografia consultata, così come è assente dalle biblioteche italiane e straniere, compresa la biblioteca civica di Chiaramonte Gulfi, e il cui ricordo risulta nebbioso e stinto persino ai tipografi di Comiso che lo stamparono.
Sembra anche qui di ripercorrere sentieri già battuti, toccando ancora una volta con mano l’aura di maledettismo che il nome Interlandi ancora suscita in coloro (peraltro rarissimi) che conoscono la sua vicenda biografica e intellettuale, nonostante il fatto che Interlandi, al di là delle teorie anti-semite e razziste (il razzismo biologico che si opponeva al razzismo idealista o spiritualista) perpetrate a sostegno delle leggi razziali del ’38-’39 a favore della razza italiana attraverso le esiziali pagine de «La difesa della razza», sia stato anche, insieme a Federigo Valli e altri, uno degli snodi intellettuali di quella galassia artistico-editorial-culturale nata e progredita durante il ventennio fascista, e in particolare nella Roma degli anni Trenta, costeggiatori di ogni avanguardia.
Un Interlandi che l’avanguardia futurista l’aveva intercettata fin dal 1914 a Catania dove tentava l’approccio al giornalismo. Lì aveva conosciuto personaggi come Antonio Bruno, Giovanni Centorbi e il poeta Mauro Ittar, tre giovani che nel ’15 diedero vita nella città etnea ai soli cinque numeri del quindicinale futurista «Pickwick». Anni dopo quello stesso Ittar sarà, non casualmente, caporedattore de «Il Tevere» di Interlandi. Ma forse non bastano questi cinquant’anni di vuoto pneumatico e di silenzio; non basta forse neanche il fatto che uno scrittore antifascista di assoluto prestigio intellettuale, e al di sopra di ogni sospetto, come Leonardo Sciascia, nei suoi anni estremi, con le sue antenne finissime e sensibili, già all’altezza del 1982, e concretamente poi mentre lavorava a Una storia semplice, il suo ultimo romanzo, avesse intercettato in qualche modo l’uomo e l’intellettuale Interlandi (anche attraverso il “suo” Brancati, Ercole Patti, il catanese Arcangelo Blandini, Alfredo Mezio e Corrado Sofia, una gran pattuglia di siciliani). Poco prima che morisse, Lorenzo Mondo lo incontrò in clinica e tra l’altro Sciascia gli parlò proprio del suo progetto su Interlandi: «Vorrebbe scrivere una storia appassionante e misteriosa (misteriosa per i risvolti interiori), di un avvocato antifascista che dopo la Liberazione ospita in casa sua a Brescia, per dieci mesi, a rischio della propria vita, Telesio Interlandi, il teorico della razza. Ma adesso non può, il materiale, i documenti, si trovano a Palermo. Ma per il momento si accontenta di lavorare ad altro, un racconto ‘di fantasia’», intercettando Interlandi anche iconicamente, quando scrisse delle tempere di Duilio Cambellotti per la prefettura di Ragusa.
Da tutti questi indizi ben si comprende come Sciascia desiderasse assai trafficare con il personaggio Interlandi per realizzare, com’era inciso nel suo blasone etico, una meditazione sul senso della giustizia, della compassione e forse anche della morte, un ripercorrere una vicenda obliqua e misteriosa com’erano state quelle, opposte e simili, di un Raymond Roussel, di un Majorana o di un Aldo Moro; «un racconto, sublimazione e trasfigurazione letteraria», recuperando cioè la parte tragica, drammatica dei giorni estremi della caduta e dell’oblio di Interlandi, come emerge anche dal carteggio di Sciascia con il figlio di Interlandi, Cesare.
Una vicenda che dovette turbare molto il siciliano Sciascia per la scelta enigmatica del siciliano Interlandi di mettere il suo nome e il suo timbro all’infame politica razziale del fascismo, lui figlio di «una terra che è un impasto di razze, dove sono venuti e si sono accampati da tutte le parti e dov’è sacra l’ospitalità dello ‘straniero’, del migrante che viene da altrove», e quanto attuale appare oggi questa considerazione di Mughini espressa ben 25 anni fa, quando ancora lontanissimi erano i giorni dei quotidiani sbarchi di migranti a Lampedusa.
Ma lo scrittore di Racalmuto, a fronte di una documentazione che andava raccogliendo, non fece in tempo (a causa della morte) a scrivere l’affaire Interlandi, una rilettura ‘storico- romanzesca’ della vicenda, che avrebbe forse rivelato anche altro del giornalista maledetto e sulfureo di Chiaramonte Gulfi, la parte che ci manca, appunto.
Un libro che Sciascia aveva destinato alla più intensa delle Collane della Sellerio, quella emblematicamente intitolala alla “memoria”, da lui stesso creata, proprio quella memoria che, nell’affaire Interlandi, era stata così bene rimossa.
Quella documentazione preziosa Sciascia l’affidò, in forma di testamento spirituale, all’amico Vincenzo Vitale, magistrato e giornalista, il quale nel 1999 (un anno dopo il convegno che abbiamo ricordato e al quale lui stesso venne invitato), riuscì in qualche modo a mantenere la promessa fatta a Sciascia, pubblicando un libretto su Interlandi in occasione del decennale della morte dell’amico.
Nel periodo in cui Sciascia andava interessandosi alle vicende tragiche del ‘maledetto’ Interlandi, incontrò Giampiero Mughini il quale, suggestionato da quanto lo scrittore di Racalmuto gli narrava del giornalista razzista, siciliano come loro due, andò anch’egli maturando l’idea di una sorta di biografia intellettuale di un periodo e di una generazione della Roma di quegli anni, un libro dedicato a Interlandi ma anche a quella ricca galassia.
Fu così che nel 1991 venne pubblicato quello che è ancora oggi l’unico strumento culturale atto a comprendere nella maniera migliore, che è sempre quella di far parlare i documenti, chi fu Telesio Interlandi e i tanti scrittori e artisti che bazzicarono attivamente i suoi giornali, dai «Quaderni del Lunario Siciliano», diretti insieme a Federico Lanza, emanazione diretta del periodico «Lunario Siciliano» (1927- 1931), animato insieme a Giovanni Centorbi e Stefano Bottari e luogo topico degli scrittori siciliani che orbitavano su Roma, allo spregiudicato «Il Tevere», voluto da Mussolini nel ’24 insieme a Franco Ciarlantini giudicato da Indro Montanelli “il giornalaccio del fascismo più bieco”, e fino a «Quadrivio», fondato nel ’33. Un volume, quello di Mughini, a suo modo altrettanto maledetto e scomparso quasi subito dalla circolazione, e che ebbe inoltre un peso nefasto sulla carriera e sulla biografia del giornalista catanese, a pesare su di lui come un marchio d’infamia per aver osato addentrarsi nella biografia intellettuale di Interlandi a volerne tirar fuori qualcosa di buono (eccome se ce n’erano di cose buone nell’attività culturale centripeta svolta dal giornalista siciliano nella Roma città aperta). Ricorda Mughini: «Interlandi era stato al crocicchio della cultura romana degli anni Venti e Trenta e finché non accettò di dirigere “La difesa della razza”, l’ignobile quindicinale che Benito Mussolini aveva voluto a sostegno delle leggi razziali.
Da quel momento il nome di Interlandi è diventato impronunciabile.
E tale è rimasto pur dopo la pubblicazione del mio libro, un libro per il quale a mia volta venni maledetto. Si, me ne ha creati di problemi. Ero arrivato sul tema e sul personaggio in anticipo sui tempi. Oggi i libri sui fascisti assassinati e straziati dopo il 25 aprile 1945 sono in testa alle classifiche». Da allora pochissimo altro si è scritto su Interlandi e, sarà un caso, solo da studiosi stranieri.
Il giornalista più potente e ascoltato del suo tempo venne arrestato il 26 luglio del 1943 e rinchiuso nel carcere militare di Forte Boccea; liberato dai tedeschi nei giorni successivi all’8 settembre, pochi giorni dopo, il 12, venne condotto in Germania. Poco dopo rientrò in Italia aderendo alla Repubblica Sociale Italiana, che gli aveva affidato la propaganda a mezzo stampa e attraverso trasmissioni radiofoniche: durante quei tragici mesi Interlandi riceveva sul lago di Garda le intercettazioni delle trasmissioni radio nemiche, che il MinCulPop gli forniva, e scriveva i testi da trasmettere attraverso le stazioni radio ascoltate nei territori dell’Italia occupata. Venne poi di nuovo arrestato a Brescia nell’ottobre del ’45 ma riuscì fortunosamente a eludere il carcere, nascondendosi per otto mesi grazie all’aiuto dell’avvocato socialista Enzo Paroli («un socialista convinto e onesto», secondo Cesare Interlandi), reduce tra l’altro delle carceri repubblichine, vicende oggetto dell’interesse di Sciascia, e che Vitale mise poi nero su bianco.
Dopo l’amnistia del ’46 Interlandi visse a Roma come un morto vivente, dimenticato da tutto e da tutti, fino alla morte, il 20 gennaio del ’65. Poco prima aveva realizzato un’autoedizione assai dolente, rievocativa della sua storia personale e «rapsodia di una generazione», finita di scrivere nella sua casa di Taormina (la ‘villa del fascista’ com’era conosciuta) nel novembre del ’60, affidandone le poche copie stampate, (oggi molto rare) al libraio romano Tombolini, che per amicizia e compassione accettò, perché riuscisse a venderne qualcuna. E chi avesse voglia (e la fortuna, considerata la rarità del librino) di leggere quelle poche pagine rischierebbe di comprendere come a volte sia forse preferibile guardare in faccia la realtà, e gli uomini, per quanto terribili e maledetti possano essere stati entrambi, anziché anteporre a essi il solo, beffardo «silenzio, prudente e necessario» invocato da quell’anonimo articolista citato all’inizio: «Sono quindici anni. Da quando mi è scivolata di mano la penna sono trascorsi quindici anni. Quindici anni di solitudine e di silenzio. Che ho fatto? Nulla. Vi è, tra quel giorno ed oggi, una sterminata distesa di tempo, grigia, uniforme, sulla quale galleg-giano numerosi fogli di carta bollata», così principia il libretto-testamento di Interlandi, quella penna scivolatagli di mano allo stesso modo di quel foglio, giusto vent’anni prima, recluso a Canton Mombello:«Telesio tentò di riprendere in mano il foglio, ma invano. Gli era scivolato da qualche parte, in qualche angolo oscuro. L’avrebbe ritrovato l’indomani, al levar del sole. Il sonno lo colse mentre fantasticava sulle parole che vi erano scritte e che ora giacevano in terra, come una cosa morta. Custodite soltanto dal buio»
Una sterminata distesa di tempo, grigia, uniforme, compatta, la stessa, identica, che c’è tra quel 15 gennaio del 1965 e oggi; dopo cinquant’anni nulla di quella solitudine e di quel silenzio è cambiato, nessuna compassione attuata, nessuna pacificazione con un passato che non passa; ritorna, inalterato e simbolico, il rifiuto del dott. Belardini a curare Cesare Interlandi, che Sciascia/Vitale dilatano fino a contenere l’eterno, immutabile «trionfo della violenza»: «Veniva infatti così celebrato, per via d’un uomo qualunque, d’un oscuro medico di provincia, l’ennesimo trionfo della violenza. Una violenza sottile, esperta, sapientemente nutrita di disincanto, di pazienti, sofferte attese; dal sapore da millenni inalterabile, che non scolora anche se è violenza che ribatte a violenza, sopruso a sopruso; ma che anzi alimenta e si alimenta di raffinatissime spirali di sopraffazioni, di inganni. Morti che seppelliscono altri morti, ferite che leniscono ferite: ecco il genio di secoli di storia, il puro distillato di decine di civiltà…». Quel Telesio Interlandi, colui che fu il più potente e ascoltato giornalista del suo tempo, resta maledetto, fantasma innominabile, reietto. Un nome da cassare anche dopo 50 anni. E ancora resta inascoltato l’appello che il figlio Cesare inviava a Sciascia in quella lettera del 23 luglio 1982, dove auspicava che finalmente si riuscisse a togliere dal padre l’ambigua cappa calatagli sopra dai «sedicenti intellettuali dell’antifascismo post- liberazione, da chi non ne ha mai saputo niente e ricicla “sentenze”».
Un auspicio rimasto inascoltato, allora come oggi.
Da “La Biblioteca di via Senato”
© Riproduzione riservata