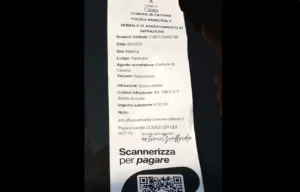L'uomo, il magistrato, l'intellettuale
di Redazione


Scicli – Non ha creduto alle sue orecchie il responsabile della segnaletica stradale del Comune di Scicli quando un giorno del 1998 il giudice Severino Santiapichi si qualificò al telefono per rappresentare che la strada del quartiere Gesso, intitolata a suo padre Saverio, era stata reintitolata -durante una ripitturazione e quindi per errore- a lui, figlio, diventando così la “via Saverio Santiapichi”, una inattesa “via Severino Santiapichi”.
“Guardi, signore, sono ancora vivente, e vedermi omaggiato in una via, mi fa un po’ impressione”.
L’equivoco fu presto risolto con un colpo di pennello, che restituì al padre Saverio il giusto onore, e sollevò il figlio Severino dall’imbarazzo di tanta gloria in vita.
Severino Santiapichi è morto sabato 17 settembre alle sei del mattino, 90 anni compiuti quattro mesi fa, dopo un periodo di clausura in casa confortato dai libri, lo strumento che gli consentiva di viaggiare, incontrare mondi e persone, di vivere.
Un uomo amato. Dai suoi concittadini per una dote, tutta sciclitana: la capacità di sorridere anche della morte. Perché nel relativismo dello sguardo di questa città che gli ha dato i natali c’è molto della sua filosofia di vita.
Figlio di un intellettuale, Saverio, cultore di storia locale, segretario dell’Opera Pia Busacca e dell’ospedale che di quel benefattore porta il nome, Severino studiò legge continuando a nutrirsi di cultura popolare, fatta di aneddoti, tipi umani, personaggi di un’epoca, quella dei primi del Novecento, che lui ha contribuito a recuperare.
Come? Scrivendo. Libri, romanzi, articoli di giornale, collaborando con le testate locali, mai risparmiandosi rispetto all’appuntamento con la memoria e la scrittura. Unica salvezza per un mondo che gli spariva dall’orizzonte ogni giorno di più.
A Scicli tutti ricordano i suoi anni ottanta, le tre Alfetta bianche che lo scortavano nei repentini ritorni dalla Capitale, dove le telecamere della Rai lo inquadravano tetragono, impassibile, davanti alle Brigate che avevano ucciso Aldo Moro o all’arabo Alì che voleva uccidere Giovanni Paolo II.
Lui non si negava. Ai compagni di infanzia, alle persone umili, a tutti. Nessuna boria, nessuna presunzione, nessun atteggiamento vip.
Era umile fra gli umili, giurista fra i giuristi, intellettuale fra gli intellettuali, ma sempre riconoscibile come “Severino”. Uguale a se stesso nella diversità di ruoli, come gli attori che fanno la storia del cinema, che cambiano personaggio, restando se stessi, Santiapichi ha interpretato la sua dimensione sociale, pubblica e privata, con una gentilezza antica: “Vorrei mi aiutasse a capire”, chiedeva agli imputati, con l’umiltà di chi vuole ascoltare le ragioni dell’omicida, avendone rispetto dell’interlocutore come persona, per quanto reo.
In Somalia gli hanno chiesto di scrivere la loro Costituzione, e da raffinato uomo di legge Severino creò l’architettura istituzionale di quel paese, poi entrato nelle sue vene e nelle sue opere letterarie.
Ma chi era Severino Santiapichi? Se “Le Mille e una Notte”, nel Quattrocento, avesse avuto un unico autore, Santiapichi sarebbe stato tra i maggiori sospettati. Perché sua era la capacità di narrare, senza soluzione di continuità, fatti storici, novelle, incontri, episodi di vita, questioni giuridiche, processi, memorie familiari, come misteri del Rosario, uno dopo l’altro.
Millimetrica. Era la sua memoria. La sua prosa così naturale che sembrava leggesse, tanto perfetta la declinazione del racconto, senza sbavature, eppur improvvisato.
Nulla di ciò che è umano gli è stato estraneo. Perché alla fine la sua era una ricerca del sapere e del vero, sforzo vano quanto appassionante.
“Penso di avere saldato una parte del debito, ho chiuso il conto con la Scicli della mia infanzia quando le dedicai un intero romanzo”, diceva nel dicembre del 2005.
“Quando scrissi “Romanzo di un paese” ho saldato il mio tributo alle persone di Scicli verso le quali avvertivo un debito formativo”.
“L’altro debito da saldare era con la Somalia. Ho portato a termine un romanzo, una sorta di giallo africano, una vicenda intricata, con risvolti che investono il mestiere di giudice e quello di imputato. Del resto anche fare l’imputato, a volte, è un mestiere: faccia caso alle persone recidive o ai delinquenti professionali…Tornando a Scicli, oggi il mio rapporto con il paese è spassionato, non è viziato dalla passione come in passato. Scicli per me non è mai stata Itaca”.
“Non appartengo a quella schiera di siciliani che, vivendo a Roma, consideravano una parentesi vuota la loro vita nella Capitale, apprezzando come vero solo il loro stare qui. Ricordo le comunità di sciclitani alla stazione Termini che la domenica mattina aspettavano l’arrivo del treno con i paesani che portavano un po’ d’aria di Scicli. A Roma ho vissuto la mia vita romana, portando dentro la stessa formazione culturale di cui parla Quasimodo quando ringrazia la madre dell’ironia che gli ha messo sulle labbra”.
Perché Severino Santiapichi scrive? “Forse per farmi compagnia, per dare testimonianza. Anche da giudici, siamo sempre testimoni”.

E che mestiere è quello di giudicare? “Nel libro ambientato in Somalia racconto di un giudice che ritiene che il suo mestiere si possa definire con l’assillo del sarto che prima di cucire un paio di pantaloni voleva sapere dai clienti dove portavano i coglioni, se sulla destra o sulla sinistra. Questo impicciarsi dei coglioni degli altri è il mestiere del giudice”.
© Riproduzione riservata