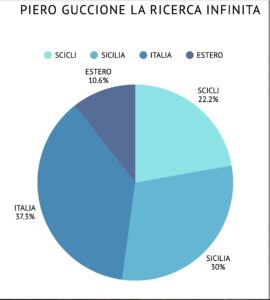Silvana Grasso su La Sicilia
di Silvana Grasso
Come ne La Pietà di Michelangelo Maria accoglie nel suo grembo di madre la carne flagellata del figlio morto, e l’emozione grande di madre cancella persino la fredda inerzia del marmo, così Papa Francesco accoglie, nel suo grembo di Padre, Amatrice, la città morta, ma viva ancora negli occhi di chi ricorda implora prega spera, ora e sempre, nell’impossibile resurrezione d’una madre d’un figlio d’un fratello d’un amico d’un bambino d’una nonna d’un nonno, che morti sono solo per la muta anagrafe dei vivi.
Possono, anzi devono, invece, essere vivi, almeno nella resurrezione dell’amore, almeno nella suggestione di ricordi scolpiti nella carne dell’anima che non muore mai, che non marcisce mai. Tra la Pietà di Michelangelo e la Pietà di Francesco, la Pietà di una donna senza nome, senza talento eccezionale d’artista o di santa, una donna d’Amatrice, una tra le tante donne d’Amatrice, «Pietà» che veglia ruderi, veglia memorie, veglia odori, veglia macerie che furono case, che furono chiese, che furono sogno, eco di bimbi, canti di sposa, sacri congedi da canuti amati padri, da canute amate madri. Congedi di natura che non destano orrore alla prosa della ragione, che non destano orrore all’elegia del cuore.
Il Santo Padre veglia sulle macerie d’Amatrice, opera d’uomo e d’una Natura «nel voler matrigna», ma maceria è ovunque in Italia, anche per chi non ha tremato assieme alla sua terra quel 24 agosto. Ovunque guerre senza cannoni, senza trincee, senza soldatini al fronte, guerre senza eroi moribondi con rosso papavero di sangue, fiorito sul petto che annaspa.
Guerriglie di chi non ha sentimento vero di patria né ideali, guerriglie combattute proclamando inchieste che sottendono minaccia «In tremila pagine i nomi di collusi alla Regione» (Crocetta, presidente della Regione). Guerriglie di ordinaria e straordinaria corruzione (Truffa all’Inps, falsi i braccianti, falsi i terreni), in cui non mancano banditori d’immortalità «Nessuno mi rottamerà» (Miccichè, commissario regionale di Forza Italia), né mancano duellanti alla riconquista della roccaforte perduta (Grillo e Davide Casaleggio s’accaparrano il cadavere del M5s). Nulla di epico, nulla di mitologico, tutto tristemente egocentrato, ovunque si guardi nel tristo e triste odierno panorama di macerie politiche e umane.
Solo macerie là ove un tempo furono ideali, macerie là ove un tempo fu onor di Patria, macerie là ove un tempo furono inni ed epinici. E non ha nulla questa guerriglia della grande Guerra, non la combattono Achille Agamennone Ettore Eracle, eroi del Mito, per cui premio immenso era morire, non vivere con disonore.
Non si combatte per amor di patria e onor di stirpe, come ignoti militi della Storia o noti eroi del Mito, anche quando v’era certezza di sconfitta, perché assai d’una spada e d’un thymòs può il volere d’un dio. Non si cede nemmeno al dolore d’una sacra madre «Gemeva la madre, versando lacrime e, aperta la veste, con una mano sollevava la mammella e gli parlava Ettore, creatura mia, rispetta questo seno, abbi pietà di me, l’uomo nemico al- lontana, stando qui fra le mura, non affrontarlo in duello. Se mai t’uccidesse, ah non potrò piangerti sul cataletto, o figlio, io che t’ho partorito, lontano da noi presso le navi argive ti strazieranno i veloci cani.» (Omero, Iliade, XXII)
Né padre Priamo né madre Ecuba «persuasero l’animo di Ettore. Egli aspettava Achille gigante. Come serpente montano attende l’uomo sopra il suo buco, lo penetra collera atroce, guarda fisso, terribile, arrotolato sopra il suo buco; così Ettore con inestinguibile coraggio non arretrava». (Ibidem).
Non vuole Zeus Padre che perda la sua vita Ettore grande, mentre «lo incalza Achille senza riposo, come un cane sui monti insegue un nato di cerva per valli e gole, dopo averlo snidato».(Ibidem)
Nulla ha l’infame guerriglia d’oggi della Guerra che visse «Il soldato morto», nei versi scarni lapidari d’un poeta del Novecento, Libero de Libero «Sono morto sul campo d’ottobre/e mi coprì la facile terra come un seme a lei tornato./Era cielo di mezzasera/dopo la pioggia e piovere dovrà/e io finivo inutile soldato. Era un prato di zolle lamentose/e la mia man vidi cadere/come ultimo frutto da un ramo:/quanti volti dal sangue coperti/come rapidi fazzoletti».
Non ha nome il soldato morto, è solo uno dei tanti morti su un prato di zolle o ai piedi d’una collinetta, morti al tramonto, o morti all’alba, il volto insanguato, disumano. E’ ignoto questo milite, ignoto come tanti altri ignoti, morti senza capire perché la combattessero la guerra «Dove si va? Per chi si muore? O futuri, notizie non avrete di mese la mia morte non v’è nota», morti senza diatriba, morti senza ribellione, morti senza risposta
La morte del soldato è la morte di tanti soldati morti, lui stesso contempla la sua morte, quasi fosse la morte d’un altro, nella mano che declina, nella sua vita che si genuflette e cede alla morte che avanza come un albero nuovo «La morte era un albero nuovo/ all’orizzonte colore di sale/era un appello di nomi marciti./ Male faceva la vita passata/e o sbagliavo il nome di Dio/».
Nello scrimolo angusto tra vita e morte anche «la vita passata», il grumo di ricordi felici, fa male, è una ferita che non cicatrizza, e nemmeno Dio ha parole per chi morire non vuole, non è tempo di morire per un ragazzo vestito da soldato.
Invoca la dea Afrodite la poetessa Saffo, respinta in amore. Il suo aiuto chiede, la sua forza implora. E velo- ce attraverso il cielo giunge a lei la vindice dea amica. Ma questo Dio è altro che un dio del Mito.
Muore in solitudine e in Guerra il soldato «assassino senza ragioni/ numero tra numeri in fila….io morivo soldato a nessuno nemico/ e mi dicevo, amico mio,/ tu non hai visto il morto soldato/ non mi puoi ricordare/se non m’hai visto morire./ Fratelli, non sapete la mia lite con Dio.» (Ibidem).
Muore, testimone unico dell’inu- tilità della sua morte «e fui niente per essere soldato», che “filma” per similitudini «allora dal cielo una voce cadde come foglia», per suoni «del mio nome l’eco gridata/ tornò alle mie labbra murate», firmandone una regia anonima intensa accorata indimenticabile.
© Riproduzione riservata