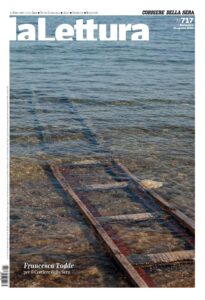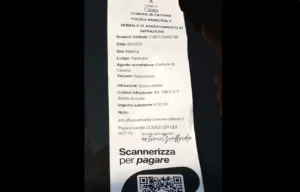La stesura del testamento di Vincenzo nella notte fu lunga e complessa
di Un Uomo Libero.
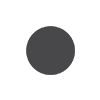

Scicli – Il 25 agosto 1623 vj Ind. poco dopo mezzanotte, ora d’Italia, in una stanza discretamente illuminata (tribus luminibus accensis), Vincenzo Miccichè cominciava a dettare il suo testamento.
Erano presenti il Protomedico della Contea di Modica Dottor Barbaro de Arizzi, Don Francesco Carrera, Fabiano de Arizzi, Don Pietro de Abbattista, Vincenzo Passanisi e Battista Li Favi.
Vincenzo, di appena ventitré anni, giaceva sul suo letto di morte, il viso pallidissimo quasi terreo, lo spirito tuttavia ancora lucido e presente.
In un angolo Giuseppe Miccichè, il padre, disperato.
Il notaio pietosamente annotava le sue ultime volontà.
Come in tutti i testamenti dell’epoca, anche in questo la premessa era d’obbligo: si testava per lasciare questo mondo in pace con la propria coscienza, perché la morte è certa ma non è dato sapere agli uomini l’ora del morire.
Vincenzo restituiva all’altissimo e immortale Dio e alla beatissima sempre vergine Maria, sua madre, l’anima che gli era stata data e che raccomandava a San Guglielmo, il santo protettore della città di Scicli, a san Carlo Borromeo e a tutti i santi del paradiso.
Voleva che il suo corpo fosse sepolto nel “cappellone” della chiesa di san Bartolomeo di Scicli in un sepolcro da scavare nella nuda terra come i confrati della chiesa gli avevano promesso. Ai piedi della sua sepoltura desiderava che fosse posto un quadro raffigurante san Carlo Borromeo.
Lasciava erede universale il padre Giuseppe al quale chiedeva di far celebrare alcune messe in remissione dei suoi peccati tra cui una in giorno di venerdì e l’altra in giorno di sabato.
Dopo queste iniziali disposizioni, Vincenzo istituiva tutta una serie di legati in suffragio della sua anima:
– 100 onze per la fabbrica della chiesa di san Guglielmo (= leggi san Matteo) di Scicli da scorporare “una tantum” dai beni ereditari e altre quattro onze per la costruzione dei “dammusi” addossati alla scarpata della collina di san Matteo sottostanti alla chiesa (dopo il terremoto del 1693, l’arciprete Carioti a sue spese farà ricostruire questi locali che erano stati molto danneggiati; alcuni anni fa sono stati anche restaurati) da consegnare in contanti a Vincenzo Carrera, soprintendente alla fabbrica del Duomo di san Matteo di Scicli.
– Alla Congregazione dell’Immacolata Concezione di Maria con sede nella chiesa di sant’Andrea di Scicli venti onze da destinare alla fattura di un vessillo nel quale fossero dipinte le immagini da un lato dell’Immacolata e dall’altro quella di san Carlo Borromeo.
– Ai Padri Agostiniani del convento del Salvatore di Scicli un censo annuale di quattro onze corrispondente a onze quaranta di capitale.
– Alla chiesa di san Pietro di Modica quaranta onze “una tantum” in contanti “pro fattura”.
– Al monastero di san Benedetto di Modica onze quaranta da impiegare in arredi sacri e per accrescere la devozione al Santissimo Sacramento dell’Eucarestia.
– Alla chiesa di santa Maria delle Grazie di Modica onze quaranta da corrispondere in contanti al canonico don Francesco de Assenzo per le necessità del tempio.
– Al convento di santa Maria del Carmelo di Trapani onze ventiquattro.
A questi legati, seguirono altri legati riguardanti congiunti o conoscenti e amici:
– Alle zie Anna, Antonia e Vincenza Miccichè legava la domestica Antonina Casinatizia.
– A Guglielmo Pagano figlio di Antonuzzo onze quaranta “una tantum” e tutti i suoi vestiti privi però degli adorni in oro che contenevano.
– Ad Antonio Devoto onze dieci “una tantum”.
– Al dottore in ambedue le leggi Francesco Arrabito una somma per farsi confezionare un vestito a lutto.
– Stessa disposizione per il canonico don Francesco de Assenzio.
– Ad Antonello Pagano due salme di frumento l’anno, vita natural durante.
– A Guglielmo e Antonello Miccichè un censo annuale di dieci onze.
– Agli eredi del Barone don Giuseppe Paternò, suo suocero, onze duecento venti circa ricevute in dote all’atto del matrimonio con Beatrice per capitoli matrimoniali celebrati nel dicembre del 1611.
– Alla moglie Beatrice Paternò seicento onze “jure antifati et virginitatis” e in più tutti “i vestimenti di qualunque sorte chi siano cossi festivi come quotidiani fatti per ditto testatore per servitio di detta Donna Beatrice”. Le lasciava anche una scrivania d’ebano e tutta la biancheria che il testatore possedeva al momento del suo decesso.
Al padre Giuseppe, nominato come già detto erede universale, raccomandava di dare esecuzione ai legati e di disporre dei suoi beni “pro operibus pijs et spiritualibus” secondo coscienza in suffragio della sua anima e di quella del nonno materno Giuseppe Melfi che glieli aveva in parte lasciati.
Indicava, comunque, l’opera pia e spirituale alla quale avrebbe tenuto forse di più. Dedotte dal suo asse ereditario tutte le spese, eseguiti tutti i legati, Vincenzo suggeriva, infatti, al padre di destinare le somme residue “pro edificatione et constructione unique collegij patrium Societatis Jesus… in hac preditta civitate Siclis…”.
Il testatore enumerava, poi, diverse operazioni finanziarie (gabelle) da lui eseguite o ancora in sospeso ricordando i nomi dei contraenti di esse e di ognuno l’eventuale debito.
Liberava il padre dall’obbligo di non vendere i beni nel caso fortuito in cui questi fosse stato perseguito per qualche motivo dalla giustizia e avesse avuto bisogno di liquidità per difendere nelle sedi opportune il suo onore.
Revocava tutte queste disposizioni nel caso in cui Beatrice, la moglie, si fosse scoperta incinta dopo la sua morte e gli avesse partorito un erede.
Queste ultime due clausole erano ricorrenti e quasi obbligatorie nei testamenti dell’epoca.
Ordinava, infine, il pagamento di dodici onze al notaio che aveva rogato l’atto quale suo onorario.
La stesura del testamento di Vincenzo nella notte fu lunga e complessa. La immagino estenuante per un giovane privo di forze arrivato inesorabilmente al capolinea della vita.
E ancora più straziante sarà stato per il padre ascoltare le sue ultime volontà sussurrate quasi con un filo di voce.
Vincenzo Passanisi, l’uomo che avrebbe occupato il posto di Vincenzo nel cuore di Giuseppe Miccichè, era presente quasi a voler raccogliere il testimone.
Vincenzo Miccichè, lo sciclitano coltissimo, lo spirito illuminato, il figlio unico di una giovane madre, Anna, che troppo presto lo aveva lasciato, si congedava dalla città e dal mondo in un’alba afosa che avrebbe rubato per sempre il sole ai suoi occhi.
Anna Melfi aveva sposato Giuseppe il 16 aprile vj Ind. 1598 in Santa Maria la Piazza. Inspiegabilmente è assente negli ultimi istanti di vita del figlio. Forse Anna era presente nel ricordo del nonno Giuseppe Melfi, amatissimo, sul quale il bambino riversò tutto il suo affetto materno.
L’Immacolata Concezione di Maria, la grande devozione al Protettore della città di Scicli san Guglielmo e a san Carlo Borromeo (il grande sostenitore delle tesi del Concilio tridentino), fanno di Vincenzo un convinto fedele della Controriforma.
Come ho scritto nel saggio “L’ultimo vero testamento di Giuseppe Miccichè, siclensis” apparso su questo giornale “on line” Ragusanews l’8 maggio 2019, Vincenzo con il suo testamento rispondeva positivamente all’urgenza e alla moda del tempo che richiedevano la presenza di un Collegio della Compagnia di Gesù in un centro importante com’era allora Scicli nella Contea di Modica ma non andava più oltre questa pia intenzione.
Sarà Giuseppe, il padre, a pretendere delle vere e proprie cattedre di istruzione popolare dai Padri Gesuiti, nominati eredi della sua immensa fortuna, per una pena che tuttavia lo consumava e per la quale cercò di “strafare”, interpretando estesamente i desideri del figlio.
La storia dei Miccichè che sto raccontando non finisce qui.
Le mie ricerche hanno ancora molte altre sorprese da raccontare che finalmente ci aiuteranno a tracciare una vera saga di questa importante famiglia sciclitana.
Rimando, dunque, i lettori interessati a una prossima puntata.
CREDITI
Archivio Chiesa Matrice di San Matteo Apostolo Scicli
Archivio Chiesa di S. Maria la Piazza Scicli
Archivio di Stato di Ragusa, sezione di Modica
Archivo Histórico Nacional
Carioti Antonino, Notizie storiche della Città di Scicli, ed. a cura di Michele Cataudella, vol. I e vol. II, Comune di Scicli, 1994
© Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei contenuti del presente articolo. Ogni loro eventuale citazione è subordinata all’autorizzazione previa dell’Autore.
© Riproduzione riservata