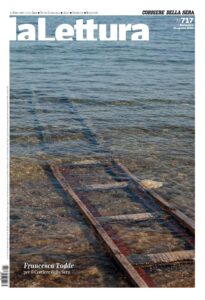Il mistero della sua sepoltura e le vicissitudini del suo quadretto di rame
di Don Ignazio la China


Scicli – Nel luglio del 2007 accettai l’invito fattomi da parte dell’Arciconfraternita di Santa Maria la Nova, di comunicare, in occasione di questa celebrazione del 440° anniversario della morte di Pietro di Lorenzo, di comunicare, in un convegno tenutosi nella chiesa di Santa Maria La Nova, i risultati delle mie ricerche sulla morte e la sepoltura del benefattore insigne della nostra città, compiute nell’Archivio dell’Opera Pia Busacca e in quella della stessa Arciconfraternita.
Il patto era che dovevo stare attento ad ogni possibile segnale per cercare di riuscire a comprendere qualcosa in più sul mistero della sepoltura di Pietro di Lorenzo alias Busacca.
La conferenza tutta fu poi pubblicata sul mensile Dibattito.
Qui mi limito a riprenderne la parte che interessa direttamente il mistero della sua sepoltura e le vicissitudini del suo quadretto di rame.
Pietro di Lorenzo si ammala a Monreale agli inizi del luglio 1567 e verso la metà o verso la fine dello stesso mese in un’età tra i 67/77 anni, secondo alcuni autori già nel Convento dei frati minori (ma dove abitava? Abitava coi frati? Era scapolo: era forse un terziario? Anche questo è un mistero da risolvere).
Ai primi di agosto dunque si pubblica il testamento e il giorno 8 agosto 1567 si passa a fare l’inventario dei suoi beni alla presenza del Procuratore della Confraternita di Santa Maria la Nova.
Busacca, infatti, fra le altre cose, stabilisce che la confraternita della chiesa di Santa Maria la Nova di Scicli sia la sua erede universale; e che nel giorno della festa del Titolo della Chiesa (cioè la Natività di Maria, ogni 8 settembre) si faccia la elargizione dei legati di maritaggio e/o di monacazione e che per Natale e Pasqua si faccia l’elargizione delle elemosine per i poveri, oltre a lasciare un legato per il riscatto di suoi parenti caduti in mani ai saraceni e a tanti altri legati minori.
Già il 2 luglio 1565 aveva fatto testamento a Palermo, sicuramente nello stesso convento di Santa Maria degli Angeli, dove vorrà essere sepolto, perché i testimoni presenti e che firmano davanti al Notaio sono tutti Frati minori osservanti. A questi frati lascia perciò un legato per il funerale e un altro legato ai fidecommissari ed esecutori testamentari per il suo obito.
In cambio lui vuole che il suo corpo“sia sepolto qua in palermo loco depositi inla venerabili ecclesia de lo venerabili convento de sancta maria deli angeli de palermo: Et che dapoi infra dui [altri leggono ‘dieci’ ma è più verosimile ‘due’] anni se habbia a portare in la detta terra de xichili et sepelliri in la ecclesia dela venerabili confraternita de sancta maria dila nova dela ditta terra de xichili;” stabilendo “che in ditta ecclesia de ditta venerabili confraternita de sancta maria dila nova dela ditta terra de xichili si habia de celebrari per la salute della anima mia et in remissione dei mei peccati una missa ogni jorno perpetuamente”
Qui però comincia il mistero perché, a parte il fatto che lui mai in nessun luogo dice di essere un confrate, specificando il luogo della sepoltura a Santa Maria la Nova, afferma che vuole essere seppellito “intro una cappella, non chi essendo cappella dela casa delaurenso [cioè in una qualunque cappella della chiesa qualora non ci sia una cappella della famiglia Di Lorenzo] “et essendoci cappella dela casa delaurenso in ditta ecclesia si habbia a fare sepelliri intro ditta cappella dela ditta casa delaurenso”.
Questo significa che il nostro Pietro all’atto di fare testamento non sa se a Scicli, nella chiesa cui lui e la sua famiglia sono legati per tradizione (sicuramente anche perché abitanti in quel quartiere) ci sia una cappella della sua famiglia!
Può essere che nei venti-quarantanni in cui lui è stato a Palermo non sia più venuto a Scicli o comunque non sia rimasto in contatto con nessuno della sua famiglia a Scicli, così da essere aggiornato se la sua famiglia era riuscita a edificarsi o no una cappella (e questo significa anche la cripta sotto la cappella per la sepoltura dei familiari) nella chiesa di Santa Maria la Nova?
A meno che non si debba leggere fra le righe del testamento e pensare che il suo andare a Palermo dai parenti in cerca di fortuna non abbia significato anche la rottura con il resto della famiglia rimasta a Scicli e che poi i legati testamentari alla propria famiglia non significhino anche un modo per riconciliarsi con questa e un farsene carico sollevandone le sorti con la ricchezza procuratasi a Palermo. In fondo, come abbiamo già detto, se erede è la confraternita (che gestisce la chiesa di Santa Maria la Nova), in realtà i veri beneficiari diretti sono i suoi parenti!
Comunque sia, conosciamo le complesse vicende tra Confraternita e autorità pubblica per la gestione dell’eredità che spuntarono subito dopo la sua morte e nei primi anni dopo: questo sicuramente portò, se non a dimenticare il fatto della successiva traslazione del corpo a Scicli per la sepoltura definitiva, almeno a rimandarlo.
Ci vorranno più di trentanni perché se ne riparli e si passi all’impegno di voler dar seguito alla volontà del Busacca.
Seguo la cronaca degli eventi così come la si può evincere dal registro degli esiti e dal parallelo giornale mastro degli anni dal 1600 in poi [Archivio Opera Pia Busacca – Registro esiti (già 608 e registro ex 610) e Registro II – Cautele (già III/153/268)]:
– 2 maggio 1600: Procuratore Vito Trapanisi. Fabbrica dela cappella nell’ecclesia di Santa Maria Lanova di Xicli…unci cinquanta … pagate a’ Petr’Antonio Giluso al quale se li pagano ad effetto di quelle pagate in detta terra di Xicli a’ Ant.o Trumbatore alias Corvo Thesoreri di detta confraternita in presentia et con intervento et consenso deli Rettori di essa et delli procuratori della fabbrica dell’istessa chiesa et che detto Thesorero non possi spendere ne’ inaltro uso convertere se non per la construttione dela fabbrica di detta nova cappella cominciata nela suddetta chiesa con li medesimi intervento et consensu deli sudetti Rettori et procuratori et diloro ordine et mandato et non in altro modo nela quale cappella con l’aggiuto divino s’haverà di seppellire il corpo di detto quondam Pietro di Lorenzo iuxta la forma del suo testamento fatto in atti del quondam notaio Giuseppe La Rosa a’ 21 luglio 1565 et questo stante una fede de li giurati di detta terra di Xicli per la quale consta che in detta chiesa non v’è cappella de li laurenzi a’ 7 di marzo passato…
L’annotazione è importante perché ci dice che il 7 marzo 1600 (cioè 33 anni dopo la sua morte) il corpo di Busacca è ancora a Palermo e si giura che non c’è cappella della famiglia di Lorenzo a Scicli (si noti che l’attestato è fatto dai Giurati: e in ogni caso i confrati non avrebbero potuto imbrogliare perché da Palermo fin dall’inizio e poi periodicamente – una/due volte l’anno si veniva a ispezionare i lavori fatti e da fare: ad esempio si trovano diverse annotazioni per spese di viaggi da Palermo a Xicli l’ispettore Giacalone per sorvegliare i lavori della cappella ).
L’occasione per la costruzione della cappella è data dal fatto che in quegli anni (dalla fine del ‘500) si sta operando un ampliamento della chiesa e una ridefinizione di cappelle e altari (ricordiamo che nel 1564-1565 si costruisce la Cappella del Sepolcro di Cristo con le 14 statue lignee del Monachello).
Comincia così un complesso lavoro per l’erezione e la decorazione della cappella, lo si intuisce dalle scarne ma significative note spese:
Ð 17 marzo 1601 altre onze 50;
Ð 7 agosto 1602 altre onze 50;
Ð 20 marzo 1604 altre onze 50;
Ð 17 giugno 1606– diventa procuratore Marc’Antonio Giluso – altre onze 60;
Ð 19 dicembre 1607 altre onze 60;
Ð 6 febbraio 1608 altre onze 40;
Ð 1 maggio 1608 altre onze 100;
Ð 22 ottobre 1612 – altre onze 60;
Ð 1613 – altre onze 288;
Ð 5 aprile [spesate]/ novembre [pagate] 1616 onze 20 per vesparo della Cappella del quondam Pietro e riparare la cappella che piove e minaccia rovina (e qui cominciano i secolari guai strutturali della cappella!): dobbiamo pensare la chiesa non al livello attuale ma ad uno più in basso, con il retro dell’abside in diretto contatto con il letto del torrente che scendeva dalla cavuzza di San Guglielmo così che spesso ogni inondazione finiva per scalzare le fondamenta dell’abside. Il terrapieno attuale risale all’ultima sistemazione ottocentesca.
Ð lunedi 26 marzo 1618 – altre onze 200 per la fabbrica e unzi 35 del giudice protettore Leonardo Miraglia inviate a 24 del presente mese ad Antonio Damiata… per prezo di quelle tre casi comprati per li rettori cioe una da Violante Barbarello e altri dui da Antonuczo Giarratana per la ca…(?) in uno atto mand…fatto per detti rettori in detti atti a 29 di gennaro 1612 quali foro aggregati con detta cappella per servizio di detto quondam Petro di Lorenzo.
Nota importante per la nostra ricerca è quella che segue:
“ venerdi 6 aprili 1618 – alla detta (confraternita) onze quaranta per vertu di mandato inscrittici fattani il dottor Leonardo Miraglia giudice e protettore delle cause di detta confraternita registrato negli atti della Corte di cause delegate a 4 del presente a mastro Vincencio Guercio contanti dissiro se li pagano come a mastro marmoreo per la fabbricazione del tumulo nel quale s’ha da riponere il cadavere di detto quondam Petro di Lorenzo fabbricato di marmo con l’arme e d’altri et anco per le spese fatte nel casciarizzo dove e riposto detto tumulo.”
Ma ancora più importante è la spesa seguente:
“giovidi 26 aprili 1618 – onze 12 a Francesco Sarmento Procuratore…per il ritratto di detto quondam Pietro di Lorenzo da fabricarse e mettersi nel suo tumulo quanto anche per nolo et altre spese da farsi per la portatura del tumulo marmoreo da questa città in la terra di Xicli.”
Il tumulo doveva ricordare, credo, quelli dei Miccichè, con la differenza dell’inserimento del quadro del Busacca mentre in quelli dei Miccichè c’è il busto marmoreo.
Chi è l’autore del quadro del Busacca? Forse l’autore di tutte le altre decorazioni che poi gli saranno affidate: il palermitano Nicola la Sarda (il Santiapichi, e poi gli altri a seguire, leggono la Tarda, ma se in un registro il cognome è equivoco, nell’altro la chiarezza della scrittura fa propendere per Sarda):
“ lunedi 28 maggio 1618 – onze 24 a Nicola Sarda Pittore pagate dalla presente tavola in conto della pittura per esso fatta della Cappella del detto quondam di Lorenzo in Xicli fatta e spedita a ditta Cappella”.
Completato il tumulo di marmo si pensa a trasportarlo a Scicli (la data uguale alla precedente fa pensare che forse tumulo e quadro saranno stati spediti insieme:
“ lunedì 28 maggio 1618 – a Patron Jacopo Bonasia [Bonaria?] disse onze 7 per suo nolo per portare con la sua barca il tumulo di marmorea di detto quondam Petro in Siragusa e poi per detti rettori (??? parola illeggibile) che si manda in Xicli ad effetto di metterci il corpo di detto Laurenzo e onze 1 per li spesi per portarlo alla marina in sino a detta barca e per suo atto mandatario fatto in notar Mariano Zapparata a 26 del presente a Nicolao Francia”.
E qui c’è il primo mistero, perché di questo tumulo non si parlerà più in modo specifico né più si parlerà della sepoltura del Busacca.
Tuttavia sembrerebbe che almeno il quadro e il tumulo sia arrivato e sia stato impiantato perché da questo momento comincia la fase della decorazione della cappella con stucchi e colori.
Prova ne è che il ritratto del Busacca rimase poi esposto nell’aula capitolare.
Se il tumulo comportava il quadro, doveva essere certo un tumulo a parete e gli stucchi certo dovevano servire poi a contestualizzarlo col resto della cappella.
Fatto sta che ora si passa a fare e il resto, ma è da notare che non si parla mai di fare o di rifare l’altare, vuol dire che si lascia quello che già c’è, e questo fatto è importante per quello che diremo in seguito:
“28 novembre 1618 – onze 6 a Mariano Smeriglio Ingegnere per li designi da lui fatti della Cappella maggiore che si ha da stocchiare nella città di Xicli”
Dai disegni alla messa in atto:
“Copia atto presso notaio Trabona di Palermo 29 maggio 1619.
Atto per stocchiare e dorare la Cappella Maggiore e quella cappella dedicata per il suddetto Pietro di Lorenzo Busacca e una e altra parte dell’arco. Il Mastro Accascina si impegna a mettere quello oro che vorranno li Rettori come è nella decorazione della cappella del Beato Ignazio dei Gesuiti di questa città, secondo i disegni dell’ingegner Mariano Smeriglio fatti vedere al Maestro Accascina, entro un anno e mesi sei dalla data dell’atto.”
E poi ancora:
“24 ottobre 1619 – onze 4 a Mariano Smeriglio per il modello e designi fatti e a mastro Antonio d’Accaxina per indrizzare, modellare e aggiustare gli stucchi.”
Da quanto detto intanto si capisce che la nuova impostazione della chiesa è stata pensata in modo che la cappella Di Lorenzo di fatto costituisca un unico complesso con la Cappella Maggiore, poi detta il Cappellone, cioè l’abside della stessa Santa Maria la Nova.
Ma come di fatto era impostata la cappella maggiore? C’è da supporre, anche da altri indizi, una reimpostazione radicale dello spazio, con una variazione dell’altare maggiore secondo i gusti dell’epoca: non più statue ma quadri. Sarebbe stata tolta perciò la statua di Santa Maria la Nova (del titolo della Natività di Maria) di marmo e al suo posto si idea la collocazione di un quadro fatto dipingere apposta a Roma:
“Martedi 7 di gennaio 1620 – onze trenta per tande a Francesco Sarmento ad effetto di cambiarle in Roma et illà far dipingere un quadro della Na(ti)vità di Nostra Donna per la Cappella di Santa Maria Lanova di Scicli.”
Ma come fu predisposta la sepoltura del Busacca nel Cappellone?
Se confrontiamo l’idea di questa sepoltura con quella quasi contemporanea voluta dal Miccichè per se e per il figlio a San Bartolomeo ce ne rendiamo conto: questi nel suo testamento nel 1631 lascia scritta la volontà di essere sepolto lui in cornu evangelii dell’altare maggiore e il figlio in cornu epistolae, dovendosi poi porre sopra la sua tomba il quadro della Immacolata del Cassarino e su quella del figlio il quadro di San Carlo Borromeo.
Questo potrebbe far pensare ad un’analoga collocazione del Busacca in qualità di benefattore illustre, a cui spetta il posto di onore in cornu evangelii cioè a sinistra dell’altare maggiore : nel Cinque-Seicento le due confraternite, nella loro rivalità, costruiscono chiese strutturalmente gemelle: navata unica e due cappelle laterali oltre all’abside, considerato come la cappella maggiore o del benefattore.
Purtroppo di più non riusciamo a dire.
Ma riprendiamo il nostro racconto dal 1620, l’anno della tela.
In ogni caso da quest’anno comincia l’opera decorativa:
– 9 luglio 1620 – onze 100 per fabbrica cappella;
– 18 gennaio 1621 – onze 5 e tarì 4 per bianchetto, ocria, minio et altre robbe consegnate a mastro Antonio d’Accaxina stucchiature della cappella di Xicli;
– (senza data) 1621- onze 50;
– 7 gennaio 1622 – onze 100 per stucchiature al maestro Antonino d’Accaxina per stocchiate e dorare detta cappella;
– 8 marzo 1622 – 1,20 qantara di piombo, rame filato, stagno per finestre, Baldacchino del Santissimo Sacramento, alcuni vasi deorati, altri giugali per l’altare di detta Cappella;
– 13 giugno 1623 – >5.8.10 ad Alessandro Curto: per li palij due palme e due canne di rasone, canne una e palmi 6 di terzanello verde, tende, cera per la festa di Santa Maria fatta nella Cappella;
– 26 giugno 1623 – alli burdunari che portarono da palermo in Xicli due carichi di vitri e due di piombo, candileri, avori, e vasi e fiori di sei casse diversi riposti per servizio della cappella in detta Chiesa onze 5;
12 agosto 1623 – onze 40 a d’Accaxina + 50 nel -1624 + 50;
– 24 dicembre 1627 accolti da Don Francesco Fidone Cappellano della Confraternita, Rettori Nicolao Calvo e Sebastiano Xifo, Leonardo Muraglia e Nicolao la Sarda pittore con due accompagnatori (= 4 cavalli ) a Xicli per ricognizione fabbrica e per vedere la cappella per incarico pittura;
– 23 dicembre 1628 acconto onze 24 a Nicolao la Sarda pittore per pitture da fare in detta cappella + acconti pagati alla moglie in varie rate fino al 1630 di onze 20+40+8+40+6+6;
– 3 gennaio 1629 spese colori stucchi per Accaxina: terra di umbra, minio,ritriglio, verdiramo, gialno, oglio di alberto, oglio di sasso, oglio di spica, azoleto, riaspico,morello, azolo, bianchetto, smaltino, indico, sinagro macinata, alacca, pici greca, terra negra;
– 9 gennaio 1629 spese per pitture cappella (Nicolao la Sarda);
– 3 marzo 1629 onze 150 a Mastro Mariano Francalanza Architettore per sua mercede per farsi il cornicione e sue finiture in detta cappella in Xicli nella chiesa di Santa Maria Lanova;
– 3 marzo 1629 onze 170 a mastro Gioseppe per sua mastria del lanternone di legname di quale s’obbligò fare sopra la cubbula di ditta Cappella e per legnami et altri cosi necessari per detta lanterna;
Questa nota conferma tra l’altro la presenza della cupola nella costruzione secentesca: è quella superbissima cuppola rovinata nel sisma del 1693 di cui parla il Carioti.
La costruzione continua:
3 settembre 1629 – 14 migliara di panelli d’oro per dorare detta Cappella consegnate a Thomaso Carrera di Xicli : onze 40 + 8;
5 settembre 1629 – onze 16 in acconto della pittura di detta Cappella a Nicolao la Sarda;
20 novembre 1629 – onze 30 per stucchi;
13 marzo 1630 – onze 20 a Nicolao la Sarda;
13 maggio 1630 – spese varie per fabbrica e piombo per vetrate onze 5.26.10;
1 giugno 1630 – onze 6 per colori pittori;
7 giugno 1630 onze 30 per 14 migliara di pannelle d’oro (2.24.10 al migliaro) per dorare andati a comprare a Napoli;
12 luglio 1630 onze 8 per colori al pittore;
18 luglio 1630 onze 8 per colori pittori;
19 luglio 1630 onze 4.15 per tela sangallo quale tela serve per coprire il quadro della detta cappella di Xicli;
30 luglio 1630 onze 150 per fabbrica cappella;
22 agosto 1630 onze 30 per pannelle d’oro;
1633 onze 40 per complire la Cappella;
9 gennaio 1634 onze 40 spese acconci e reparationi dell’arco della Cappella;
19 maggio 1634 onze 40 per fabbrica chiesa;
2 dicembre 1634 onze 5.15 per fabbrica chiesa;
23 aprile 1635 – per doratura cappella onze 60;
24 aprile 1635 onze 85 spese fabbrica per ingrandire et imbellire la cappella del quondam Pietro di Lorenzo;
27 aprile 1635 – onze 56 per adorare la Cappella + 60 per fabbrica chiesa;
26 gennaio 1636 onze 22 per adorare Cappella;
6 gennaio 1642 – per panelli d’oro per adorare Cappella.
Ho evidenziato in neretto alcuni fatti credo significativi che ci fanno intuire come la Cappella sicuramente fu aperta al culto (cfr. festa e giogali) e che la chiesa, ormai con l’abside/cappella con cupola e lanternino doveva avere un certo fascino estetico per stucchi e dorature, e che anche testimoniano come ad un certo momento la fabbrica della Cappella andò avanti con quella della restante chiesa e che dal patrimonio del Busacca cominciarono a usufruirsi anche il legato per giogali (a volte destinato per la fabbrica della chiesa) destinato a Santa Maria la Nova. Sicuramente il passaggio avviene per la peste del 1626 (anno assente nelle note spese) e dopo, quando le famiglie Damiata, Militello e altre assumono il patronato di varie cappelle della chiesa e cominciano una concomitante opera di edificazione/riedificazione con quella del Busacca. E forse il progetto originario non soddisfa più dato che nel 1635 si pensa già ad ingrandire e abbellire di nuovo al cappella Di Lorenzo. Il pretesto è dato dall’arco dell’abside che si incrina e nei secoli sarà sempre quello: nonostante demolizioni e ricostruzioni: anche oggi l’incrinatura più grande della chiesa ottocentesca è quella dell’arco trionfale!
Ma eravamo arrivati al 1642.
E’ il periodo in cui comincia la corsa alle Collegiate a Scicli e così nel 1644 i Confrati di Santa Maria la Nova stabiliscono di creare un Capitolo di 16 chierici: quattro dignità e dodici canonici. La motivazione riguarda il Busacca: “i confrati hanno fabbricato una cappella delle più insigni e sontuose che vi siano in questo regno, e quivi s’ha da trasportare il cadavere di detto testatore lasciato ancora in loco depositi nella città di Palermo”. Il Capitolo deve servire appunto ad assicurare la volontà del testatore con la celebrazione della messa quotidiana nella sua Cappella (cioè in quello che poi coinciderà con l’altare maggiore) in suo suffragio, anzi si impegnano a celebrarne due al giorno (una come da testamento, da un canonico scelto come cappellano della chiesa per tutto l’anno per il Busacca, e l’altra a turno da tutti i canonici secondo il calendario) e quattro nelle domeniche e feste di precetto, e l’otto settembre una ognuno.
Ma questa annotazione è importante perché ci rivela che, nonostante il fatto che nel Cappellone sia stato predisposto il tumulo marmoreo per Pietro di Lorenzo il suo corpo, fino al 1644 è ancora “in deposito” a Palermo. Ma poi fu traslato a Scicli? E se si, dov’è finito? Dai registri finora non è uscito più nulla.
Né ci aiutano gli storici locali. Il nostro arciprete conferma il fatto che il di Lorenzo aveva stabilito la sua sepoltura a Santa Maria la Nova (dando per scontato – ex facto- che il Busacca aveva indicato il cappellone) e che l’abbellimento fosse nato per questo: ma non ci dice se di fatto il Busacca è sepolto qui oppure non vi è sepolto. E il brano in questione del Carioti fu scritto verso il 1730-1740. Qualcosa in più ce la dice il Barone Spadaro, che essendo confrate di Santa Maria la Nova dovrebbe essere attendibile (sic!) quando afferma che a chiesa ultimata i confrati desiderarono finalmente traslare a Scicli il corpo del loro testatore, ma che le difficoltà burocratiche e i preventivi di spesa e le tasse da pagare così alte che alla fine decisero di soprassedere: “Cessò di vivere alla Capitale entro il Convento dei Frati Minori Osservanti, sotto titolo della Gancia.
Ivi restò tumulato, non ostante che volea trasferire le sue ossa nel sepolcro di sua padronanza posto nel cappellone di Santa Maria la Nova. Il dispendio doganale preteso per tassa nella esportazione dei cadaveri, negò al gran benefattore di Scicli il refrigerio della propria terra.
I discendenti in vece di possedere le sue ceneri ebbero spedito da Palermo il ritratto sopra laminetta di rame, di buon colorito, e sta esposto nell’Aula Capitolare di Santa Maria la Nova”.
Capisco le difficoltà burocratiche, ma non quelle economiche: l’opera pia era così ricca che non sapeva come investire o spendere i suoi soldi, spesso destinate a spese non del tutto necessarie (come testimonia il cantiere continuo della chiesa e l’acquisto continuo di arredi sacri e giogali), e poi nei confronti del Busacca c’era un sentimento e di grata venerazione, volete che l’orgoglio dei confrati si fosse arrestato davanti alle spese da fare?
In ogni caso la notizia dello Spadaro è importante perché rivela che il quadro di rame del Busacca era esposto nell’aula capitolare della Chiesa di Santa Maria La Nova.
E il tumulo? L’analoga sorte dei Miccichè a San Bartolomeo ci può aiutare: anche lì il Micciche avrebbe voluto essere collocato presso l’altare maggiore ma l’erezione della Collegiata con l’obbligo dell’impianto degli stalli del coro nell’abside fece sì che i due tumuli dei Miccichè fossero spostati ai due lati dell’ingresso della chiesa. Perciò, o il tumulo del Busacca già impiantato rimase sotto gli stalli, o nel 1644 fu spostato altrove o non fu più collocato e rimase nella sua custodia dove era stato imballato per il trasporto: e questo forse compromise, insieme ad altri fattori, anche l’inumazione qui a Scicli del Busacca. Anche il Pacetto scriverà: “questo pio benefico e generoso fondatore cessava di vivere in Palermo entro il Convento de’ PP. Minori Osservanti sotto il titolo della Gancia, nella di cui chiesa fu intombato; solo ci abbiamo in Scicli la di lui immagine espressa sopra lamina di rame, di buon colorito, la quale vedesi esposta nell’aula capitolare della suddetta chiesa di Santa Maria la Nova.”
Quindi siamo sicuri che fino all’anno in cui scrive il Pacetto, nel 1878, il quadretto di rame era nella sacrestia della chiesa.
Altre notizie invece del corpo finora non ne abbiamo.
Nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Palermo il cimitero è stato bombardato dagli americani, il pavimento è stato rifatto, delle tombe antiche si è persa la traccia.
Del quadretto invece è facile seguire la storia recente.
Ottenuto dopo secoli il trasferimento della amministrazione della Opera Pia, la confraternita di santa Maria la Nova tra il 1882 e il 1892 (anno in cui viene eretto il monumento in Piazza) fa costruire il palazzo che sarà sede appunto della amministrazione della Eredità Pietro di Lorenzo.
Il quadretto di rame è trasferito nella sede della presidenza dell’Opera nel nuovo palazzo, come luogo più degno. Da qui successivamente, costruito il nuovo ospedale che dal benefattore prenderà nome, tra il 1902 e il 1908, e fissata la sede amministrativa nel padiglione centrale del nosocomio, il presidente di allora, in un moto di orgoglio, trasferì il quadretto nella stanza della presidenza, in Ospedale.
Qui il quadro rimase, purtroppo per noncuranza e faciloneria della rettoria dell’epoca, anche quando l’amministrazione dell’Ospedale passò da privata a pubblica e così il quadretto, invece di essere riportato nella sua sede naturale e originaria, rimase negli uffici della amministrazione e finì per essere indebitamente inventariato tra i beni di ASL / USL, cosa che non doveva assolutamente succedere.
E’ dal 2007 che ho spronato inutilmente i vertici della Confraternita e dell’Opera Pia perché sia adoperassero per il recupero della lastra di rame e la restituzione da parte della dirigenza sanitaria ai legittimi proprietari.
L’esito di questi giorni, con la restituzione, in comodato, al Sindaco e la sua esposizione nella stanza del Sindaco, se da un lato almeno segna il ritorno dell’immagine di Busacca (almeno quella) nella sua Scicli, ha però il sapore quasi della beffa perché ritorna in un luogo e un contesto che non sono i suoi propri.
Un passo è stato fatto, ma adesso, con la buona volontà di tutti e senza preclusioni di parte, dobbiamo compierne un altro: far ritornare l’immagine di rame di Pietro di Lorenzo nella sua Santa Maria La Nova.
Le ceneri di Busacca forse sono perse per sempre, ma non si è perso il suo ritratto. Almeno questo sia conservato nella sua chiesa e nella sua cappella a testimonianza della memoria e della gratitudine degli sciclitani nei secoli.
© Riproduzione riservata