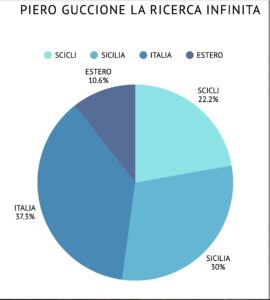Dibattito sull'etimo
di Un Uomo Libero.


Scicli – Molti storici del presente e del passato sono stati affascinati da Chiafura.
Oggi “Chiafura” è universalmente conosciuto come il quartiere trogloditico della città di Scicli e nel linguaggio corrente del dopo Terremoto del 1693 è stato sinonimo di abbandono e di degrado.
Recentemente, nella storia repubblicana italiana, Chiafura fu protagonista di un’accorata interrogazione parlamentare dalla quale scaturì la nascita di un nuovo moderno quartiere, il quartiere Jungi, naturale espansione della città di Scicli verso il mare.
Chiafura è un agglomerato di grotte antichissime nelle quali per secoli la povertà ha abitato con gli animali. Dal lavoro degli animali, infatti, quella povertà traeva l’unico mezzo di sostentamento per sopravvivere.
Per uno studio abbastanza completo e circostanziato su questo quartiere della città di Scicli rimando, comunque, all’ottima sintesi di Pietro e Paolo Militello: “Chiafura dopo il terremoto del 1693”.
Qui, invece, io voglio ragionare sull’antichità del toponimo “chiafura” tentando di dare una spiegazione quanto più credibile e vicina alla realtà e, soprattutto, quanto più documentata possibile.
Già il canonico e storico Giovanni Pacetto si era a lungo interrogato sull’antichità di questo toponimo usato per identificare l’antico quartiere della città di Scicli.
Il Pacetto conosceva ovviamente il libro di memorie dell’Arciprete Antonino Carioti “Notizie storiche della città di Scicli” e sapeva pure che l’Arciprete più volte aveva citato nel suo manoscritto il quartiere che, arrampicandosi sull’estremità occidentale del colle san Matteo con le sue numerose grotte, fa da quinta scenografica all’attuale chiesa di san Bartolomeo chiamandolo “Chiafura”. Addirittura a pag. 168 del volume primo delle sopra citate memorie, edizione curata dall’indimenticabile Professore Michele Cataudella, si legge testualmente:
“Ogni qualvolta i conti e le contesse di Modica stazionavano ne’ suoi stati, non lasciavano di frequentare la città di Scicli alloggiando nel palazzo dell’illustre famiglia Erizzi, sito nell’antico quartiere di Chiafura, oggi rovinato per causa del terremoto del 1693.”
Due cose lascia trapelare Carioti in questo brano.
Primo. Il quartiere denominato “Chiafura” era antico e importante perché abitato da gente facoltosa.
Secondo. Il quartiere non era circoscritto alle antiche grotte scavate sulle pendici della collina di san Matteo. Si allungava, invece, secondo la descrizione che dà l’arciprete, fin quasi all’odierna piazza Italia. E’ stato dimostrato, infatti, che il palazzo della famiglia Erizzi (vignale di Antonino Erizzi, v. Carioti, Notizie storiche della città di Scicli, pag. 430. Notizia confermata da numerosi atti in notai diversi) era edificato sull’omonimo vignale oggi inglobato nel complesso de “Il Ritiro” prospetticamente situato di fronte alla chiesa della Maddalena.
Il canonico Pacetto non accettò comunque sic et simpliciter le informazioni ricevute da Carioti. Da ottimo ricercatore qual era non si spiegava, in verità, come nessun notaio del passato avesse mai utilizzato nei suoi rogiti il termine “chiafura” per individuare quella parte della collina che sovrasta la chiesa di san Bartolomeo.
Il canonico Pacetto rivelava così una passione archivistica non comune anzi rara per l’epoca nella quale visse, oltre a un acume non comune sapientemente aiutato da discrete doti di paleografo. Stimolerà in seguito con il suo importante legato la fantasia di diversi ricercatori e storici che come me nel tempo hanno tentato di risolvere felicemente il secolare rebus.
Su Chiafura Pacetto aveva formulato una sua teoria che non sarebbe peregrina se non fosse scarsamente documentata.
A foglio 208 della sua opera “Toponomastica Contrate di Scicli” così scriveva:
“Grutti minutilli
Spesso incontrasi presso gli Atti di Notar Guarino accennata una tale Contrada e come ché giammai in detto Notaro si fa menzione della Contrada Chiafura la quale contiene moltissime Grotte, perciò suppongo che con tale denominazione si vorrebbero indicare le Grotte di Chiafura. Delle suddette Grotte se ne fa menzione in più Atti, ma io mi restringo rapportarne un solo del giorno 29 Xmbre 1569 dove leggesi che Natali Scardino accaptao d’Angilo et Sabella de Mazza # (tarì, ndr) 12 di Cenzo supra una casa in contrada di li Grutti minutilli conf. cum casa di Andria Lupo.”
Se così fosse, dicevo, sarebbe per sempre svelato il mistero di Chiafura. E il merito andrebbe davvero al canonico Pacetto.
Ma non è esattamente così.
Prima ancora di quest’atto del notaio Guarino, io stesso ho trovato un atto del Notaio Bartolomeo Terranova alias Cannariati rogato in data 8 novembre 1525 13° Indizione nel quale si fa espressamente menzione della contrada sospettata dal Pacetto di essere identificata con “Chiafura”. E’ una dichiarazione nella quale Violante, figlia del defunto Antonio Buchuffa e vedova di Francesco di Giuffrida, testimonia che Lemmo de Joccia ogni anno nel mese di agosto le paga un censo di tarì due su due case di sua proprietà “per suolo e luogo”. Le case sono ubicate nel territorio di Scicli in contrada “di li grutti minutilli”.
Il Notaio Terranova, pignolo a volte fino all’inverosimile, non scrive “cripte” bensì case, ergo non si trattava di grotte.
Non è difficile capire, allora, che la teoria del canonico Pacetto secondo la quale si sarebbe potuto identificare il quartiere detto de “li grutti minutilli” con Chiafura perde di credibilità o, in ultima analisi, la mantiene solo riguardo alla parte alta della collina. Tra l’altro l’atto da me individuato è di gran lunga anteriore all’altro citato dal Pacetto in Notaio Guarino.
Il 17 agosto 1517 5° Ind. in notaio Militello Antonino vol. I, invece leggo che
Andrea Falla e Antonina sposi… vendettero a Petro Chazenio presente una loro casa posta in territorio di Scicli in contrada di Chafura vicino alle case del ven/ Don Paolo di Arrabito e vicino alla casa dello stesso venditore…
A questo punto, mi chiedo se Chiafura sia mai esistito come toponimo o se sia solo l’errore di un inesperto copista che ha letto male il termine tardo latino CLAUSURA confondendo la “cl” iniziale con “ch” e scrivendola così, interpretando, poi, il segno ortografico comunemente usato per “s” come “f”.
Nei protocolli di Notaio Militello che sono arrivati fino a noi, da me pazientemente studiati, “chafura” compare in un atto solo, l’atto di cui sopra ho dato coordinate archivistiche e traduzione. In tutti gli altri protocolli di notai contemporanei che ho avuto la possibilità di analizzare, in nessuno di essi compare l’etimo “Chafura”, anche se vendite e locazioni se ne fecero in quella zona abbastanza. In ognuna di esse, compresi i censi, il termine generico impiegato dal notaio era solo e sempre “clausura” per indicare ciò che oggi chiameremmo particella catastale, dando per ciascun cespite come indicazione spaziale unicamente la sua distanza dalla chiesa di santa Margherita o dalla porta detta della Posterna, entrambe con certezza esistenti in quel vecchio quartiere.
E allora?
Chiafura e il suo mistero continuano a beffarsi di noi postumi negandoci una verità che forse la Storia stessa ha voluto seppellire sotto la polvere del tempo per un oblio pietoso della memoria.
CREDITI
Archivio di Stato di Ragusa, sezione di Modica, Notai di Scicli
Carioti Antonino, Notizie storiche della Città di Scicli, ed. a cura di Michele Cataudella, vol. I e vol. II, Comune di Scicli, 1994
La China Ignazio, Chiafura sì Chiafura no, Ignazio La China dice la sua, Il Giornale di Scicli, 20.05.2019
Militello Paolo, Il patrimonio violato nel “Ritiro” di Scicli, www.ragusanews, 1.10.2018
Militello Paolo e Pietro, Chiafura dopo il terremoto del 1693, Giornale di Scicli
Pacetto Giovanni, Toponomastica Contrate di Scicli, Biblioteca Comunale Carmelo La Rocca, Scicli
© Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, dei contenuti del presente articolo. Ogni loro eventuale citazione è subordinata all’autorizzazione previa dell’Autore.
© Riproduzione riservata