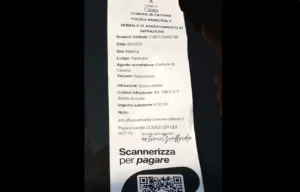Una rivista letteraria fiorentina pubblica un racconto di uno dei nostri collaboratori, Pasquale Bellia
di Pasquale Bellia

Chi si aspetta da questa lettura un ritmo del racconto e una trattazione diaristica come si ritrova in “Viaggio in Sicilia 2002” avrà una delusione!
Nel riportare questa nuova esperienza di scoperta, è stato privilegiato quel repertorio di sensazioni di un cuore che batte, e non solo per trascinare innanzi la mia vita. Ho cercato di trarre da quello che sono abituato a guardare tutti i giorni i segreti che, a causa della routine, non riesco a vedere. Ho sistemato lo scandaglio verso altre e più intime profondità, alla ricerca dei motivi che sorreggono il gesto: la voglia di ri-cerca, il desiderio di misurare le proprie capacità alla sofferenza, l’eccitazione e l’ansia del rischio. Sì, rischio! Perché un’avventura in bicicletta porta con sé lo stesso incosciente pericolo: del ballare al buio in un balcone senza ringhiera. L’impegno del pedalare in topografie sconosciute è esercizio ardimentoso. Del resto nessun gioco piace abbastanza, senza il fascino del rischio e la prima grande virtù di chi intraprende un simile cammino: è il coraggio. Quel coraggio che cancella la pigrizia.
…………….
Gli anni – si sa – passano, hanno lo stesso movimento dei luoghi. Perché anche i luoghi hanno un’anima, un’identità, un carattere. In questo viaggio della “cura di sé” mi sono mosso – io sedentario per forza ma innamorato dell’avventura – con in testa una mappa letteraria dei luoghi, che presto ho verificato non corrispondeva alla verità. Per me era lo stesso verità, anche se dietro ad una bugia, perché non credo le giustezze si trovino sempre per terra: alcune volte per raggiungerle ci vogliono le ali e la loro collocazione a molti è inaccessibile. Sono in ogni modo stato in balia dei sogni e della nostalgia. Rischiosa condizione, quest’ultima, che porta a muoversi in bilico sul ciglio del profondo abisso delle illusioni, che fin’ora ho sempre saltato senza precipitarci
………………
Nel pedalare, la solitudine, anche se tra gli altri, è quasi totale. È come stare dentro un alone di luce vivida che protegge e racchiude pensieri e sentimenti, che si muove alla mia velocità non risentendo dei fatti intorno. Quando cadi dalla pelle dentro l’anima, cerchi, cerchi e non trovi nessuno. Mi ha sempre accompagnato la mia stessa stramba ombra in movimento che originava dal filo di contatto delle ruote con la strada. Nelle giornate di sole più forte … lei era più chiusa. L’allungata piramide scura nella proiezione del mio stesso essere nelle ore dell’alba, aveva come vertice lontano la testa e le ruote di un’ellisse perfetta. Poi … con il proseguire del giorno si accorciava e gli pedalavo sopra. In quei momenti ero convinto: io ero solo un’ombra e la passione il sole!
……………………
In bicicletta è tutt’altro scoprire. La libertà e l’autonomia dei gesti del forestiero – vissute con felicità e coraggio – sono ricchezze introvabili altrove, rendono più vive le giornate e più futili i rischi. Nel mio cammino soltanto il sonno e la fame scandivano il tempo. Alle ore della necessità e quindi non per convenzione fissate, mi sono alimentato di ciò che la strada, appeso ai suoi rami, mi offriva: i fichi dell’agrigentino, l’uva del trapanese, le mele dei Nebrodi, le pere dell’Etna. Il vedere inconsueto dell’adagiarsi dei fecalomi sull’erba secca e il loro dividersi al contatto con l’arido terreno, il bere dalle fonti trovate per caso, il lavarsi per strada, bivaccare senza fretta, la ricchezza del fare a meno della vita nota per dei giorni: è un’ubriacatura di libertà! Difficoltà, intemperie, imprevisti, costituiscono il prelibato sapore di un’avventura in bicicletta. La pioggia, come fatto naturale, cadendo torna al luogo della sua origine; il vento custodisce sapori, rumori strappati ad altri luoghi e porta via le ragnatele del tempo; le salite, dalle fatiche asprigne, irrimediabilmente misurano l’arte della pazienza e la capacità a superarle; il freddo, con la sua frustata, sveglia i sentimenti e ci fa sentire vivi. Del resto la vita stessa è come una gara ciclistica.
……………………
Ho vissuto per strada. Nastro indifferente che attraversa realtà sempre diverse e che pulsa di vita come un meccanismo a molla. Transito di merci, di saperi, di poteri, di civiltà millenarie. Filo d’asfalto che attraversa gli eventi della storia dei luoghi, idealmente cucendoli tutti.
Sì, tutto potrebbe iniziare così, qui, in questo modo, una maniera un po’ pesante e lenta, nel luogo neutro che appartiene a tutti e a nessuno, dove la gente s’incontra quasi senza vedersi, in cui la vita si ripercuote altrove, lontana e regolare. Lo spazio pubblico, luogo deputato allo svolgimento di attività comuni: la strada! Non la strada come solo mezzo di transito, quasi un condotto idraulico, nata per evitare il centro, quanto quella che con la storia degli abitati e degli abitanti trova un confronto, un’interazione. La strada delle bancarelle dei fruttivendoli senza licenza, delle stagionali attrezzature balneari, che attraversa piazze, o si perde tra le campagne; quelle nuovissime e le altre dove ogni rattoppo racconta una storia di lavoro, di fatica.
……………………….
Tanto ho combattuto come un “Guerriero della luce”, contro avversità meteorologiche e altimetriche.
Il vento di ponente – il primo giorno: Sampieri-Sciacca – mi ha imposto una disumana fatica: le canne si chinavano al mio passaggio, scodinzolando allegre i loro pennacchi e sventolando le strette foglie appuntite come nastri di seta. I muri di salici scuotevano le fronde scosse dal vento. Le buganvillee disperdevano i loro petali che parevano farfalle, colorando l’aria. Il banano agitava le sue lunghe foglie come fazzoletti d’addio. A nulla serviva poggiare il mento sul manubrio per diminuire la superficie all’avanzare, o affilare il naso per squarciare il muro del vento: sui viadotti si saliva a 7 – 8 kmh con difficoltà nell’equilibrio, in discesa non più di 20 kmh. La scia dei camion – che non rallentavano la loro fretta – era solo uno scappellotto poco utile, perché subito la sinistra mano del vento poggiata sulla fronte m’impediva di avanzare. Quasi 14 ore di sella continua per soli 220 Km. All’arrivo mi sentivo gonfio il cuore di fatica e una nausea da sofferenza. Quel vento aveva portato via frammenti di me. La sera, lungo il filo dell’orgoglio, ho riposato il cuore e ricercato il fiato dentro un gomitolo di sfinitezza.
La pioggia del Tirreno – Mare che conosco – mi ha rincorso per l’intero cammino della quarta tappa: Cefalù-Patti. Un cielo scuro mattutino era definito da leggere nuvole bianche sfrangiate come ciocche di cotone, altre che vagavano minacciose come Galeoni carichi di un blu cobalto; hanno viaggiato lungamente con me al punto da sembrare un mare capovolto. Quando poi, il tossire lontano del temporale si è avvicinato, il crepitio dei tuoni disegnava luminosi squarci ramificati nel cielo e maligni rovesci di pioggia si sono abbattuti sul mio cammino. Lucidate braccia e gambe, la pioggia copiosa gocciolava dal casco sugli occhiali, spingevo di più – come nelle corse mi accadeva – per una forma di eccitazione che accompagnava quell’impegno bagnato, quasi santificato. Mi sono riparato più volte dopo essermi oramai inzuppato. La varia fragranza della vegetazione inumidita, penetrava dal naso e si dirigeva verso l’anima. L’acqua che saliva dalla strada con il giro delle ruote era di un tepore sconcio. Quella che mi pioveva addosso, fresca e pulita. Il sentirsi abbandonato, tra vegetazione rigogliosa e case sparse, dava un senso di potenza e un’aperta sfida senza paura. Cosa poteva accadermi? Solo una difficoltà nell’equilibrio, dato anche il peso portato e la non sicura governabilità della bicicletta: per il resto, sentivo l’eroico gesto assolutamente appartenermi. È un giorno piovoso, ma ben presto i nuvoloni scuri si dissolveranno e allora … tornerà benevola la luce. Sì, le nuvole di dissipano, mentre il sole non si dissolve mai. Credo sia un fatto da rammentare in ogni momento di solitudine.
La salita dei Nebrodi è stata lunga e faticante. Non pensavo esistesse in Sicilia una salita “dolomitica”: 30 chilometri senza respiro. Porto dietro un fardello notevole dovuto ai bagagli, e non sono più capace come un tempo a combattere contro certe pendenze, perché non sono più allenato rispetto ad anni addietro: tutto questo è stato motivo di sofferenza estrema. Partivo da quasi quota zero, e sapevo delle difficoltà della salita, senza conoscerla. La strada – lasciato la zona marina – svolgeva la sua pendenza tra boschi di castagni e noccioleti, attraverso una Sicilia genuina e arcaica nel paesaggio e nelle attività. In cima prati e pascoli d’altura con bestiame brado a brucare. Un’aria fresca e assolutamente trasparente amplia l’orizzonte. Seduto in fondo sella, davo un’occhiata senza vivacità al lento movimento delle gambe. Seguivo l’alternarsi nell’andare su e giù dell’ossuta rotula e il definirsi dei muscoli della coscia, il polpaccio contrarsi nel gioco di caviglia. Non mi alzavo suoi pedali se non per fare riposare le gambe cambiando il modo della spinta, e subito un morso di dolore attanagliava il quadricipite con i canini della contrazione infilzati fin dentro le ossa. Il 26, provvidenzialmente fattomi arrivare da Giuliano, è stato una benedizione ed alcune volte non bastevole perché, per la lunga salita, sentivo la forza della gravità aggrappata al posteriore della bicicletta che, come un freno avverso al mio procedere, impediva il rotolare in avanti delle ruote.
Il freddo d’agosto. Sì, può sembrare paradossale d’agosto in Sicilia, proprio quel freddo che solo le domeniche d’inverno a Firenze nel pedalare sento. A Favoscuro a quota 1264, la salita dei Nebrodi era finita e pensavo di avere ultimato il patimento. La giornata era soleggiata e limpida come acqua di fonte in un bicchiere di cristallo. Messa in cima la mantellina antivento, non basta a proteggermi, devo frenare, frenare, portare l’andatura alla stessa lentezza della salita. La pelle della gambe e delle braccia non è “d’oca”, come si suole dire, ma somiglia alla superficie acuminosa di una grattugia e le mani, con difficoltà nei movimenti, a fatica stringono le leve dei freni. Sento il freddo dalla pelle arrivare al midollo, ma devo scendere se voglio sperare di superare il dolore. Quando la quota diminuisce – a Santa Domenica Vittoria e dopo a Randazzo – e anche il giorno incomincia a contare le sue ore più miti, il gesto torna nella stessa condizione di sempre, anche se l’automatica regia nel pedalare trova dei momenti di difficoltà nella gestione.
Riflettevo, in quelle condizioni, come il soffrire o come il godere è cedere alle passioni: l’unica differenza è che il godimento somiglia alla serenità e perciò inganna e fa perdere del tempo, mentre il soffrire costringe subito a indurirsi e tendersi. Apprezzo la vita che si svolge dolorosamente e non voluttuosamente; ho semplificato il mondo in una galleria di gesti di forza nel sentimento, dove si trova lo spettacolo della vita e non la vita.
E poi, chi ha detto che la vita fosse da godere?
Pasquale Bellia
© Riproduzione riservata