La crisi del settore edile
di Lucrezia Fava
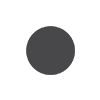

Modica – Sabato mattina, 1 dicembre, si è tenuto l’evento organizzato da Filca Ragusa (Federazione Italiana Costruzioni e Affini), federazione di categoria Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Rosario Gagliardi” di Ragusa.
Titolo dell’incontro: “Costruiamo insieme legalità”. Presenti Giorgio Abate, coordinatore provinciale di Libera, Giuseppe Grassia, presidente dell’Ance di Ragusa, Giusi Migliorisi, dirigente di Confindustria Ragusa, Salvatore Scelfo, segretario nazionale della Filca-Cisl e responsabile del dipartimento legalità della categoria, il colonnello Francesco Fallica, comandante provinciale della Guardia di Finanza, Michele Di Rosa ispettore della Direzione Territoriale del Lavoro e Concetta Caruso, dirigente della Prefettura.
Ha introdotto l’incontro Luca Gentili, segretario generale della Filca-Cisl di Ragusa, subito dopo il saluto del professore Vincenzo Giannone, dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico per Geometri “Rosario Gagliardi”.
L’obiettivo era riunire i rappresentanti di categoria del settore edile, le istituzioni di governo e i ragazzi dell’istituto tecnico, interessati a “costruire”, per riflettere sull’attuale crisi economica, in particolare del settore edile in provincia, e sulle soluzioni che è necessario adottare, secondo il discrimine della legalità.
Vediamo più da vicino i temi trattati e le personalità coinvolte.
LA CRISI DEL SETTORE EDILE. SINDACATI A CONFRONTO
Luca Gentili, segretario generale della Filca Ragusa, ha aperto l’incontro con un prospetto dell’andamento del settore edile in provincia. «Da ottobre 2011 a settembre 2012 abbiamo 535 imprese in meno, 724 operai in meno, 4.600.000 euro in meno di massa salariale (cioè di retribuzioni complessivamente erogate dalle imprese agli operai), 45.651 ore in più di cassa integrazione». I numeri provano la criticità della situazione attuale, riprova che fenomeni che si credevano scomparsi, o almeno diminuiti, persistono. Fenomeni quali il caporalato, il lavoro nero, il ricorso alla cassa integrazione fittizia, la pretesa di prestazioni straordinarie non retribuite, l’usura, il riciclo di denari sporchi. E sullo sfondo la minaccia costante del business del malaffare. Perché – è risaputo- le associazioni a delinquere si infiltrano con più facilità nelle imprese in crisi, traggono utili dalla disoccupazione e dal malessere sociale, diventano una chance sempre più concreta per chi, per vie legale, non trova lavoro.
Sulla stessa linea Giuseppe Grassia, presidente dell’Ance di Ragusa: «il settore edile è il più colpito in provincia. Sono tre le cause principali che ne bloccano lo sviluppo: il lavoro nero, l’estorsione e una burocratizzazione eccessiva. Bisogna denunciare il malaffare, cambiare mentalità, snellire le procedure». Il presidente elenca poi alcune misure di successo che sono stata adottate per tutelare le imprese e incentivare e promuovere il merito: il Codice Etico dell’associazione nazionale, il nuovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, siglato da Ance Ragusa e dalle organizzazioni sindacali di categoria, «il primo e l’unico contratto in Italia che permette alle imprese che svolgono in modo serio, legale, la loro attività di guadagnare determinati benefici», e il Protocollo della Legalità, di cui hanno discusso in modo più esteso il viceprefetto di Ragusa Concetta Caruso e la dirigente di Confindustria Ragusa Giusi Migliorisi.
IL PROTOCOLLO DELLA LEGALITÀ. ISTITUZIONI E IMPRESE.
«Cos’è la legalità? Ne sentiamo parlare sempre, ma cosa significa?» così Giusi Migliorisi, dirigente di Confindustria Ragusa, introduce il suo intervento sull’importanza di fare attività d’impresa in modo legale. «Legalità significa vivere dentro la legge, rispettare le regole per garantire il benessere sociale». Per contro, l’ignoranza delle regole genera illegalità, diventa terreno fertile per le mafie. Da qui la necessità di educare e responsabilizzare i giovani, mentre alle imprese tocca intervenire in modo più concreto e immediato. «Il primo obiettivo di un’impresa – spiega la dott.ssa Migliorisi – è il profitto. Ma perché si generi in modo legale bisogna far fronte a notevoli difficoltà: la cattiva amministrazione, l’atteggiamento d’imposizione delle cosche, le infiltrazioni malavitose. Il Protocollo della Legalità è una soluzione a questi problemi». La dirigente di Confindustria sintetizza in due punti la funzione del protocollo: «le imprese si impegnano con la Prefettura a denunciare gli atti d’intimidazione e a indicare i loro fornitori». Pena l’esclusione da Confindustria.
Il viceprefetto Concetta Caruso, che si occupa di ordine e sicurezza pubblica, quindi di documentazione antimafia e legalità, sottolinea il significato del protocollo, sottoscritto il 10 maggio 2010 dal Ministero dell’interno e da Confindustria ed entrato in vigore a Ragusa lo scorso settembre. L’accordo «significa una più stretta sinergia tra le imprese e il mondo del governo». Il Ministero dell’Interno s’impegna a rafforzare e semplificare le procedure di monitoraggio dell’attività imprenditoriale: le imprese meritorie ricevono un documento antimafia, come attestato della loro legalità, e vengono inserite in White List, liste garanti dell’affidabilità dell’impresa sul mercato.
In sinergia con la Prefettura e le imprese intervengono sul territorio la Guardia di Finanza e la Direzione Territoriale del Lavoro.
L’ispettore Michele Di Rosa si sofferma sul ruolo intermediario della Direzione Territoriale del Lavoro: reprimere le violazioni in materia di lavoro, quindi assicurare il rispetto dei contratti di lavoro e favorire la conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore.
Il colonnello Francesco Fallica introduce il lavoro della Guardia di Finanza con una nota positiva a Ragusa: per la stretta collaborazione tra istituzioni e associazioni sindacali, per l’assenza di una mentalità criminale. Secondo il Colonnello, infatti, le cosche mafiose non sono presenti a livello locale, ma aggiunge: «questo non deve tradursi in un allentamento dei controlli. Se manca la mafia di un tempo, quella visibile del pizzo e della lupara, significa che oggi dobbiamo guardare più a fondo, dove il fenomeno mafioso si rende invisibile, come nel riciclo di denaro sporco. Ragusa può diventare facile vittima di infiltrazioni».
Parla poi dei rapporti tra imprese e istituzioni e li ricollega nella lotta all’evasione fiscale, che definisce: «il problema dei problemi, e il problema di tutti». Un ragazzo interviene per chiedergli se soltanto le imprese e la Guardia di Finanza siano responsabili dell’evasione fiscale. Non è una vera domanda, almeno per quanti danno per scontato che la politica non può non esserne responsabile. il Colonnello infatti risponde: «la politica ce la cerchiamo noi, chi ci vieta di cercarcene un’altra? Io credo nel valore dell’esempio. E dobbiamo iniziare noi a darlo: stiamo più attenti alle persone che scegliamo, diamo un peso maggiore al voto».
LEITMOTIV DELL’INCONTRO: MAFIA E GIOVANI POLI OPPOSTI
Nel corso dell’incontro il fenomeno della mafia sembra quasi un problema ovvio. Parassita del sistema economico, causa prima, in Sicilia, del lento sviluppo di una sana attività imprenditoriale, la mafia rimane lo sfondo costante di riferimento.
A portarla in primo piano, è Giorgio Abate, coordinatore provinciale dell’associazione Libera.
Abate parla della nascita di Libera sul territorio nazionale, nel 1995, in risposta al bisogno del popolo di contenere e superare i danni delle stragi del ’92, ricorda il suo primo successo nella lotta contro le mafie: il riconoscimento della petizione popolare, supportata da Libera, per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali nella legge 109/96, del marzo 1996. Fa un prospetto attuale: con un fatturato complessivo di 130 miliardi la mafia risulta essere la prima azienda d’Italia. Le sue reti si assottigliano e si allargano, corrompono imprenditori e politici, tanto a Nord che a Sud. Chiediamoci perché in Sicilia è stato usato solo il 10% dei fondi europei e a Milano sono stati confiscati alla mafia 550 beni.
Conclude il suo intervento con una citazione del magistrato Antonino Caponnetto: «la mafia teme di più la scuola che la giustizia». Quindi l’educazione e la capacità di responsabilizzare le nuove generazioni.
Veniamo così al secondo punto focale dell’incontro, opposto al primo: i giovani. È chiaro che dove serve un cambiamento sostanziale – nessun dubbio che serva in Italia, data la grave crisi economica, istituzionale e culturale che viene riconosciuta, ormai, ovunque – bisogna puntare su chi dispone di maggior tempo ed energie. L’appello ai giovani è quindi costante, volutamente ottimista, radicale. Come risulta nell’intervento conclusivo del segretario nazionale della Filca-Cisl, Salvatore Scelfo: «vi auguro di essere bravi cittadini, cittadini consapevoli, di una società più giusta, ma perché sia possibile è necessario che partecipiate alla vita politica, al lavoro, alle attività sociali, da protagonisti, serve che vi interessiate di tutto».
© Riproduzione riservata














