Si è spento a Genova, all'età di 94 anni.
di Redazione
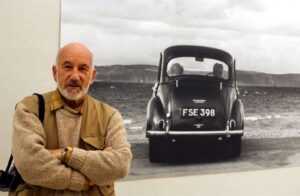
Genova – È morto a Genova all’età di 94 anni Gianni Berengo Gardin, uno dei maestri della fotografia italiana. Era nella sua casa di Camogli, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza. Nato a Santa Margherita Ligure il 10 ottobre 1930, è stato una figura chiave della fotografia italiana del XX e XXI secolo, con un lavoro che intreccia impegno sociale, reportage documentario e attenzione ai dettagli della vita quotidiana e dell’ambiente.
Nato a Margherita Ligure, infiniti trascorsi a Venezia, un frutteto a Camogli come rifugio segreto, Gianni Berengo Gardin ha trascorso la sua intensa vita con la sua Leica a tracolla – «anche se a volte poi non fotografo nulla, ma non vorrei mai perdermi qualche occasione». Del Macof di Brescia è stato presidente del comitato scientifico, in collezione permanente sono esposti alcuni dei suoi scatti più iconici.
Berengo Gardin ha iniziato a dedicarsi alla fotografia negli anni ’50, senza mai più abbandonare la sua dolce dipendenza. La svolta arriverà grazie alla Magnum, agenzia di cui Cartier-Bresson è stato fondatore e al quale negli anni seguenti sarà spesso paragonato. Anche se, ribadirà, «il mio lavoro non è assolutamente artistico e non ci tengo a passare per un artista. In realtà sono il Willy Ronis italiano, anche se una delle cose di cui più mi vanto è la dedica in cui Cartier-Bresson mi scrive: ‘A Gianni Berengo Gardin con simpatia e ammirazione’. Avere la sua ammirazione è il massimo, poi si può morire in pace». Ma era solo l’inizio: nei primi anni ’60 un suo parente americano lo mise in contatto con Cornell Capa, che gli fece avere alcuni libri totemici: da quel momento la sua fotografia seguirà le orme dei grandi di Life e della stessa Magnum, raccontando la realtà con gli occhi di un «artigiano votato all’impegno sociale».
Venezia nel cuore
Era nato a Santa Margherita Ligure (Genova) il 10 ottobre 1930, ma considerava Venezia la sua vera città natale: lì aveva studiato e mosso i primi passi con la macchina fotografica, che non avrebbe mai più lasciato. Con oltre due milioni di negativi, più di 260 libri pubblicati, oltre 360 mostre personali in tutto il mondo e una carriera consacrata da premi internazionali, Berengo Gardin è stato molto più di un fotografo: è stato un testimone etico, un poeta della realtà, un osservatore discreto ma instancabile dell’Italia che cambia. Berengo Gardin amava definirsi «un artigiano», e non un artista. Detestava l’idea di fotografia come forma d’arte estetizzante, preferendo sempre l’impegno civile alla ricerca di uno stile personale: «Il mio lavoro non è artistico, ma sociale e civile. Non voglio interpretare, voglio raccontare». Il suo sguardo si è sempre posato sull’uomo: nei suoi gesti quotidiani, nel lavoro, nei momenti di intimità e nei luoghi del disagio. Dall’Italia contadina del dopoguerra agli slanci della modernizzazione, dalla vita degli zingari all’universo industriale, dalle periferie urbane ai manicomi, campo, quest’ultimo, in cui firmò il reportage più potente della sua carriera. Nel 1969, insieme a Carla Cerati e sotto la guida di Franco Basaglia, realizza «Morire di classe» (Einaudi), un libro che svela per la prima volta le condizioni disumane dei manicomi italiani. È un grido muto, fatto di immagini nette e crudeli, che scuote il Paese e contribuisce alla battaglia culturale che porterà, nel 1978, alla Legge Basaglia. «Fotografavamo solo con il consenso dei malati – raccontava – Ma non volevamo mostrare la malattia, bensì la condizione». Era la cifra del suo lavoro: non lo choc, ma la consapevolezza. Dopo aver vissuto a Venezia, Roma, Lugano, Parigi e infine Milano, dove si stabilisce nel 1965, Berengo Gardin avvia una lunga carriera da professionista del reportage, che lo porterà a collaborare con le più importanti testate italiane e internazionali, tra cui «Domus», «L’Espresso», «Time», «Stern» e «Le Figaro», ma soprattutto a dedicarsi alla forma che più amava: il libro fotografico.
Dopo un iniziale impiego come redattore per riviste d’aviazione, scopre la fotografia leggendo i volumi della Farm Security Administration americana e i libri di Eugene Smith e Dorothea Lange. Poco più che ventenne entra a far parte del famoso circolo fotografico ‘La Gondola’ e viene invitato da Italo Zannier a far parte del Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia. In seguito fonda con i suoi amici il gruppo fotografico ‘Il Ponte’. La sua fotografia amatoriale ottiene un grande successo e molti dei suoi scatti vengono pubblicati nei cataloghi di importanti mostre e nelle riviste specializzate di tutto il mondo. Il suo esordio ufficiale avviene nel 1954 sulle pagine del settimanale «Il Mondo», diretto da Mario Pannunzio, con cui collaborò fino a 1965. Da lì inizia un percorso che lo porta a lavorare con realtà di prestigio come il Touring Club Italiano (1966-1983), l’Istituto Geografico De Agostini, e aziende simbolo dell’industria italiana, da Olivetti a Fiat, da Alfa Romeo a IBM. La fotografia di Berengo Gardin è anche un grande racconto urbano e paesaggistico; documenta il lavoro, l’architettura.
Lavori fondamentali sono «Zingari a Palermo», «India dei villaggi», le fotografie dei cantieri di Renzo Piano (dal 1979 al 2012) e l’impegno contro le grandi navi nella laguna di Venezia, un progetto esposto in collaborazione con il FAI a Milano e Venezia nel 2014 e 2015. La sua Venezia resta una costante: la fotografa per tutta la vita, con uno sguardo sempre partecipe e sempre critico. Il suo primo libro, «Venise des Saisons» (1965), fu un omaggio proprio alla sua Venezia: una città non turistica, intima, quotidiana, fatta di lavoratori, bambini che giocano, artigiani, nebbia e silenzi. Berengo Gardin è stato il fotografo italiano più premiato e riconosciuto a livello internazionale. Nel 1972 Modern Photography lo inserisce tra i «32 World’s Top Photographers», nel 1982 lo storico dell’arte Ernst Gombrich lo cita come unico fotografo nel suo «L’immagine e l’occhio. Altri studi sulla psicologia della rappresentazione pittorica» (Einaudi). Nel 2008 riceve a New York il Lucie Award alla carriera, già assegnato a giganti come Henri Cartier-Bresson, Gordon Parks ed Elliott Erwitt; nel 2009 l’Università Statale di Milano gli conferisce la Laurea Honoris Causa in Storia della Critica d’Arte; nel 2014 ottiene il Premio Kapuściński per il reportage, mentre nel 2017 viene accolto nella Leica Hall of Fame.
Nel 1975 Bill Brandt lo seleziona per la mostra «Twentieth Century Landscape Photographs» al Victoria and Albert Museum di Londra. Nel 2003 fa parte degli 80 fotografi selezionati per la mostra «Les choix d’Henri Cartier-Bresson». Tra le oltre 360 mostre personali in Italia e all’estero, Berengo Gardin ha partecipato alla Photokina di Colonia, all’Expo di Montreal nel 1967 e all’Expo di Milano nel 2015, alla Biennale di Venezia e alla celebre mostra «The Italian Metamorphosis, 1943-1968» al Guggenheim Museum di New York nel 1994. Tra le personali più recenti, si segnalano nel 2016 «Vera fotografia. Reportage, immagini, incontri» al PalaExpo di Roma, che ne ha ripercorso la lunga carriera attraverso i principali reportage e oltre 250 fotografie, e nel 2022 l’ampia retrospettiva «L’occhio come mestiere» al Maxxi di Roma. Le sue fotografie sono custodite nei più prestigiosi musei del mondo ed istituzioni culturali, come il New York Museum of Modern Art di New York, il Centro Studi e Archivi di Comunicazione dell’Università di Parma, la Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi, la sede dell’Onu a New York, la Photokina Colonia, il Guggenheim Museum di New York, la Galleria Nazionale d’Arte ed Estetica di Pechino, la Maison Européenne de la Photographie di Parigi, il Reina Sofía di Madrid, il Maxxi di Roma e l’Istituto Centrale per la Grafica. Il suo archivio – più di due milioni di scatti – è oggi gestito dalla Fondazione Forma per la Fotografia, che continua a divulgarne l’opera e l’eredità. Berengo Gardin Ha fotografato baci rubati, camposanti, treni affollati, lavoratori, donne («prima viene la Leica, poi le donne, poi i gelati», diceva scherzando), architetture, bambini, rom, anziani. Sempre con uno sguardo fermo, empatico, ironico senza mai essere cinico. Molti lo hanno definito il «Cartier-Bresson italiano», ma lui stesso preferiva un’altra definizione: «Sono il Willy Ronis italiano. Ma conservo con orgoglio una dedica di Cartier-Bresson: ‘A Gianni Berengo Gardin con simpatia e ammirazione’. Avere l’ammirazione di lui, vuol dire che si può morire in pace».
|
|
© Riproduzione riservata














