Uno studio dello storico dell’arte Paolo Nifosì
di Redazione
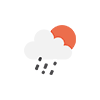

Ragusa – Uno degli interrogativi che mi sono posto nell’affrontare l’arte negli Iblei è quello di poter dare una risposta alla seguente domanda: quando ha cominciato a diffondersi la “maniera moderna” di vasariana memoria in area iblea?. Allo stato attuale delle ricerche penso che questa diffusione si possa porre intorno agli anni trenta del Cinquecento. Prima di quella data abbiamo alcune belle sculture in marmo raffiguranti la Madonna col Bambino oltre a Sant’Agrippina di Scicli e alla Natività della chiesa di San Giuseppe di Modica. Ma ancora si sente molto in queste opere la cifra stilistica del rinascimento quattrocentesco. Invece con l’incarico dato nel 1529 da parte dei carmelitani di Modica ad Antonello Gagini si avverte un adeguarsi ai canoni del classicismo cinquecentesco, a quella terza età del Rinascimento. Le cose per quel polittico marmoreo non andarono come dovevano andare, ma quell’Annunciazione penso sia uscita dalla bottega di Antonello Gagini. Resta problematico l’altro polittico su tavola sempre per i carmelitani di Modica, di cui ci resta la tavola di Sant’Alberto, che dovrebbe essere degli anni quaranta del Cinquecento se la sua cornice sarà dorata da Francesco Siracusano nel 1550. Difficile collocare quel polittico, come più volte è stato scritto, negli anni venti. Troppo tempo tra l’eventuale realizzazione in quel decennio e la realizzazione sicura della cornice nel 1550. Un altro Gagini, Giacomo, negli anni quaranta realizzerà,a quanto scrive il gesuita Padre Salvo, il monumento funebre Naselli nella chiesa di San Francesco all’Immacolata di Comiso, che è in linea del nuovo gusto classicista e manierista. Ma le opere si infittiscono con la seconda metà del Cinquecento, con la tendenza a realizzare sacre rappresentazioni monumentali da collocare negli spazi absidali. La prima che ci risulta è quella della chiesa di San Giovanni Evangelista di Modica. Nel 1549 i rettori della chiesa di San Giovanni Evangelista incaricano Vincenzo de Ramundo e Francesco de Chanchano, maestri scultori e pittori di Noto, per realizzare un santo sepolcro con otto statue lignee e precisamente Cristo, la Madonna, San Marco, San Giovanni, Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo, oltre a due angeli con la croce, la scala ed altri elementi della passione, con la montagna sotto la detta croce. Il costo previsto è di ottanta onze. Quell’opera non ci rimane. Un eco e una memoria resta nel gruppo scultoreo che si trova nell’altare sul lato destro della chiesa su citata. Negli anni sessanta sono tre le opere monumentali. La Deposizione dell’abside della chiesa di Santa Maria la Nova, il presepe monumentale della chiesa di San Bartolomeo, entrambi a Scicli e il polittico della chiesa di San Giorgio di Modica. Nella chiesa di Santa Maria la Nova i rettori nel 1564 incaricano il netino Domenico Antonino Monacella di Noto a realizzare un santo sepolcro con quattordici sculture lignee e cioè Cristo, la Madonna, Maria di Magdala, e altre due Marie, Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo, San Giovanni, oltre a quattro angeli e a due custodi del santo sepolcro. I modelli di riferimento dovevano essere le sculture del Santo Sepolcro di Modica, ad eccezione delle sculture dei due custodi per le quali il modello di riferimento doveva essere il Santo Sepolcro realizzato nella Terra di Ragusa ( il documento è stato pubblicato dal Marano Rosa). Di quel Sepolcro ci restano due sculture, l’Addolorata e il Cristo deposto. Il presepe monumentale della chiesa di San Bartolomeo di Scicli, con sculture di prima veduta a grandezza d’uomo, come ci riferisce il Carioti, furono commissionate nel 1565. Di quelle sculture non ci rimane traccia.
Dello stesso anno è l’incarico dato dai rettori della chiesa di San Giorgio di Modica a Bernardino Nigro per il polittico che si trova nella parete absidale. L’incarico al Nigro viene dato dai procuratori Giovanni Guarrasi, Antonio Giarratana, Matteo di Tommaso, Tommaso Lixsandro; quest’ultimo anche procuratore dell’assente Pietro Lorefice, il 26 settembre del 1566. Col contratto il Nigro, detto il “greco”, che a quella data risulta abitante a Caltagirone, s’impegna a dipingere la “cona” in base ai soggetti che indicheranno i procuratori, con colori “finissimi”, ad olio e con “azolo” di “Alemagna”(Germania). Il prezzo non è fissato fin dall’inizio, ma sarà deciso da parte di periti scelti di comune accordo e nel caso di una valutazione discordante da parte di un terzo perito alla consegna dell’opera. Al Nigro saranno dati acconti nel prosieguo dei lavori; gli è consentito di poter avere come collaboratore il siracusano Girolamo “lo spagnolo”, da individuare in Girolamo Gomes, e di poter scegliere l’artista che dovrà dorare la cornice lignea del polittico. Per tutta la durata del lavoro al Nigro si da una stanza con annessa cucina per lui e i suoi collaboratori ed il costo dell’affitto sarà computato nel prezzo definitivo. L’opera sarà consegnata nel 1571 ai procuratori, il magnifico don Antonino Palazzolo, don Francesco Occhipinti, don Giovanni Guarrasi, don Pietro Lorefice. Delle tavole citate nell’atto di consegna che dovevano essere dieci sono citate: “uno di nostra Donna (la Sacra Famiglia), lo quatro di Santo Georgi, lo quatro di San Martino, lo quatro di la Aportasioni di Cristo a lo templo, li Tri re, la Disputa, la Ascensioni di Cristo, la Missioni di lo Spirito Santo e lo Dio patri”. Non è citato il tema della Resurrezione. Come periti sono nominati per conto di Bernardino Nigro il siracusano Girolamo “lo spagnolo” (Girolamo Gomes) e per conto dei procuratori della chiesa un pittore chiamato il Calabrese. I periti non sono dello stesso avviso nel valutare la qualità del lavoro. Il perito nominato dai procuratori della chiesa e i procuratori stessi non accettano l’opera in quanto non dipinta a regola d’arte come previsto dal contratto del 1566. Si concede al Nigro un mese di tempo per intervenire nuovamente sull’opera e ove necessario raschiare alcune tavole per ridipingerle. Nel novembre dello stesso anno il Nigro riconsegna l’opera. Questa volta come periti si nominano per conto del Nigro un pittore di Lentini ( non è specificato il suo cognome); per conto dei procuratori (don Simone Salemi, don Matteo Di Tommaso, don Vincenzo …., don Benedetto Baglieri, il magnifico don Antonino Palazzolo, Giovanni Guarrasi, Giovan Pietro Cicero, don Pietro Lorefice) il maestro Antonino ( Adorno ?) di Noto. Le tavole questa volta sono accettate con un ruolo determinante del maestro Antonino di Noto. Il prezzo concordato sarà di 220 onze. Tra l’incarico del 1566 e la consegna risultano diversi acconti. Se la consegna delle tavole avviene nel 1571 nel polittico leggiamo due date riferite al 1773, con ogni probabilità i due anni saranno serviti per la realizzazione della cornice della cui realizzazione non sappiamo ancora l’autore. Ultima opera tardo rinascimentale iblea sarà quella della chiesa di San Giorgio di Ragusa. Nel 1571 per questa ‘cona’ marmorea sarà incaricato Antonino Gagini. I lavori, molto impegnativi, dureranno almeno due decenni. Di quel monumentale polittico absidale della vecchia chiesa di San Giorgio oggi ci resta il trittico collocato nella sagrestia di San Giorgio con le sculture di San Giorgio, Sant’Ippolito e San Mercurio, oltre alla Madonna col bambino nella cimasa e oltre agli altorilievi delle storie di San Giorgio e degli apostoli scapitozzati nella predella.
Dall’analisi delle opere di cui sopra emerge che per la scultura in marmo si farà riferimento a Palermo, a tre scultori della famiglia Gagini, e cioè Antonello, Giacomo e Antonino. Per la scultura lignea saranno scultori di Noto i protagonisti, mentre per la pittura ci si rivolgerà ad artisti netini e siracusani. Resta da chiarire il ruolo del Nigro che troviamo attivo a Caltagirone, a Catania e, soprattutto, a Modica. Il classicismo tardorinascimentale nel secondo Cinquecento è diventato in area iblea linguaggio comune. Per una nuova cultura manieristica bisognerà aspettare la fine del Cinquecento e il primo Seicento con la presenza nell’area del toscano Filippo Paladino.
Il monumento al Naselli è stato fotografato da Carlo Giunta.
Tutti i diritti riservati su testo e foto
© Riproduzione riservata














