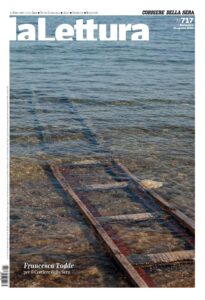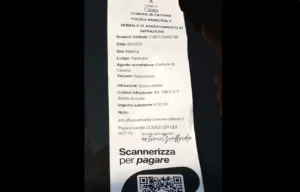di Redazione

Convegni e vari confronti, si sono tenuti sugli argomenti appena sopra citati, auspicando – con mezzi deboli e strumenti spesso incerti – pratiche virtuose attentamente individuate, che hanno comunque il merito di azioni necessarie per fare acquisire diffusa coscienza sociale. Ma, sappiamo bene come deve essere poi la politica, con azioni legislative volte a gestione le risorse del territorio e i pensieri della pianificazione territoriale, a materializzare quanto la coscienza culturale matura e la necessità sociale richiede.
Capisco, nel frattempo, come l’ideologia dominante non vuole attenzione ai problemi, se non c’è un consenso immediato. E questi temi, raramente lo ottengono. La cura del territorio, la vivibilità (non la bellezza, badate bene) delle città e del territorio, sono argomenti scomparsi dall’agenda politica. Sia a sinistra, che a destra: non ci sono. A scomparire è stato l’interesse per il bene comune. Essere autoscentrici, credo è diventato necessità collettiva, quando il paesaggio è “proprietà” visiva, d’uso, ecc: sociale. Nei nostri territori l’identità propria – sedimentatesi in centinai di anni – è stata stravolta per manipolazioni arbitrarie dissennate, che hanno inciso stabilmente l’equilibrio dei luoghi, con difficoltà di ritorno.
Oggi si discute molto di piani e di identità paesaggistica. Anche pensando al paesaggio, l’identità – se è anche altro – non può non essere un progetto del futuro in rapporto col passato nel contesto del resto del territorio. Che lo si sappia o meno, è sempre così. Se le identità sono soggettivamente plurime – e lo sono sempre – può essere considerato urgente sviluppare il senso della comunità di tutti gli sciclitani. Il senso dell’appartenenza e dell’unità di passato e futuro, che lega l’insieme delle persone al di là delle proprie diversità interne. Questo affinché un nuovo attaccamento al territorio diventi supporto e impegno a farci riscoprire il senso della cittadinanza: sciclitana, mediterranea, europea, ecc. Ma anche il senso – che deve essere alto – della legalità e dell’impegno civile, senza di che: ogni pianificazione non può avere fondamento stabile e unitario. Un piano che si dice paesaggistico comporta, prima di tutto, promozione di attività in campo politico, sociale, culturale, economico, scientifico, artistico e così via.
Se l’identità è anche legame emozionale della comunità con se stessa, essa è riconoscibile anche come legame con il territorio in cui una comunità vive, cioè col paesaggio, generato da pratiche, nozioni discorsi ed emozioni. Identità e paesaggio sono nozioni tanto poco dicibili, quanto molto efficaci e onnipresenti.
Eppure il paesaggio deve pensarsi come un processo di percezione di un territorio, senza implicare che ogni percezione (e azione che ne consegua) sia positiva e rispettabile. Infatti ogni percezione è da considerare, e da tenere in conto, come forza in campo, senza di che si continuano a fare errori “centralistici” o “illuministici” o “dirigistici” (Gambino, Romani, Camporesi). Conoscere gli elementi della percezione comune del proprio paesaggio da parte di una popolazione, e le diversità interne di questa percezione, è condizione imprescindibile per la pianificazione, soprattutto quando di quelle percezioni si voglia sia utilizzare e sia: mutare qualche aspetto.
Si insiste sul fatto che una definizione onnicomprensiva di paesaggio non può che essere troppo generale, generica e banale, dato che si può e si deve parlare di paesaggio geo-morfologico, vegetale, agrario, forestale, pastorale, storico, letterario, antropologico, sonoro, minerario, industriale, delle infrastrutture, urbano e così via. Una concezione unitaria di paesaggio si fa contrastare con l’impossibilità da parte di una sola persona di cogliere, individuare e ricomporre a sintesi tutte le sue componenti e, a maggior ragione, per le persone estranee ai luoghi, quel significato profondo, che è anche sentimento, evocato per indicare il legame tra le comunità che hanno modellato e vissuto quegli stessi luoghi.
Spesso si fa cenno, per i nostri territori, all’offerta di potentati dell’economia turistica, che cercano di determinare la configurazione generale del paesaggio. Se è così, non si comprende perché a ciò non debbano concorrere anche le istituzioni sovra-comunali e le istituzioni scientifiche che indagano sui processi degli ecosistemi e sulle conseguenze nella lunga durata degli interventi sul territorio. Concepire il paesaggio come percezione dei diretti interessati o comunque interessati a un territorio – lungi dal semplificare generalizzando – pone di fronte alla complessità dei problemi e richiede, operativamente non solo in quanto pianificatori, cercare di attingere una “integrazione delle percezioni dei vari soggetti ed una sintesi che recepisca l’interesse generale”, magari slegato dagli interessi contingenti di parte più o meno leciti. Intendere il paesaggio come percezione, dunque – a parte tutta la miriade di altre osservazioni – costringe a tenere conto dei ruoli di ognuno e di organizzare la partecipazione democratica ai processi di pianificazione paesaggistica, evitando il più possibile il prevalere casuale o di mero potere lobbistico, anch’essi legati e coerenti con interpretazioni soggettive del paesaggio e quindi anche a interessi sul territorio. La visione dinamica del paesaggio, come percezione, obbliga poi a una pianificazione in cui anche la fantasia visiva, applicata al futuro, previdente e quasi preveggente, abbia ruolo progettuale primario.
Delle volte, maldestre persone, mettono arbitrariamente, impedimenti e limiti alla “vista” e all’uso individuale nel godere di un paesaggio. Il tema dell’abusivismo non è più ai primi posti.
Forse perché la costruzione illegale e sconosciuta, dapprima, all’autorità pubblica e non ha più bisogno di nascondersi ed è diventata piena normalità a cui si fa l’abitudine? O l’autorità è così occhiuta e ben armata di strumenti repressivi da non farsi più fregare? O non è l’autorità – generalmente l’amministrazione comunale – a praticare essa stessa l’abuso legalizzato dal potere decisionista che fa e disfa a suo piacimento fuor d’ogni controllo pubblico e democratico? Sappiamo quale enorme potere detengano i sindaci (e i presidenti di Regione). I piani regolatori vigenti e i regolamenti edilizi – cioè le leggi – non contano niente. “Le amministrazioni tendono più a mutare i piani che a realizzarli”, dice l’urbanista architetto Sergio Rizzi. Non è soltanto abuso di autorità. C’è una specie di abusivismo a metà. Dovuto da una parte ai privati (proprietari, costruttori, progettisti) che, ottenuta una concessione o un’autorizzazione – soprattutto quelle relative a nuove norme insensate – la “interpretano” e la stravolgono per conseguire superfici e cubature maggiori. Da un’altra dovuto all’ente pubblico che, lui per primo, ammette interpretazioni insidiose, erode man mano la norma già assurda e la trasforma nell’accettazione di una realtà avulsa dagli scopi della normativa, peraltro spesso pretestuosi.
Poi l’abusivismo in libertà assoluta. Quello di vecchio stampo, che nel territorio sciclitano bene si conosce: abuso totale. Nuova costruzione senza regole.
Una volta se costruivi una casa su terreno dello Stato: diventava automaticamente proprietà pubblica. Ora non più: basta pagare e sei tu a prenderti la terra pubblica che hai occupato. Cosa possa significare per il Demanio, soprattutto in certe aree meridionali, è facile poterlo immaginare.
Che l’unico modo di sanare un abuso è la demolizione: credo di non dire un’assurdità. Se un manufatto è stato realizzato senza nessuna conformità alle previsioni di Piano – quindi di legge – e alla vocazione naturalistica del luogo, va cancellato. Non va espropriato ed acquisito dall’amministrazione, perché – è facile capire – non è il passaggio di proprietà che sana, quanto la demolizione. Ma non è un problema di etica, né di regolamentazione. Quello dell’abusivismo, è un problema profondamente radicato nell’arroganza storica dell’occidente dominante. Nella peggior aggressione sconsiderata del territorio, manifesta la sua concezione proprietaria della legalità e del potere.
Confido sempre nelle giovani generazioni, perché i grandi, gli adulti: ormai li credo irrecuperabili. Avendo avuto studenti di Scicli e di altri centri del ragusano, so che quella di dare il proprio contributo al luogo natio: è un’esigenza nuova, ma sempre più diffusa tra i giovani più acculturati.
So bene che introdurre limiti di vario tipo in un territorio potenzialmente ricco sotto il profilo turistico – anche su questo tema “turistico” andrebbe aperta una discussione – , e perciò appetibile dal punto di vista della rendita immobiliare: comporta scontri più che confronti. Inevitabilmente questo appetito genera forti conflitti, ma – vi chiedo – non è arrivato finalmente il tempo che si smetta di pensare che sviluppo equivalga a edilizia nelle coste e che, anche a Scicli, le regole vengano considerate le sole che possano garantire equità e sviluppo duraturo, invece di viverle come una limitazione di una presunta libertà individuale?
Un giorno – vi prometto, tempo e pazienza permettendo – farò un accertamento come procedura di ricerca verso un riscontro. Il metodo è quello di comparare fotografie aeree zenitali odierne, con le mappe ufficiali dall’Agenzia del Territorio (Catasto). Quindi riguarda la individuazione e la presenza o meno di intere costruzioni abusive.
Altro campo di ricerca – questo con fattibilità più sicura – è quello di confrontare lo stato della pineta di Sampieri in questi ultimi 40 anni – tramite documenti fotografici da prese zenitali già in mio possesso – così da evidenziare e seguire le trasformazioni virulente di questi ultimi anni.
Ma poi … sapete … mi viene il dubbio … posso fare tutto questo come attività di ricerca che istituzionalmente svolgo in ambito accademico alla rincorsa di una consapevolezza, ma credo sarebbe giusta azione – rivolta al buona governo del territorio – che tutti questi gesti venissero approntati dalle amministrazioni che sono poste alla salvaguardia del territorio. Ma le amministrazioni, hanno questa volontà? Hanno rigore e serenità per evidenziare tutto lo sfacelo del quale, anche in minima parte, sono complici per mancato o non adeguato controllo?
Altro interrogativo riguarda la democrazia. Si possono avere diversità di vedute ed anche interessi privati da tutelare, ma il confronto va fatto nelle ufficiali sedi pubbliche e con le diverse forme di partecipazione che ogni comunità può scegliersi in modo civile. Come mai in alcune aree della Sicilia – e Scicli rientra in queste aree – le controversie sono portate avanti con strumenti di intimidazione di varia natura? Prepotenza esercitata da un ristretto numero di persone, ma che la maggioranza silente e connivente subisce.
Oppure, forse, i cittadini di Scicli non sono maturi – culturalmente e umanamente – per comprendere l’eccezionale negatività dell’esperienza che stanno vivendo e condividendo? La speranza è che gli abitanti di questo meraviglioso territorio – ancora ricco di un residuo equilibrio tra vita dell’uomo e vita dell’ambiente – si raccolgano attorno al loro Municipio: che non è solo un Palazzo, ma deve essere un gruppo di uomini coraggiosi, dotati di buona volontà, competenza, saggezza, e li stimoli ed aiuti a resistere e ad andare avanti, sulla strada di fruttuose iniziative di salvaguardia.
Ultima riflessione per una differenza
Come più volte riportato da questo giornale, il Governatore della Sicilia Raffele Lombardo è titolare di un abuso nel territorio di Ispica in contrada Marza. A tutt’oggi non si sa se ha finalmente dato un segnale di legalità demolendo l’abuso come promesso.
http://www.sciclinews.com/news/Goletta-Verde-e-i-dossier-di-Legambiente-sulle-villette-di-Renelle-Trippatore/0000005359
Per contro il Governatore della Sardegna Renato Soru, si è dimesso dall’incarico per bocciatura della legge sull’Urbanistica sarda. All’atto della dimissione ha sostenuto “Il Piano paesaggistico regionale è stato parte fondamentale di questa legislatura. Disconoscerlo, in qualunque modo, è un fatto grave, che dovrà essere preso nella giusta considerazione da parte di tutti noi”. Non si è trattato di un no da nulla, il provvedimento non approvato avrebbe dovuto sostituire la vecchia normativa del 1989 per completare il programma di governo del territorio voluto da Soru, cominciato con la legge “salvacoste” del 2004 e proseguito con il Piano paesaggistico. Soru ha reso noto durante il suo intervento in Consiglio Regionale in cui ha annunciato le sue dimissioni “non sarà l’ultimo giorno della mia esperienza politica. Ho servito con tutta l’onestà possibile di cui sono capace, mettendo al primo posto l’interesse dei sardi e credo di servirlo anche oggi con la mia decisione”.
Da una parte si usa e si abusa, dall’altra si cerca di riparare con piani e strumenti adeguati.
Pasquale Bellia
Tutte le foto sono di P.B.

© Riproduzione riservata