di Redazione
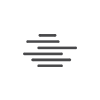

Ragusa – Che il tartufo esista anche in Sicilia è cosa nota anche se non al grande pubblico. Abbiamo sempre sentito parlare del tartufo delle Langhe, di quello dell’appennino Umbro- Marchigiano e di quello del senese, varietà molto pregiate e molto ricercate dai palati raffinati, oltre ad essere un vero e proprio business. Eppure, anche la Sicilia è terra di tartufi e ne esistono diverse varietà, alcune anche molto ricercate. A confermarlo, ci sono diversi studi e tantissimi ricercatori del settore. Il tartufo, infatti, potrebbe costituire un prodotto di nicchia economicamente vantaggioso. Ma esiste nell’area iblea? E dove si può trovare in Sicilia? Gli esperti sostengono di si: alcune varietà sono state trovate anche nell’area dei Monti Iblei, sia sul versante siracusano che su quello ragusano. In effetti, però, gli amanti di questo prodotto dall’inconfondibile profumo e i ricercatori del settore, sanno che il tartufo in Sicilia è conosciuto almeno dall’Ottocento, avendone parlato sia scrittori che scienziati. Per farci aiutare in questa complicata materia abbiamo chiesto aiuto al professor Giovanni Amato, biologo, micologo, profondo conoscitore degli aspetti naturalistici dell’area iblea che ha collaborato con il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Ateneo di Catania. Dal gennaio 2013, inoltre, è direttore della sezione naturalistica del Museo Civico di Monterosso Almo, suo Comune d’origine e come direttore della sezione naturalistica del Museo Civico ha avviato indagini sulla flora micologica degli Iblei ragusani, avvalendosi per i tartufi della collaborazione del signor Mario Brinch di Ragusa.
CHE COS’E’ IL TARTUFO?
Il tartufo è un fungo ipogeo appartenente alla Ascomycetes. Il particolare e inconfondibile odore odore dei tartufi è dovuto all’esigenza di questi funghi di attrarre animali che, dissotterrando il corpo fruttifero ipogeo, favoriscono la dispersione delle spore.
UN PO’ DI STORIA
La scoperta del tartufo in Sicilia viene attribuita comunemente a Giuseppe Insegna che avrebbe trovato questo tipo particolare di fungo in un vaso nel giardino botanico di Palermo nel 1874. Il realtà il primo ritrovamento del tartufo in Sicilia è documento di almeno una trentina d’anni prima, nel 1845, da parte di due studiosi, Taranto e Gerbino che avrebbero scovato i tartufi nella zona del bosco di San Pietro, fra Niscemi e Caltagirone. Queste, le notizie scientifiche e documentate riguardanti il ritrovamento. Ma esistono anche diverse notizie “letterarie” di scrittori che ne hanno parlato, incidentalmente, nelle loro opere. Ne parlava, ad esempio, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel suo Gattopardo: il principe Salina, infatti, amava un piatto che chiama “Timballo e tartufo”. Interessante anche il fatto che ne parli uno scrittore “chiaramontanissimo” come Serafino Amabile Guastella in uno scioglilingua che così recita: “Don Cristofulu ccu i trufuli e i scrufuli, scrifuliannusi e trufuliannusi cristufulia”, brano tratto da “Le domande carnascialesche e gli scioglilingua del circondario di Modica 1888”. “Trufuli”, infatti, è il nome dialettale dei tartufi.
E’ POSSIBILE COLTIVARE UN TARTUFO?
In linea di massima si è portati a pensare che il tartufo sia un prodotto selvatico, difficile da coltivare. In realtà non è esattamente così. Esistono, infatti, le cosiddette “tartufaie”, appezzamenti di terreno creati apposta per permettere la coltivazione di alcune specie di tartufi. In Sicilia esistono? Giovanni Amato, spiega: “In Sicilia esiste un’azienda a Burgio che si chiama “Tartufi Montalbano”. L’Azienda Montalbano si occupa di tartuficoltura e realizzazione di impianti di tartuficoltura in tutta Sicilia, Iblei compresi. Questa azienda non si occupa solo del lato economico, ma anche della ricerca, infatti producendo piante micorizzate è possibile fare in modo che un tartufo possa stringere simbiosi con la pianta in vivaio. Solitamente si tratta di alberi appartenenti alla famiglia delle querce, come i lecci, ma anche pini. Impiantando il vegetale, dopo qualche anno è possibile che nasca un tartufo per la commercializzazione. Abbiamo parlato anche pubblicamente di queste operazioni il 30 aprile in una conferenza all’antico monastero di Ibla. In tale conferenza, infatti, abbiamo cercato di parlare delle potenzialità dei prodotti dell’area iblea, compreso il poco conosciuto tartufo. La Tartuficoltura, può diventare veramente una forma di sviluppo economico. Basta pensare al fatto che anche la Nuova Zelanda coltiva tartufi. Naturalmente, non è possibile ricreare tutte le specie in coltivazione. Ad esempio, non è possibile coltivare il tartufo bianco, considerato il più pregiato, in quanto non si riesce a capire quale sia la sua simbiosi”.
LE VARIETA’ IN SICILIA
A dispetto di quanto si possa pensare, in Sicilia esistono molte varietà di tartufi: Tartufo nero estivo o scorzone – Tuber aestivum, Tartufo uncinato – Tuber aestivum var. uncinatum, Marzuolo o bianchetto – Tuber borchii, Tartufo nero invernale – Tuber brumale, Tartufo nero pregiato – Tuber melanosporum e infine anche il Tartufo bianco pregiato – Tuber magnatum ritrovato per la prima volta in Sicilia nel 2013 dal Dottor Giovanni Enrico Vasquez dell’Associazione Micologica di Bresadola, gruppo di Catania, nell’area di Piazza Armerina.
LA LEGISLAZIONE IN SICILIA SUI TARTUFI
C’è da dire che a differenza di altre Regioni d’Italia in cui il tartufo è diventato quasi un simbolo, in Sicilia siamo ancora piuttosto indietro con la legislazione in merito a questa materia. C’è, infatti, un vero e proprio vuoto legislativo su ciò che riguarda il mondo dei tartufi, mentre per quanto riguarda la raccolta del funghi epogei si fa riferimento alla legge regionale 3/2006 (sull’acquisizione del tesserino, le ore di formazione, ecc.). Per quanto riguarda invece i fungi ipogei, cioè i tartufi, per procedere alla raccolta si fa riferimento alla legge nazionale. Amato, infatti, precisa: “Se ne parla da anni di fare una legge regionale, ma ancora non abbiamo visto nessun risultato. I cavatori di tartufi, infatti, per regolare il prezzo si rifanno alla produttività stagionale. Quest’anno, ad esempio, i continui sbalzi climatici non hanno favorito molto la raccolta di prodotti spontanei. Ogni specie, comunque, ha un proprio prezzo e in linea di massima ci si attiene alla borsa del tartufo di Alba”.
I CANI DA TARTUFO
E’ la legge ad obbligare il cavatore di tartufi ad usare il cane. Giovanni Amato, infatti, spiega: “In altre zone d’Italia, ad esempio, fino agli anni ’50 venivano usati i maiali, in quanto hanno ottime capacità olfattive e riescono a penetrare il terreno con il grugno più di un cane. Oggi, tale pratica è abbandonata e si usano per la ricerca di tartufi alcune razze canine. Molto apprezzata è il Lagotto Romagnolo, originariamente usato per la caccia in ambienti acquatici. Ma si presta bene anche un buon incrocio di bracco italiano. Al cane spetta, secondo la legge, il compito di segnalare e non di scavare. La ratio dietro la legge è squisitamente ambientale perché molto spesso alcuni cavatori utilizzano cani da riporto: il cane porta in bocca il tartufo al padrone il quale si lascia dietro buche che non favoriscono la rinascita del tartufo. Il padrone, invece, dopo aver avuto la segnalazione del cane, deve scavare nel terreno, raccogliere il tartufo e ricoprire la buca. Sarebbe auspicabile che i cavatori non facciano ciò solo per seguire una legge, bensì proprio per etica”.
I TARTUFI NELL’AREA IBLEA
Nel nostro territorio i tartufi esistono e sono disseminati sui Monti Iblei sia sul versante siracusano che su quello ragusano. Giovanni Amato, infatti, spiega: “Il più diffuso è il nero estivo, legato a particolari condizioni di suolo, senza ristagni d’acqua. Predilige, infatti, un terreno con elevato valore calcareo, per questo è diffuso in tutta l’area iblea e non, ad esempio, sull’Etna, che ha un suolo acido. Personalmente, ho ritrovato tartufo nero estivo a Ragusa, Chiaramonte, Monterosso, Modica e Scicli. Non dico che ci siano grandi quantità ma esiste. Il mio interesse, poi, non è certo commerciale, piuttosto è per un fine scientifico. E proprio perché vorremmo che molta gente si avvicinasse a questo mondo, a partire dal 13 novembre, insieme all’associazione culturale Nivèra, terremo un corso di formazione micologica a Chiaramonte. Ma il nero estivo si trova anche a bosco San Pietro, a Caltagirone e alla sughereta di Niscemi”.
IL MARCHIO TARTUFO SICILIANO
Si discute da tempo su questa possibilità ma in merito a questo argomento Giovanni Amato è scettico. Il biologo, infatti, spiega: “Creare un marchio per il tartufo siciliano è difficile perchè non ha caratteristiche specifiche rispetto agli altri tartufi d’Italia. Basta pensare al fatto che è stato creato un solo marchio per i tartufi e riguarda il tartufo bianco di Alba. La difficoltà che si ha ad individuare la terra iblea come terra dei tartufi è dovuta allo scempio delle risorse naturali fatto nel corso dei secoli. Edrisi, geografo arabo del XII secolo, descriveva Monte Lauro come ricoperto da estese foreste. Nel 1808 Paolo Balsamo parlava del rigoglio dei boschi di querce fra Monterosso e Chiaramonte. Nel 1886 Antonio Dell’Agli raccontava che il territorio di Giarratana aveva 60 ettari di boschi di querce. Oggi, tutto questo, è solo un ricordo. Venendo a mancare le condizioni ideali, vennero a mancare i tartufi. Forse oggi, grazie all’impianto delle pinete, stanno tornando”.
© Riproduzione riservata














