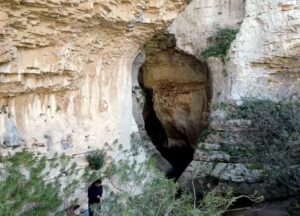Una memoria di Giuseppe Pitrolo
di Giuseppe Pitrolo

Il 23 Maggio ricorre il ventesimo anniversario dalla morte di Giovanni Falcone.
Céline: “la grande sconfitta, in tutto, è dimenticare“.
Santayana: “Quelli che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo“
Giovanni Falcone. Francesca Morvillo. Rocco Di Cillo. Antonio Montinari. Vito Schifani.
Paolo Borsellino. Agostino Catalano. Walter Cusina. Vincenzo Li Muli. Emanuela Loi. Claudio Traina.
Uccisi dalla Mafia: il 23 Maggio 1992 (alle ore 17.58) e il 19 Luglio 1992 (alle 16.55).
E tanti altri nomi: Emanuele Notarbartolo, Placido Rizzotto, Salvatore Carnevale, Pietro Scaglione, Boris Giuliano, Cesare Terranova, Lenin Mancuso, Giuseppe Impastato, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Giangiacomo Ciaccio Montalto, Paolo Giaccone, Rocco Chinnici, Beppe Montana, Ninni Cassarà, Claudio Domino, Pino Puglisi, Libero Grassi, Rosario Livatino, Giuseppe Di Matteo,…
E Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Uccisi dalla Mafia. A Palermo. Da due attentati. Nel ’92. Vent’anni. Un secolo fa.
Falcone a Capaci, sulla strada che porta dall’aeroporto a Palermo. Con il tritolo che provocò voragini e terrore.
Dopo 2 mesi, Borsellino. In Via D’Amelio. Nella più classica e tragica delle morti annunciate.
“E fu (…) la rovina, lo strazio, il ludibrio della carni” (Vincenzo Consolo).
Fu lo sgomento. Il senso di resa.
Antonino Caponnetto disse: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano di “quelle creature che raramente Dio manda sulla terra, a una terra che non se le merita“.
Eppure dopo pochi mesi Gian Carlo Caselli diventò Procuratore a Palermo, Totò Riina e tanti altri latitanti furono catturati. Allo smarrimento subentrò l’operosità.
Tuttavia da qualche tempo il clima è mutato: la criminalità sta nascosta, presidia il territorio, lo Stato a volte sembra aver altre priorità.
Ma noi dobbiamo ricordare. Continuare.
Fra disperazione e speranza.
Perché, come diceva Falcone, “la mafia è umana. E come tutte le cose umane ha un inizio e una fine”.
La lotta alla mafia è un cammino lungo, ma non interminabile.
Falcone e Borsellino erano due magistrati. Siciliani. Palermitani. Cresciuti nel quartiere popolare della Kalsa, attorno a piazza Magione. Accanto a coetanei che sarebbero diventati capimafia.
Entrano in magistratura nei primi anni Sessanta. Lavorano a Palermo dagli anni Settanta ai primi anni Novanta.
Sono ironici e malinconici, distaccati e appassionati. Grandi lavoratori. Siciliani e anti-siciliani.
Somigliano a certi siciliani descritti da Sciascia, che ne “Il ’48” così faceva dire a Nievo: “Io credo nei siciliani che parlano poco, nei siciliani che non si agitano, nei siciliani che si rodono e soffrono: i poveri che ci salutano con un gesto stanco, come da una lontananza di secoli; e il colonnello Carini sempre così silenzioso e lontano, impastato di malinconia e di noia ma ad ogni momento pronto all’azione: un uomo che pare non abbia molte speranze, eppure è il cuore stesso della speranza, la silenziosa fragile speranza dei siciliani migliori… Una speranza (…) che teme se stessa, che ha paura delle parole ed ha invece vicina e familiare la morte“.
Il 25 Settembre del ’79 il giudice Terranova muore in un attentato: il giorno dopo Falcone presenta domanda per entrare a far parte dell’ufficio istruzione, guidato da Rocco Chinnici.
Definisce centinaia di processi.
Nel Maggio del 1980 Chinnici gli assegna il processo Spatola, processo intricato fra droga, mafia italiana e mafia americana. Quindici avvocati si recano da F. per raccomandargli “maggiore giudizio”.
Falcone si concentra sulla consistenza patrimoniale, indaga sui conti bancari. Comprende che la mafia è un fenomeno ramificato, perciò è necessario confrontarsi con i colleghi che si occupano di mafia in altre città italiane e negli Stati Uniti: nel Dicembre dell’ 80 quindi si reca a New York, dove inizia la cooperazione con il procuratore distrettuale Rudolph Giuliani.
Borsellino negli stessi anni lavorava sulle carte scoperte nel covo di Leoluca Bagarella.
Falcone e Borsellino si rendono conto che stanno indagando sull’identica organizzazione criminale: in pratica, nasce il pool anti-mafia.
Ma nell’Estate dell’83 Rocco Chinnici viene ucciso.
Tuttavia Antonino Caponnetto, a 63 anni, dal tranquillo tribunale di Firenze fa la domanda per essere assegnato all’ufficio istruzione di Palermo. Nell’Autunno del 1983, perciò, è a Palermo, dove conferma i metodi di Chinnici: ovvero la socializzazione fra i giudici istruttori delle esperienze, la massima circolazione di notizie. Falcone e Borsellino vengono valorizzati, con Di Lello e Guarnotta.
Dall’Estate del 1984 l’ex mafioso Tommaso (“Masino”) Buscetta inizia a collaborare con il pool di Palermo: Caponnetto afferma: “Siamo finalmente penetrati nel cuore della struttura dell’organizzazione mafiosa. Finalmente il cuore si apre alla speranza“.
Con il conseguente blitz di San Michele centinaia di mafiosi vengono arrestati.
Migliaia di giovani sfilano per Palermo applaudendo: per il commissario Ninni Cassarà “una manifestazione come questa significa che a Palermo stanno davvero cambiando molte cose“. Falcone approva: “fanno il tifo per noi“. Borsellino anni dopo dirà: “Il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze“.
Si arriva al “maxi-processo”, che per Borsellino (27.1.85) “sarà solo una prima tappa, l’inizio di una fase nuova. Non esprimo una semplice speranza: il lavoro istruttorio che si è chiuso è destinato ad aprire altri orizzonti”. “Non ci siamo basati solo sui ‘pentiti’: ma su prove come intercettazioni telefoniche, materiale bancario e patrimoniale“.
A fine ’87 il sessantasettenne Caponnetto torna a Firenze: indica come suo continuatore ideale Falcone. Ma il CSM a Gennaio ‘88 sceglierà Meli, perché più anziano.
Dirà Caponnetto: “Falcone cominciò a morire nel Gennaio ’88“. E Borsellino: “Lo Stato cominciò a farlo morire quel giorno“.
Falcone, con parole profetiche, il 25 Giugno del 1988 affermerà: “Il declino di Cosa Nostra, più volte annunciato, non si è verificato, e non è purtroppo neanche prevedibile (…) Non pochi uomini politici siciliani sono stati e sono ancora adepti di Cosa Nostra (…) Non è possibile trarre buoni auspici dalla drastica riduzione dei fatti di sangue“.
Borsellino un mese dopo (16.7.88) denuncerà la “smobilitazione dell’Antimafia (…):fino a poco tempo fa le indagini erano centralizzate,così come è centralizzata Cosa Nostra: ora invece sono disperse in mille rivoli. (…) L’ultimo rapporto di polizia degno di questo nome risale al 1982“.
Il 19 Giugno ‘89 Falcone scamperà all’attentato dell’Addaura: da parte dello Stato non ci sarà alcuna risposta: solo la minimizzazione (qualcuno insinuerà che l’attentato era stato una messinscena del magistrato!).
Nella Primavera del 1991 Falcone capisce che a Palermo non potrà più combattere la Mafia: accetta perciò il trasferimento al Ministero di Grazia e Giustizia, per continuare a lottare. Diversi partiti gli avevano chiesto di candidarsi alle elezioni: lui risponde: “ma quando riusciranno a capire che a me piace fare solo il mestiere che faccio?“.
Falcone, cioè, è morto perché ha voluto fare fino alla fine il magistrato.
Nel Maggio 1992 l’attentato di Capaci. La strage. La morte.
Paolo Borsellino sa che è arrivato un grosso quantitativo di esplosivo: “Quell’esplosivo è per me“, dirà: e, come un personaggio di Garcia Marquez, Borsellino va verso, lo ribadiamo, la propria morte annunciata.
Il 19 Luglio del 1992 l’attentato di Via D’Amelio.
Dopo le stragi, dopo il martirio degli uomini delle istituzioni, ci fu (finalmente!), la risposta da parte dello Stato. La mobilitazione della società civile. I sequestri di beni alla Mafia per migliaia di miliardi.
Eppure sembra che il clima negli ultimi anni sia cambiato.
Il Procuratore Pietro Grasso ricorda che “ora la Mafia è meno visibile e quindi più pericolosa; non è visibile per i mass media“.
Basti pensare che nel settembre del 1991 Maurizio Costanzo e Michele Santoro avevano tenuto a reti unificate, dal teatro Massimo di Palermo, una trasmissione (vista da più di 14 milioni di cittadini) per ricordare Libero Grassi, l’imprenditore palermitano ucciso, nell’inerzia dello Stato, perché non aveva voluto pagare il “pizzo”: ora…
Secondo Caponnetto: “Ora non è come nel ’92, non c’è quella speranza: ora c’è solo consumismo: si mercifica tutto“.
E tuttavia dobbiamo andare oltre la rassegnazione: imparare da Falcone e Borsellino. Abbiamo sbagliato a pensare che bastassero loro.
Scrive Caselli: “Sono morti perché noi non siamo stati vivi“.
E Borsellino aveva detto: “La lotta alla mafia è un compito di ognuno di noi. Ognuno per quello che può, ognuno per quello che sa“: “la lotta alla mafia non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà, che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”.
Le nuove sfide sono già arrivate: innanzitutto i fondi europei che stanno pervenendo nella nostra isola: dobbiamo vigilare tutti (cittadini, ogni schieramento politico, sindacati, forze dell’ordine, magistrati) perché queste risorse creino sviluppo per i siciliani e non ricchezza per i mafiosi.
L’altra sfida è la globalizzazione del crimine: Falcone nel 1990 scriveva che bisogna abolire “i cosiddetti paradisi fiscali, che fino ad oggi hanno reso vani i tentativi di alcuni paesi per identificare i flussi di denaro provenienti da attività illecite“.
Bisogna continuare a ricordare chi è morto per noi.
Borsellino, parlando il 20 Giugno del 1992 di Falcone, affermava: “Occorre evitare che si torni ancora indietro. Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito lo dobbiamo pagare, gioiosamente continuando per loro, facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono dei sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro.
Collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo anche nelle aule di giustizia, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità, dimostrando all’Italia e al mondo che Falcone (e Borsellino) sono vivi!!”.
© Riproduzione riservata