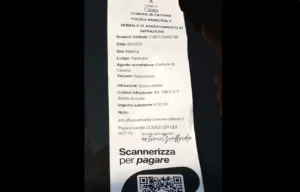Saverio Avveduto, nel 1950 giovane docente al Liceo di Scicli, vinse il suo primo premio letterario
di Redazione


Scicli – Grazie a un prezioso archivio messo a disposizione dal preside Antonino Lauretta, pubblichiamo oggi un racconto dell’intellettuale Saverio Avveduto (scomparso il 18 febbraio del 2021 alla veneranda età di 97 ann), ambientato a Scicli. Ispicese di nascita, nel 1950, il professor Avveduto vinse il concorso per insegnamento in storia e filosofia e prese cattedra a Scicli. Socialista della prima ora, fu poi docente universitario in Sociologia alla Sapienza di Roma, e personaggio di rilievo della cultura italiana nel Secondo Novecento, quando la sua ricerca interseca quella di Jorge Luis Borges, Leonardo Sciascia, Tullio De Mauro, solo per citare i personaggi che pubblichiamo in foto con Avveduto.
Con questo scritto, l’autore, allora giovane docente al Liceo di Scicli, vinse nel 1950 il suo primo premio letterario: “un assegno bancario per assistere alle rappresentazioni classiche, (di Siracusa n.d.r.), comprensivo delle spese di soggiorno”, annotò il 7 maggio di quell’anno il quotidiano la “Sicilia”. Soprende l’attualità (non nuova, certo, ma aspramente offerta), del discorso di Avveduto: il vivere, cioè, come peso che non si riesce a deporre né a portare. Ecco il racconto.
La maledizione del vivere
di Saverio Avveduto
-Signor Professore, La prego di non interrogarmi, oggi; non ho potuto prepararmi ieri pomeriggio.
-Davvero? E come mai?
– Signor Professore…
-Suvvia, ormai ci conosciamo, tu sai bene che io preferisco la verità, quale che ess sia, alla menzogna disonesta.
– Signor Professore… c’erano troppi morti da seppellire ieri, ho dovuto aiutare mio padre.
-Perché tuo padre…
– Sì, è il custode del cimitero.
***
Caso non contemplato, questo, per un professore; e così mi trovai nella situazione del Don Lollò di pirandelliana memoria. Ma poiché in classe la cattedra è al contempo potere legislativo ed esecutivo, assolsi il reo.
Incantevole, il cimitero di Scicli, tutto a terrazze e gradoni. E con il mare per sfondo. Come un teatro greco. Veramente accogliente, con quella sua anticamera a lato – il tubercolosario – e il suo secondo centro di rifornimento, il paese, un po’ più in là e volto ad oriente. E così il sole, a Scicli, prima che i vivi, saluta i morti.
Pertanto anche se voleste dubitare che a Scicli – come un po’ dovunque – conviene morire, sarete certo d’accordo con me che conviene morire a Scicli.
***
Teatro. Immaginate l’atroce condanna se ognuno di noi fosse costretto a rimanere sempre e soltanto se stesso? Un professore di filosofia continuamente altalenantesi fra Parmenide ed Eraclito? Un giudice eternamente teso a distinguere il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto, come Psiche condannata a
… “sceverare i grani
d’orzo, i chicchi di miglio, le rotonde
Vecce, i bislunghi pippoli di avena”?
Un medico perennemente in mezzo ai disfacimenti della carne, alle torture fisiche e psichiche, sempre così vicino all’altra sponda?
Ma per fortuna, noi spesso ci dimentichiamo.
I rinascimentali scoprono l’individuo. Ma ora pare che “l’essere sempre noi” ci pesi troppo. E quindi, di scatto, diventiamo altro da noi, altri cioè.
Ecco il teatro. Viviamo per suo mezzo vite innumerevoli -Eraclito – e nella ridda dell’essere ciò che potevamo essere e non siamo stati, stanchiamo un po’ la nostra ansia di infinito: novelli Kant, viaggiamo attraverso gli atlanti geografici.
Ma non riusciamo mai a dimenticare noi stessi: la nostra personalità. – Parmenide – che ci segue sempre come l’ombra di un cadavere che non abbia avuto sepoltura.
Teatro greco di Siracusa. Eccolo, scolpito, scolpito e avvolgente, come un’inquietante “intuizione intellettuale” dell’anima umana.
L’anima, cioè, fuori del tempo e dello spazio.
Io la vedo eterna, l’anima, nel teatro greco di Siracusa: rappresa nelle sue gradinate color grigio-eternità, sfingea.
Eppure inquadrata, anch’essa, nella mobilità vertiginosa del tempo e nell’impalpabilità dello spazio. Quella cavea “sta” da venticinque secoli nel turbinare senza tregua di istanti incontabili.
Il teatro greco di Siracusa ogni tre anni, a primavera.
Quell’anima allora parla, e ci rivela l’identità sostanziale della sofferenza, antica e fatale come la noia, cui soggiace l’umanità tutta.
E’ come se scoperchiaste di colpo tutte le tombe di un cimitero per sentire dai redivivi il racconto delle loro pene che sono le vostre, dei loro sogni sbriciolati che sono i vostri. La nostra inutile ed eroica fatica di Sisifo.
A che vale allora l’immensa pròodos cosmica? Nulla. “Sereno è il paesaggio di Colono, ma la vita è inutile e infelice. Così Sofocle nel famoso stasimo, epicedio della maledizione del vivere. E Shakespeare: vita è una favola contata da un idiota – piena di rumore e furore- che non significa niente. Il coro della magrolina Antigone di Anouilh riecheggia il destino dell’inutilità: “Tutti quelli che dovevano morire sono morti. Quelli che credevano una cosa e quelli che credevano il contrario. Anche quelli che non credevano niente e che si sono trovati coinvolti nella faccenda (la vita) senza capire niente”. E la Medea di Alvaro, come la sua collega transoceanica di Robinson Jeffers, conclude: “Non ha senso la vita”.
Così Hofmannstahl, Gide, Giradoux, Cocteau, tutti coloro che oggi (1950) vivono ancora lo stesso dramma del V° sec. a.C. e lo riesprimono nel bel riuscito tentativo di lanciare un arditissimo ponte per congiungere il presente istantaneo e il passato di pietra in un balzo vertiginoso su un baratro di 30 secoli, rifacendo a ritroso la via del folle Ulisse: il mondo “nuovo”, tutto proteso verso le conquiste dell’avvenire, alla piccola terra pietrosa, Itaca, culla dei nostri sogni e della nostra disperazione.
La disperazione fatta pietra è il Teatro greco di Siracusa, “anima umana al di fuori del tempo e dello spazio”.
Ma perché, perché, ci chiediamo noi con secolare struggimento, perché il Nulla? E come sempre, andiamo in cerca di un pensiero rivelatore. “Re Pensiero” siede, come lo vide Edgard Poe, coronato sopra un trono di dolore in una reggia incantata. Questa volta però il nostro fanatismo per Re Pensiero – la tragedia intellettuale – ci porta a detronizzare il nostro sovrano; poiché al fondo del perché d’ogni cosa sta una sola parola: irrazionale.
Irrazionale significa mito, lirica, tragedia, volontarismo ed eresia, romanticismo ed estetismo, esistenzialismo, intuizionismo: Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Sartre, Leopardi e quant’altri.
L’auriga del Fedro che porta con sé la religione, la filosofia, l’etica, sente annuvolarsi la vista; i cavalli, sbrigliati e furiosi, spiccano il salto e il volo oltre ogni limite di strada.
Ricordate l’Aiace rivissuto a Siracusa nel 1930? Egli è il primo eroe “individuo” che si sente lontano, cioè, dalla uniformità banale e ostile del mondo. Per questo diventa folle ma, ritornato saggio, a Tecmessa che appassionatamente lo vuole convincere sulla passionalità della vita e cioè della sua irrazionalità (e così dissuaderlo dal proposito interiore del suo autoannullamento), risponde che la “vita è problema” cioè razionale, risolubile quindi. Ma la soluzione che egli sceglie, il suicidio, segna il trionfo dell’irrazionale, poiché “vita felicissima è l’essere privi della coscienza del piacere e del dolore”. L’unica cosa da volere è il Nulla.
Aiace però è “individuo”, e il suo dramma potrebbe avere in lui stesso prologo e catastrofe. E’ possibile intenderlo, questo dramma, come condizione basale dell’umanità tutta?
Vediamo, allora, consideriamo la vicenda diacronicamente, non più in un unico soggetto ma in tre generazioni, quella degli Atridi: i tre anelli di una catena che li vincola e li sorpassa; forse valgono a dimostrare la coessenzialità all’uomo dell’irrazionale.
Siamo così all’Orestea, rievocata dall’ultima “Olimpiade siracusana”.
Io sono d’opinione che la tragedia degli Atridi è così immane, che l’aver dato ad essa il più definitivo svolgimento, – pure sotto un solo aspetto, quello religioso – basta ad Eschilo come titolo perenne di gloria.
Cosa potrebbe esserci di più solenne di questo tempio della sventura umana qual è l’Orestea? Nulla, veramente nulla. Eppure anch’essa ha qualcosa di incondito, il canto sacro delle Erinni divenute Eumenidi, il lirismo in cui si risolve la cupezza della trilogia, l’equilibrio, la catarsi, l’assoluzione di Oreste insomma, non sono che provvisorie. Qui risiede infatti l’errore. La razionalità, con Eschilo, alla fine trionfa, l’equilibrio vince, ritorna; ma la soluzione è religiosa: è l’espressione di una esigenza più che la constatazione di un fatto.
Qual è invece il fatto? Ecco, questo: posta la premessa irrazionale (il delitto di Atreo) la catena non può più rompersi, ogni tentativo di ingabbiare l’irrazionale nello schema del logos, dell’equilibrio, è provvisorio, lirico più che filosofico; è l’aspirazione al riposo, al mondo migliore, all’isola lontana ai duri mortali travagli, tutti bei sogni, i quali non mutano d’un iota la realtà, e che pertanto non sono capaci di esprimerla, perché la trascendono.
Ed allora? Ecco, allora Sofocle al lavoro; ecco nascere una nuova Elettra, l’implacabile vergine matricida. Attorno a lei si sposta il centro del dramma e – come vedremo – è giusto che sia così. Euripide completa lo spostamento: la sua Elettra sanguinaria e rivoltante, è l’unica possibile; come quella moderna di Hofmannstahl.
Ma se Euripide fissa la figura di Elettra, non riesce a risolvere quella di Oreste; segna però un passo originalissimo su questa strada, proclama sicuro che il delitto di Oreste non può trovare espiazioni; è impossibile l’equilibrio, la catarsi finale dell’Orestea eschilea. Oreste deve pagare: come? Non so, sembra dire il tragico di Salamina E così egli ironizza la stessa pur necessaria soluzione: la “machina”.
Ma quel che il genio greco non riuscì ad esprimere, affiora alla coscienza moderna attraverso il dramma dei Mannon di O’ Neill. Questi nuovi Atridi ripetono il dramma di allora (di sempre?), ma con una consapevolezza più lucida o più allucinante. La consapevolezza tesa che ha sgombrato l’orizzonte di noi moderni da ogni nube che nel passato lo deturpava sì, ma vitalizzandolo, per lasciarlo “crudelmente nitido nella linea fredda, impenetrabile che può dar esca alle audacie più sfrenate come all’angoscia più cupa” (F. Adami). Così l’architettura tormentata dei secoli precedenti dà luogo allo stile del ‘900, freddo, liscio, geometrico, stile che del nostro animo svuotato è l’espressione più rappresentativa.
I Mannon ripetono gli Atridi, ma in tono di psicanalisi. Al fondo del loro animo è l’odio che, incapace di formazione reattiva, esplode celebrando il trionfo dell’istinto di morte, ma questo (thànatos) è legato psicanaliticamente al fratello, all’eros, destinato però, per il fondo irrazionale che ci domina, alla sconfitta, all’annullamento. Così Agamennone-Mannon cerca l’elemosina dell’amore, ma viene respinto perché non sa suscitare che odio.
Clitennestra-Cristina si illude d’aver trovato Egisto-Brant e lo ama selvaggiamente, con frenesia sfrenata; ma Elettra-Lavinia, la vergine implacabile cui la madre ha rubato l’amore del padre prima e di Egisto-Brant poi, induce Oreste-Ori a sopprimere l’amante di Cristina e poi questa a suicidarsi. Alla vergine folle non resterebbe che sfogare il suo più tremendo soffocato paleoistinto, la lussuria, nell’incesto col fratello: ma si rifiuta perché nel fondo del suo cuore sonnecchia ancora, pur fra tanto odio, l’amore, la Scheria lontana, divenuta ora Shenandoah. E quando Oreste-Ori si uccide, lei si chiude all’amaro autosacrificio di tutta la vita, che non le varrò mai l’espiazione.
Nel mito moderno, dunque, il trionfo dell’irrazionale è completo. Oreste-Ori non può che uccidersi, Elettra-Lavinia si consumerà nella volontaria prigionia di tutta la vita: l’equilibrio non torna perché non può tornare. Non può tornare perché chi trionfa è sempre Dioniso; come ci dicono le Baccanti, di scena quest’anno.
Pentèo è la razionalità, l’ordine morale: di fronte ad esso stanno Dioniso e le Menadi, l’irrazionalità. Il Dio è stato offeso; bene: Egli allora sovvertirà il più insovvertibile degli istinti, l’amore materno, e Agàve sotto l’impero della pazzia dionisiaca sbranerà il figlio. Il trionfo di Dioniso non potrebbe essere più completo. Pentèo non ha accolto il Dio ed è stato punito, ma anche chi lo accoglie benevolmente, come il re Icaro, non può che approdare al porto della morte. Perché l’irrazionalità è nelle cose stesse e non è né giusta né ingiusta: è impulso cieco e distruttore, forza implacabile, maligna.
Si placa solo nel sereno cimitero di Scicli.
Lo spettatore che siede al teatro greco di Siracusa vede di là dalla scena, la ferrovia, cioè la macchina, cioè, intendo, la razionalità fatta materia; la macchina celebra il dominio dell’uomo, il trionfo del suo cervello. Dinanzi ad essa però, altare della ragione, sta il teatro, altare dell’irrazionalità, destinato a scardinarla dalle fondamenta e condurla a morte. Là nel sereno cimitero di Scicli.
Il coro dei vecchi di Colono, che lamentano sconsolati il fato del Nulla, canta: “non nascere è la sorte che vince tutte le altre; ma, venuti al mondo, tornare subito là di dove si è venuti, è, dopo quella, sorte migliore”.
Vivere per punire se stessi della colpa di essere nati.
***
La foto di copertina mostra il professor Saverio Avveduto con Jorge Luis Borges. In gallery, don Paolo Ruta apre l’ingresso laterale della chiesa della Consolazione al professor Saverio Avveduto, qui in compagnia della figlia. La foto è del luglio 2006. Quindi il professor Saverio Avveduto e Tullio De Mauro in Campidoglio a Roma. Di seguito, Leonardo Sciascia e Saverio Avveduto nel 1984 a Madrid. Infine, la copertina de La maledizione del vivere.
Un grazie al preside Antonino Lauretta per i preziosi materiali.
© Riproduzione riservata