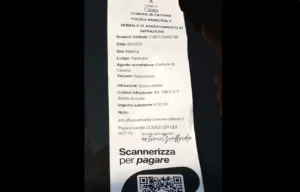Aveva superato due interventi per l'asportazione di un tumore
di Giuseppe Savà

C’è qualcosa di profetico nella morte, improvvisa, tragica e straziante di Sebastiano Tusa. La profezia che si materializza con la sua scomparsa è quella dell’uomo che sfida l’ignoto, che cerca il non conosciuto, e attraverso questa ricerca rischia la vita.
Sebastiano Tusa aveva superato due interventi chirurgici per tumore, al colon e ai polmoni, e dopo la chemioterapia -che gli aveva fatto perdere i capelli- si immergeva in mare, riprendendo il lavoro di ricerca archeologica subacquea.
Una sfida alla malattia e alle avversità, alla condanna che il destino sembra assegnare quando la diagnosi è infausta. Come se la consapevolezza di un tempo limitato avesse accelerato in lui un bisogno di conoscere, di cercare, di mettere in moto tutte le leve della curiosità scientifica.
Tusa è stato un Indiana Jones siciliano, pronto a rischiare pur di sapere, dedito al suo lavoro con amore invidiabile. Ha fatto ciò che gli piaceva, lo ha fatto con passione, trasporto, abnegazione, lasciando l’ospedale e i cicli di chemio, la broncopolmonite e i ricoveri, per tornare a indagare. In mare, dove si immergeva, e lungo i frastagliati sentieri dell’archeologia.
E’ morto – ci sia consentito- nella maniera più feroce e coerente possibile, per un uomo che del sapere aveva fatto una missione. Andando in Africa, a portare in un convegno mondiale Unesco la propria testimonianza. Che oggi brilla, insopprimibile.
© Riproduzione riservata